
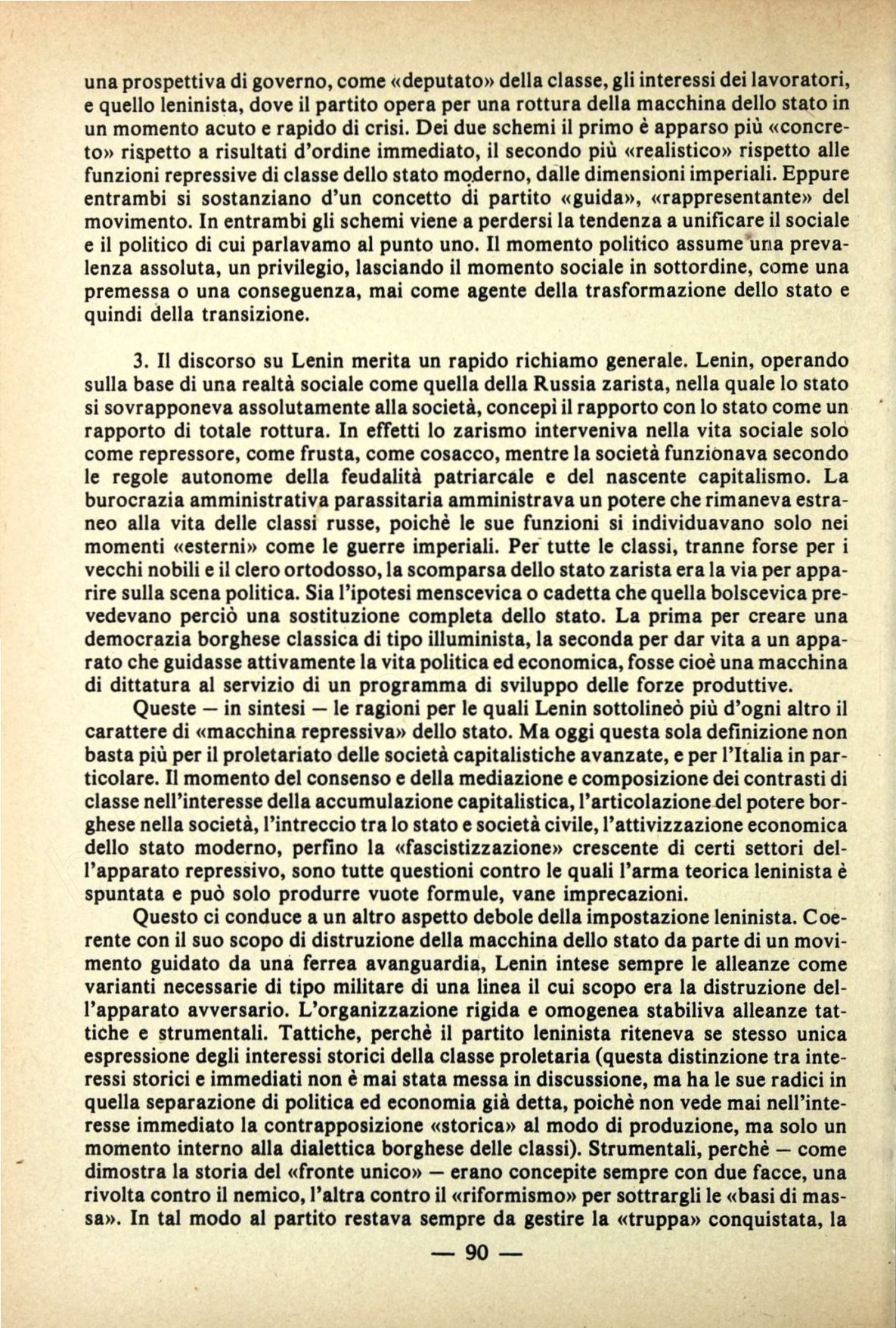
unaprospettiva di governo, come «deputato» della classe, gli interessi dei lavoratori,
equello leninista, dove il partito opera per una rottura dellamacchina dello stato in
unmomento acuto e rapido di crisi. Dei dueschemi il primo è apparso più «concre-
to» rispetto a risultati d'ordine immediato, il secondo più «realistico» rispetto alle
funzioni repressive di classedello statomoderno, dalle dimensioni imperiali. Eppure
entrambi si sostanziano d'un concetto di partito «guida», «rappresentante» del
movimento. In entrambi gli schemi viene a perdersi la tendenza a unificare il sociale
eil politico di cui parlavamo al punto uno. Il momento politico assume una preva-
lenza assoluta, un privilegio, lasciando il momento sociale in sottordine, come una
premessa o una conseguenza, mai come agente della trasformazione dello stato e
quindi della transizione.
3. Il discorso su Lenin merita un rapido richiamo generale. Lenin, operando
sullabase di una realtà sociale come quella della Russia zarista, nella quale lo stato
sisovrapponeva assolutamente alla società, concepì il rapporto con lo statocomeun
rapporto di totale rottura. In effetti lo zarismo interveniva nella vita sociale solo
comerepressore, come frusta, comecosacco, mentre la società funzionava secondo
le regole autonome della feudalità patriarcale e del nascente capitalismo. La
burocrazia amministrativa parassitaria amministrava unpotereche rimaneva estra-
neo alla vita delle classi russe, poiché le sue funzioni si individuavano solo nei
momenti «esterni» come le guerre imperiali. Per tutte le classi, tranne forse per i
vecchi nobili e il clero ortodosso, la scomparsadello stato zarista era la via per appa-
rire sullascena politica. Sia l'ipotesi menscevicao cadetta chequella bolscevica pre-
vedevano perciò una sostituzione completa dello stato. La prima per creare una
democraziaborghese classica di tipo illuminista, la secondaper dar vita a un appa-
rato cheguidasse attivamente la vita politicaedeconomica, fossecioèunamacchina
di dittatura al servizio di un programma di sviluppo delle forze produttive.
Queste—in sintesi—le ragioni per le quali Lenin sottolineò più d'ogni altro il
carattere di «macchina repressiva» dello stato. Ma oggi questa sola definizionenon
bastapiù per il proletariato delle società capitalistiche avanzate, eper l'Italia in par-
ticolare. Il momentodel consensoedellamediazioneecomposizionedei contrasti di
classenell'interesse della accumulazione capitalistica, l'articolazione del potere bor-
ghesenella società, l'intreccio tra lo statoesocietà civile, l'attivizzazione economica
dello stato moderno, perfino la «fascistizzazione» crescente di certi settori del-
l'apparato repressivo, sono tutte questioni contro le quali l'arma teorica leninista è
spuntata e può solo produrre vuote formule, vane imprecazioni.
Questo ci conduce a un altro aspettodebole della impostazione leninista. Coe-
rentecon il suoscopo di distruzione dellamacchina dello stato da parte di unmovi-
mento guidato da una ferrea avanguardia, Lenin intese sempre le alleanze come
varianti necessarie di tipo militare di una linea il cui scopo era la distruzione del-
l'apparato avversario. L'organizzazione rigida e omogenea stabiliva alleanze tat-
tiche e strumentali. Tattiche, perché il partito leninista riteneva se stesso unica
espressionedegli interessi storici della classe proletaria (questa distinzione tra inte-
ressi storici e immediati non èmai statamessa in discussione, ma ha lesue radici in
quella separazione di politica ed economia già detta, poiché nonvedemai nell'inte-
resse immediato la contrapposizione «storica» al modo di produzione, ma solo un
momento interno alla dialettica borghese delle classi). Strumentali, perché—come
dimostra la storia del «fronte unico»—erano concepite sempre con due facce, una
rivolta contro il nemico, l'altra contro il «riformismo» per sottrargli le «basi di mas-
sa». In tal modo al partito restava sempre da gestire la «truppa» conquistata, la
90
















