
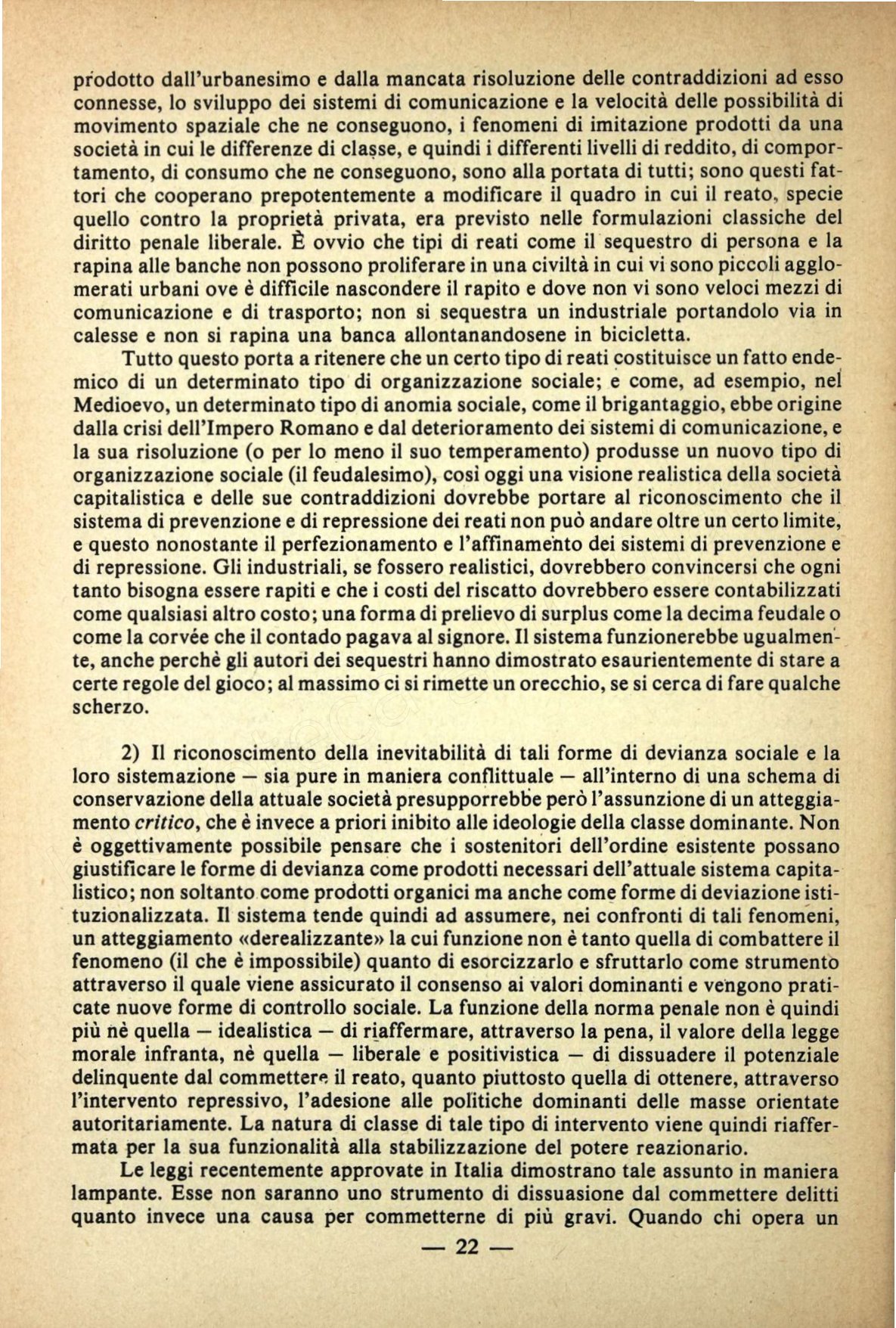
prodotto dall'urbanesimo e dalla mancata risoluzione delle contraddizioni ad esso
connesse, lo sviluppo dei sistemi di comunicazione e la velocità delle possibilità di
movimento spaziale che ne conseguono, i fenomeni di imitazione prodotti da una
società in cui le differenze di classe, e quindi i differenti livelli di reddito, di compor-
tamento, di consumo che ne conseguono, sono alla portata di tutti; sono questi fat-
tori che cooperano prepotentemente a modificare i l quadro in cui i l reato., specie
quello contro la proprietà privata, era previsto nelle formulazioni classiche del
diritto penale liberale. E ovvio che tipi di reati come i l sequestro di persona e la
rapina alle banche non possono proliferare in una civiltà in cui vi sono piccoli agglo-
merati urbani ove è difficile nascondere il rapito e dove non vi sono veloci mezzi di
comunicazione e di trasporto; non si sequestra un industriale portandolo via in
calesse e non si rapina una banca allontanandosene in bicicletta.
Tutto questo porta a ritenere che un certo tipo di reati costituisce un fatto ende-
mico di un determinato t ipo di organizzazione sociale; e come, ad esempio, nel
Medioevo, un determinato tipo di anomia sociale, come il brigantaggio, ebbe origine
dalla crisi dell'Impero Romano e dal deterioramento dei sistemi di comunicazione, e
la sua risoluzione (o per lo meno il suo temperamento) produsse un nuovo tipo di
organizzazione sociale (il feudalesimo), così oggi una visione realistica della società
capitalistica e delle sue contraddizioni dovrebbe portare al riconoscimento che i l
sistema di prevenzione e di repressione dei reati non può andare oltre un certo limite,
equesto nonostante il perfezionamento e l'affinamento dei sistemi di prevenzione e
di repressione. Gli industriali, se fossero realistici, dovrebbero convincersi che ogni
tanto bisogna essere rapiti e che i costi del riscatto dovrebbero essere contabilizzati
come qualsiasi altro costo; una forma di prelievo di surplus come la decima feudale o
come la corvée che il contado pagava al signore. Il sistema funzionerebbe ugualmen-
te, anche perchè gli autori dei sequestri hanno dimostrato esaurientemente di stare a
certe regole del gioco; al massimo ci si rimette un orecchio, se si cerca di fare qualche
scherzo.
2) I l riconoscimento della inevitabilità di tal i forme di devianza sociale e la
loro sistemazione—sia pure in maniera conflittuale — all'interno di una schema di
conservazione della attuale società presupporrebbe però l'assunzione di un atteggia-
mento
critico,
che è invece a priori inibito alle ideologie della classe dominante. Non
èoggettivamente possibile pensare che i sostenitori dell'ordine esistente possano
giustificare le forme di devianza come prodotti necessari dell'attuale sistema capita-
listico; non soltanto come prodotti organici ma anche come forme di deviazione isti-
tuzionalizzata. I l sistema tende quindi ad assumere, nei confronti di tali fenomeni,
un atteggiamento «derealizzante» la cui funzione non è tanto quella di combattere il
fenomeno (il che è impossibile) quanto di esorcizzarlo e sfruttarlo come strumento
attraverso il quale viene assicurato il consenso ai valori dominanti e vengono prati-
cate nuove forme di controllo sociale. La funzione della norma penale non è quindi
più nè quella— idealistica—di riaffermare, attraverso la pena, il valore della legge
morale infranta, nè quella — liberale e positivistica — di dissuadere i l potenziale
delinquente dal commettere il reato, quanto piuttosto quella di ottenere, attraverso
l'intervento repressivo, l'adesione alle politiche dominanti delle masse orientate
autoritariamente. La natura di classe di tale tipo di intervento viene quindi riaffer-
mata per la sua funzionalità alla stabilizzazione del potere reazionario.
Le leggi recentemente approvate in Italia dimostrano tale assunto in maniera
lampante. Esse non saranno uno strumento di dissuasione dal commettere delitti
quanto invece una causa per commetterne di più gravi. Quando chi opera un
22
















