
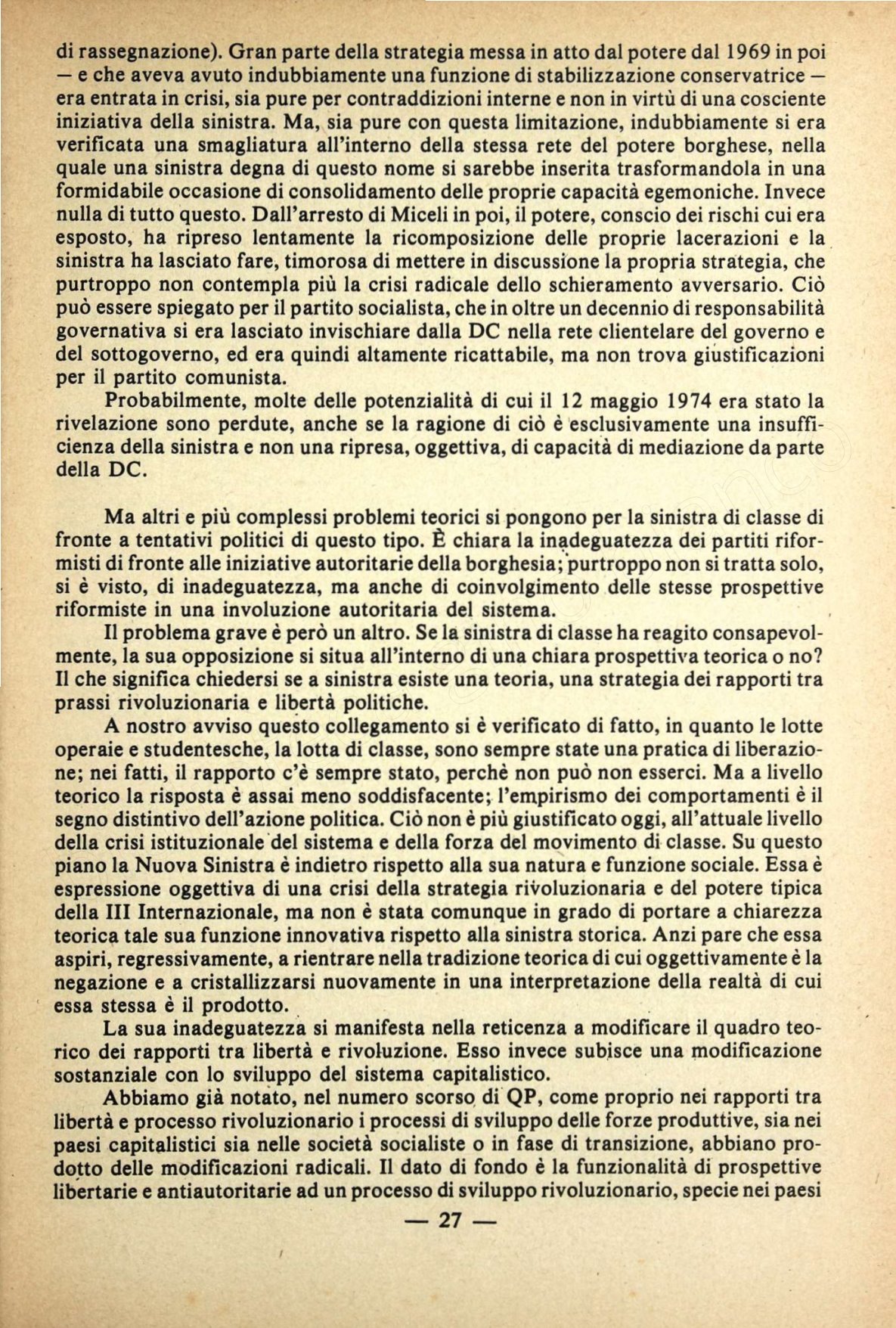
di rassegnazione). Gran parte della strategia messa in atto dal potere dal 1969 in poi
—e che aveva avuto indubbiamente una funzione di stabilizzazione conservatrice—
era entrata in crisi, sia pure per contraddizioni interne e non in virtù di una cosciente
iniziativa della sinistra. Ma, sia pure con questa limitazione, indubbiamente si era
verificata una smagliatura all'interno della stessa rete del potere borghese, nella
quale una sinistra degna di questo nome si sarebbe inserita trasformandola in una
formidabile occasione di consolidamento delle proprie capacità egemoniche. Invece
nulla di tutto questo. Dall'arresto di Miceli in poi, il potere, conscio dei rischi cui era
esposto, ha ripreso lentamente la ricomposizione delle proprie lacerazioni e la
sinistra ha lasciato fare, timorosa di mettere in discussione la propria strategia, che
purtroppo non contempla più la crisi radicale dello schieramento avversario. Ciò
può essere spiegato per il partito socialista, che in oltre un decennio di responsabilità
governativa si era lasciato invischiare dalla DC nella rete clientelare del governo e
del sottogoverno, ed era quindi altamente ricattabile, ma non trova giustificazioni
per i l partito comunista.
Probabilmente, molte delle potenzialità di cui il 12 maggio 1974 era stato la
rivelazione sono perdute, anche se la ragione di ciò è esclusivamente una insuffi-
cienza della sinistra e non una ripresa, oggettiva, di capacità di mediazione da parte
della DC.
Ma altri e più complessi problemi teorici si pongono per la sinistra di classe di
fronte a tentativi politici di questo tipo. È chiara la inadeguatezza dei partiti rifor-
misti di fronte alle iniziative autoritarie della borghesia; purtroppo non si tratta solo,
si è visto, di inadeguatezza, ma anche di coinvolgimento delle stesse prospettive
riformiste in una involuzione autoritaria del sistema.
Il
problema grave è però un altro. Se la sinistra di classe ha reagito consapevol-
mente, la sua opposizione si situa all'interno di una chiara prospettiva teorica o no?
Il che significa chiedersi se a sinistra esiste una teoria, una strategia dei rapporti tra
prassi rivoluzionaria e libertà politiche.
A nostro avviso questo collegamento si è verificato di fatto, in quanto le lotte
operaie e studentesche, la lotta di classe, sono sempre state una pratica di liberazio-
ne; nei fatti, il rapporto c'è sempre stato, perchè non può non esserci. Ma a livello
teorico la risposta è assai meno soddisfacente; l'empirismo dei comportamenti è il
segno distintivo dell'azione politica. Ciò non è più giustificato oggi, all'attuale livello
della crisi istituzionale del sistema e della forza del movimento di classe. Su questo
piano la Nuova Sinistra è indietro rispetto alla sua natura e funzione sociale. Essaè
espressione oggettiva di una crisi della strategia riVoluzionaria e del potere tipica
della
I I I
Internazionale, ma non è stata comunque in grado di portare a chiarezza
teorica tale sua funzione innovativa rispetto alla sinistra storica. Anzi pare che essa
aspiri, regressivamente, a rientrare nella tradizione teorica di cui oggettivamente è la
negazione e a cristallizzarsi nuovamente in una interpretazione della realtà di cui
essa stessa è i l prodotto.
La sua inadeguatezza si manifesta nella reticenza a modificare il quadro teo-
rico dei rapporti tra libertà e rivoluzione. Esso invece subisce una modificazione
sostanziale con lo sviluppo del sistema capitalistico.
Abbiamo già notato, nel numero scorso di
QP,
come proprio nei rapporti tra
libertà e processo rivoluzionario i processi di sviluppo delle forze produttive, sia nei
paesi capitalistici sia nelle società socialiste o in fase di transizione, abbiano pro-
dotto delle modificazioni radicali.
Il
dato di fondo è la funzionalità di prospettive
libertarie e antiautoritarie ad un processo di sviluppo rivoluzionario, specie nei paesi
27
















