
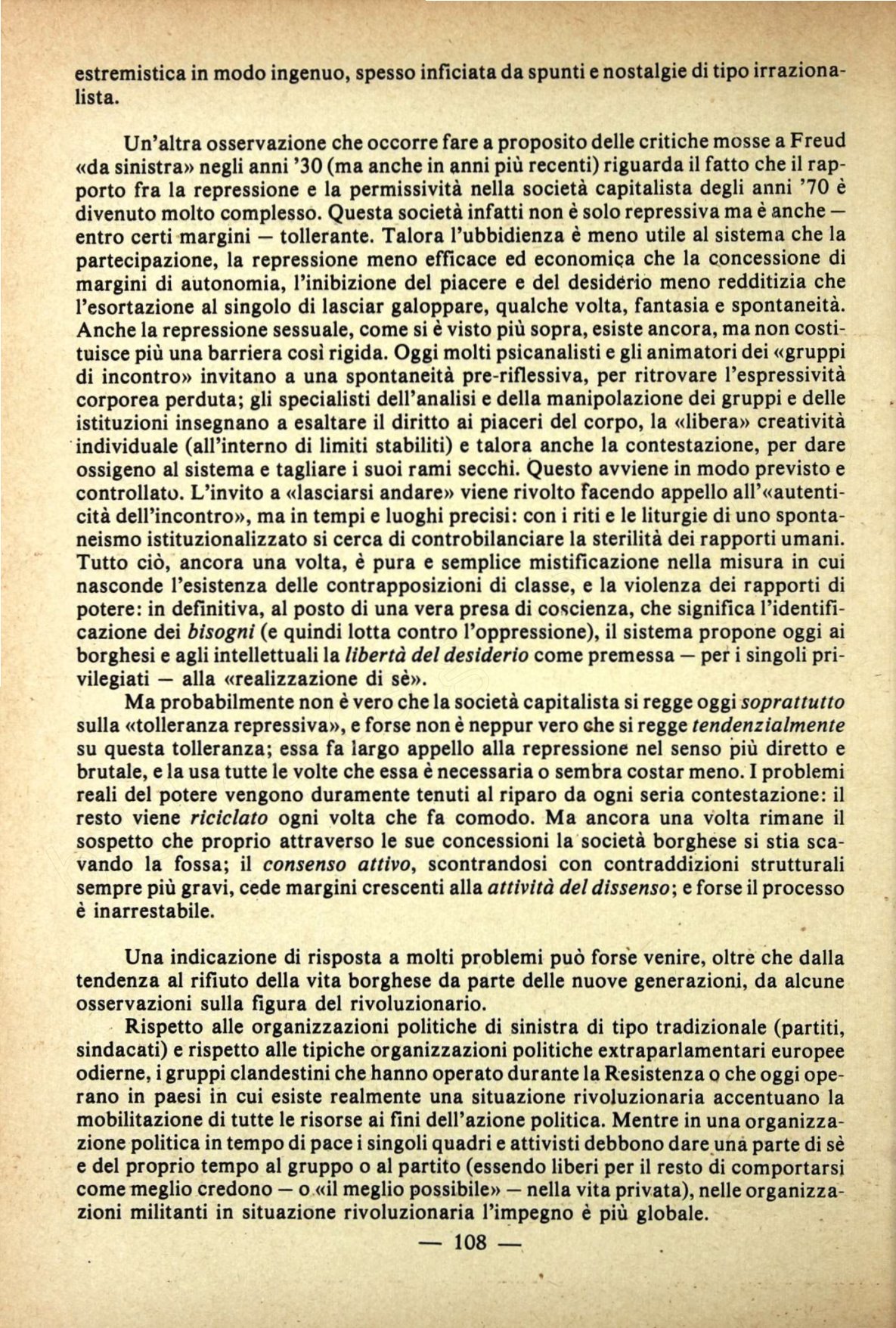
estremistica in modo ingenuo, spesso inficiata da spunti e nostalgie di tipo irraziona-
lista.
Un'altra osservazione che occorre fare a proposito delle critiche mosse a Freud
«da sinistra» negli anni '30 (ma anche in anni più recenti) riguarda il fatto che il rap-
porto fra la repressione e la permissività nella società capitalista degli anni '70 è
divenuto molto complesso. Questa società infatti non è solo repressiva ma è anche
entro certi margini — tollerante. Talora l'ubbidienza è meno utile al sistema che la
partecipazione, la repressione meno efficace ed economica che la concessione di
margini di autonomia, l'inibizione del piacere e del desiderio meno redditizia che
l'esortazione al singolo di lasciar galoppare, qualche volta, fantasia e spontaneità.
Anche la repressione sessuale, come si è visto più sopra, esiste ancora, ma non costi-
tuisce più una barriera così rigida. Oggi molti psicanalisti e gli animatori dei «gruppi
di incontro» invitano a una spontaneità pre-riflessiva, per ritrovare l'espressività
corporea perduta; gli specialisti dell'analisi e della manipolazione dei gruppi e delle
istituzioni insegnano a esaltare il diritto ai piaceri del corpo, la «libera» creatività
individuale (all'interno di l imiti stabiliti) e talora anche la contestazione, per dare
ossigeno al sistema e tagliare i suoi rami secchi. Questo avviene in modo previsto e
controllato. L' invito a «lasciarsi andare» viene rivolto facendo appello all'«autenti-
cità dell'incontro», ma in tempi e luoghi precisi: con i riti e le liturgie di uno sponta-
neismo istituzionalizzato si cerca di controbilanciare la sterilità dei rapporti umani.
Tutto ciò, ancora una volta, è pura e semplice mistificazione nella misura in cui
nasconde l'esistenza delle contrapposizioni di classe, e la violenza dei rapporti di
potere: in definitiva, al posto di una vera presa di coscienza, che significa l'identifi-
cazione dei
bisogni
(e quindi lotta contro l'oppressione), il sistema propone oggi ai
borghesi e agli intellettuali la
libertà del desiderio
come premessa—per i singoli pri-
vilegiati — alla «realizzazione di sé».
Ma probabilmente non è vero che la società capitalista si regge oggi
soprattutto
sulla «tolleranza repressiva», e forse non è neppur vero che si regge
tendenzialmente
su questa tolleranza; essa fa largo appello alla repressione nel senso Più diretto e
brutale, e la usa tutte le volte che essa è necessaria o sembra costar meno. I problemi
reali del potere vengono duramente tenuti al riparo da ogni seria contestazione: i l
resto viene
riciclato
ogni vol ta che fa comodo. Ma ancora una volta rimane i l
sospetto che proprio attraverso le sue concessioni la società borghese si stia sca-
vando l a fossa; i l
consenso attivo,
scontrandosi con contraddizioni struttural i
sempre più gravi, cede margini crescenti alla
attività del dissenso;
e forse il processo
è inarrestabile.
Una indicazione di risposta a molti problemi può forse venire, oltre che dalla
tendenza al rifiuto della vita borghese da parte delle nuove generazioni, da alcune
osservazioni sulla figura del rivoluzionario.
Rispetto alle organizzazioni politiche di sinistra di tipo tradizionale (partiti,
sindacati) e rispetto alle tipiche organizzazioni politiche extraparlamentari europee
odierne, i gruppi clandestini che hanno operato durante la Resistenza o che oggi ope-
rano in paesi in cui esiste realmente una situazione rivoluzionaria accentuano la
mobilitazione di tutte le risorse ai fini dell'azione politica. Mentre in una organizza-
zione politica in tempo di pace i singoli quadri e attivisti debbono dare una parte di sè
edel proprio tempo al gruppo o al partito (essendo liberi per il resto di comportarsi
come meglio credono—o «il meglio possibile»—nella vita privata), nelle organizza-
zioni militanti in situazione rivoluzionaria l'impegno è più globale.
108
















