
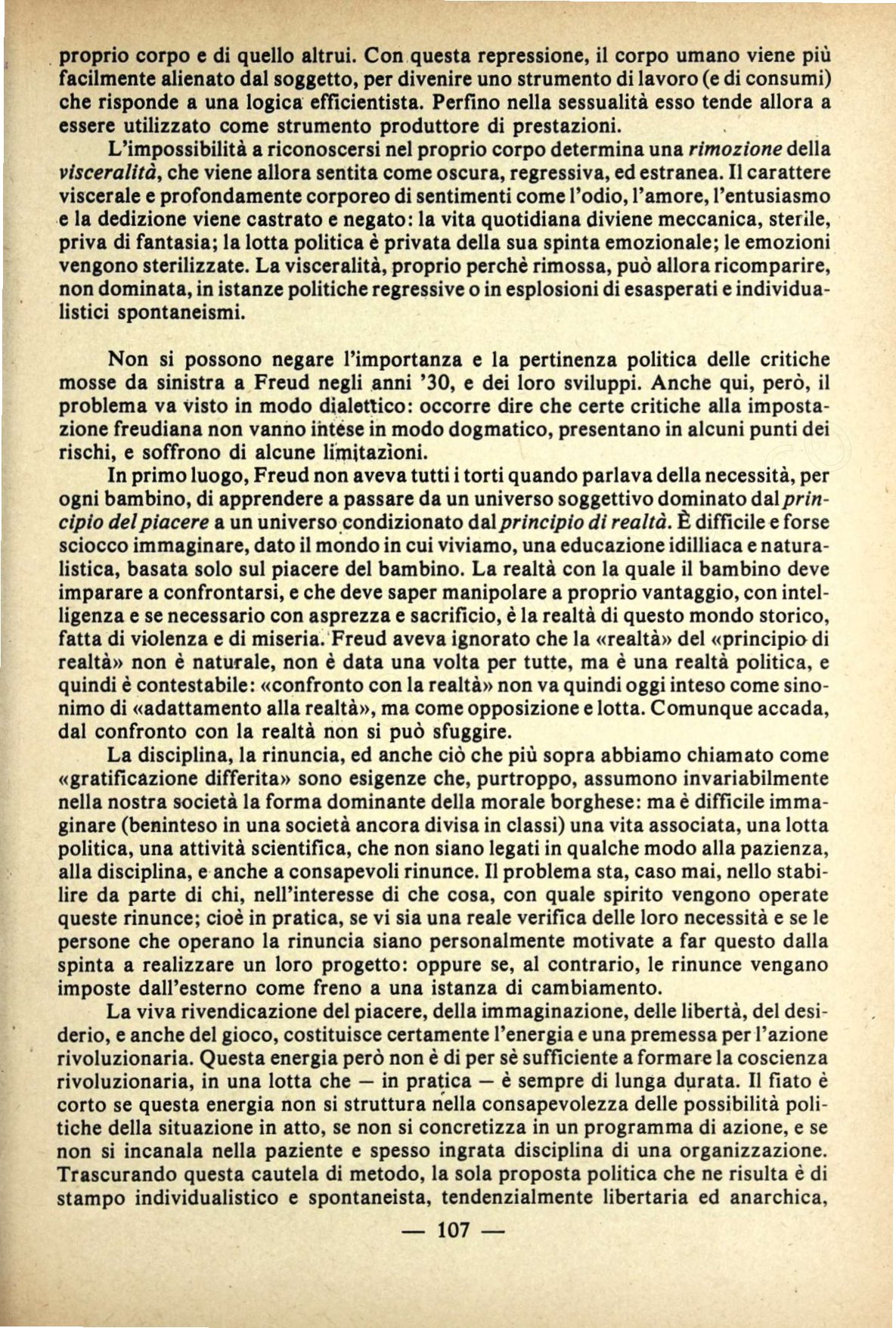
proprio corpo e di quello altrui. Con questa repressione, il corpo umano viene più
facilmente alienato dal soggetto, per divenire uno strumento di lavoro (e di consumi)
che risponde a una logica efficientista. Perfino nella sessualità esso tende allora a
essere utilizzato come strumento produttore di prestazioni.
L'impossibilità a riconoscersi nel proprio corpo determina una
rimozione
della
visceralità,
che viene allora sentita come oscura, regressiva, ed estranea. Il carattere
viscerale e profondamente corporeo di sentimenti come l'odio, l'amore, l'entusiasmo
e la dedizione viene castrato e negato: la vita quotidiana diviene meccanica, sterile,
priva di fantasia; la lotta politica è privata della sua spinta emozionale; le emozioni
vengono sterilizzate. La visceralità, proprio perchè rimossa, può allora ricomparire,
non dominata, in istanze politiche regressive o in esplosioni di esasperati e individua-
listici spontaneismi.
Non si possono negare l'importanza e la pertinenza politica delle critiche
mosse da sinistra a Freud negli anni '30, e dei loro sviluppi. Anche qui, però, il
problema va visto in modo dialettico: occorre dire che certe critiche alla imposta-
zione freudiana non vanno intese in modo dogmatico, presentano in alcuni punti dei
rischi, e soffrono di alcune limitazioni.
In primo luogo, Freud non aveva tutti i torti quando parlava della necessità, per
ogni bambino, di apprendere a passare da un universo soggettivo dominato dal
prin-
cipio del piacere
a un universo condizionato dal
principio di realtà.
È difficile e forse
sciocco immaginare, dato il mondo in cui viviamo, una educazione idilliaca e natura-
listica, basata solo sul piacere del bambino. La realtà con la quale il bambino deve
imparare a confrontarsi, e che deve saper manipolare a proprio vantaggio, con intel-
ligenza ese necessario con asprezza e sacrificio, è la realtà di questomondo storico,
fatta di violenza e di miseria. Freud aveva ignorato che la «realtà» del «principio di
realtà» non è naturale, non è data una volta per tutte, ma è una realtà politica, e
quindi è contestabile: «confronto con la realtà» non va quindi oggi inteso come sino-
nimo di «adattamento alla realtà», ma come opposizione e lotta. Comunque accada,
dal confronto con la realtà non si può sfuggire.
La disciplina, la rinuncia, ed anche ciò che più sopra abbiamo chiamato come
«gratificazione differita» sono esigenze che, purtroppo, assumono invariabilmente
nella nostra società la forma dominante della morale borghese: ma è difficile imma-
ginare (beninteso in una società ancora divisa in classi) una vita associata, una lotta
politica, una attività scientifica, che non siano legati in qualche modo alla pazienza,
alla disciplina, e anche a consapevoli rinunce. Il problema sta, caso mai, nello stabi-
lire da parte di chi, nell'interesse di che cosa, con quale spirito vengono operate
queste rinunce; cioè in pratica, se vi sia una reale verifica delle loro necessità e se le
persone che operano la rinuncia siano personalmente motivate a far questo dalla
spinta a realizzare un loro progetto: oppure se, al contrario, le rinunce vengano
imposte dall'esterno come freno a una istanza di cambiamento.
La viva rivendicazione del piacere, della immaginazione, delle libertà, del desi-
derio, e anche del gioco, costituisce certamente l'energia euna premessa per l'azione
rivoluzionaria. Questa energia però non è di per sè sufficiente a formare la coscienza
rivoluzionaria, in una lotta che— in pratica—è sempre di lunga durata. Il fiato è
corto se questa energia non si struttura nella consapevolezza delle possibilità poli-
tiche della situazione in atto, se non si concretizza in un programma di azione, e se
non si incanala nella paziente e spesso ingrata disciplina di una organizzazione.
Trascurando questa cautela di metodo, la sola proposta politica che ne risulta è di
stampo individualistico e spontaneista, tendenzialmente libertaria ed anarchica,
107
















