
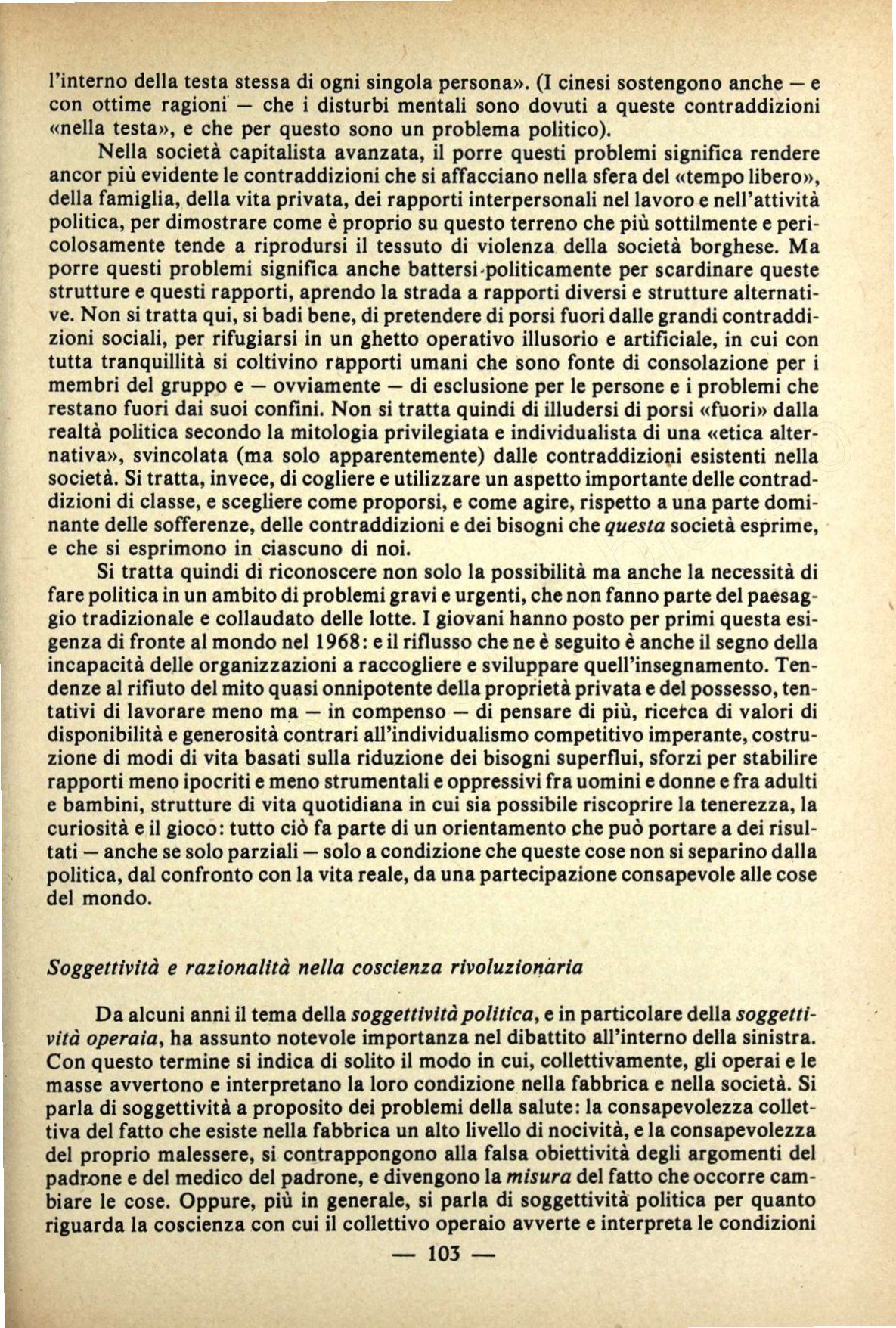
l'interno della testa stessa di ogni singola persona».
(I
cinesi sostengono anche—e
con ottime ragioni — che i disturbi mentali sono dovuti a queste contraddizioni
«nella testa», e che per questo sono un problema politico).
Nella società capitalista avanzata, i l porre questi problemi significa rendere
ancor più evidente le contraddizioni che si affacciano nella sfera del «tempo libero»,
della famiglia, della vita privata, dei rapporti interpersonali nel lavoro e nell'attività
politica, per dimostrare come è proprio su questo terreno che più sottilmente e peri-
colosamente tende a riprodursi i l tessuto di violenza della società borghese. Ma
porre questi problemi significa anche battersi spoliticamente per scardinare queste
strutture e questi rapporti, aprendo la strada a rapporti diversi e strutture alternati-
ve. Non si tratta qui, si badi bene, di pretendere di porsi fuori dalle grandi contraddi-
zioni sociali, per rifugiarsi in un ghetto operativo illusorio e artificiale, in cui con
tutta tranquillità si coltivino rapporti umani che sono fonte di consolazione per i
membri del gruppo e—ovviamente—di esclusione per le persone e i problemi che
restano fuori dai suoi confini. Non si tratta quindi di illudersi di porsi «fuori» dalla
realtà politica secondo la mitologia privilegiata e individualista di una «etica alter-
nativa», svincolata (ma solo apparentemente) dalle contraddizioni esistenti nella
società. Si tratta, invece, di cogliere e utilizzare un aspetto importante delle contrad-
dizioni di classe, e scegliere come proporsi, e come agire, rispetto a una parte domi-
nante delle sofferenze, delle contraddizioni e dei bisogni che
questa
società esprime,
eche si esprimono in ciascuno di noi.
Si tratta quindi di riconoscere non solo la possibilità ma anche la necessità di
fare politica in un ambito di problemi gravi e urgenti, che non fanno parte del paesag-
gio tradizionale e collaudato delle lotte. I giovani hanno posto per primi questa esi-
genza di fronte al mondo nel 1968: e il riflusso che neè seguito è anche il segno della
incapacità delle organizzazioni a raccogliere e sviluppare quell'insegnamento. Ten-
denze al rifiuto del mito quasi onnipotente della proprietà privata edel possesso, ten-
tativi di lavorare meno ma— in compenso—di pensare di più, ricerca di valori di
disponibilità e generosità contrari all'individualismo competitivo imperante, costru-
zione di modi di vita basati sulla riduzione dei bisogni superflui, sforzi per stabilire
rapporti meno ipocriti emeno strumentali e oppressivi fra uomini e donne e fra adulti
ebambini, strutture di vita quotidiana in cui sia possibile riscoprire la tenerezza, la
curiosità e il gioco: tutto ciò fa parte di un orientamento che può portare a dei risul-
tati—anche se solo parziali—solo a condizione che queste cose non si separino dalla
politica, dal confronto con la vita reale, da una partecipazione consapevole alle cose
del mondo.
Soggettività e razionalità nella coscienza rivoluzionaria
Da
alcuni anni il tema
della
soggettività politica,
e in particolare della
soggetti-
vità operaia,
ha assunto notevole importanza nel dibattito all'interno della sinistra.
Con questo termine si indica di solito il modo in cui, collettivamente, gli operai e le
masse avvertono e interpretano la loro condizione nella fabbrica e
nella
società. Si
parla di soggettività a proposito dei problemi della salute: la consapevolezza collet-
tiva del fatto che esiste nella fabbrica un alto livello di nocività, e la consapevolezza
del proprio malessere, si contrappongono alla falsa obiettività degli argomenti del
padrone e del medico del padrone, e divengono la
misura
del fatto che occorre cam-
biare le cose. Oppure, più in generale, si parla di soggettività politica per quanto
riguarda la coscienza con cui il collettivo operaio avverte e interpreta le condizioni
103
















