
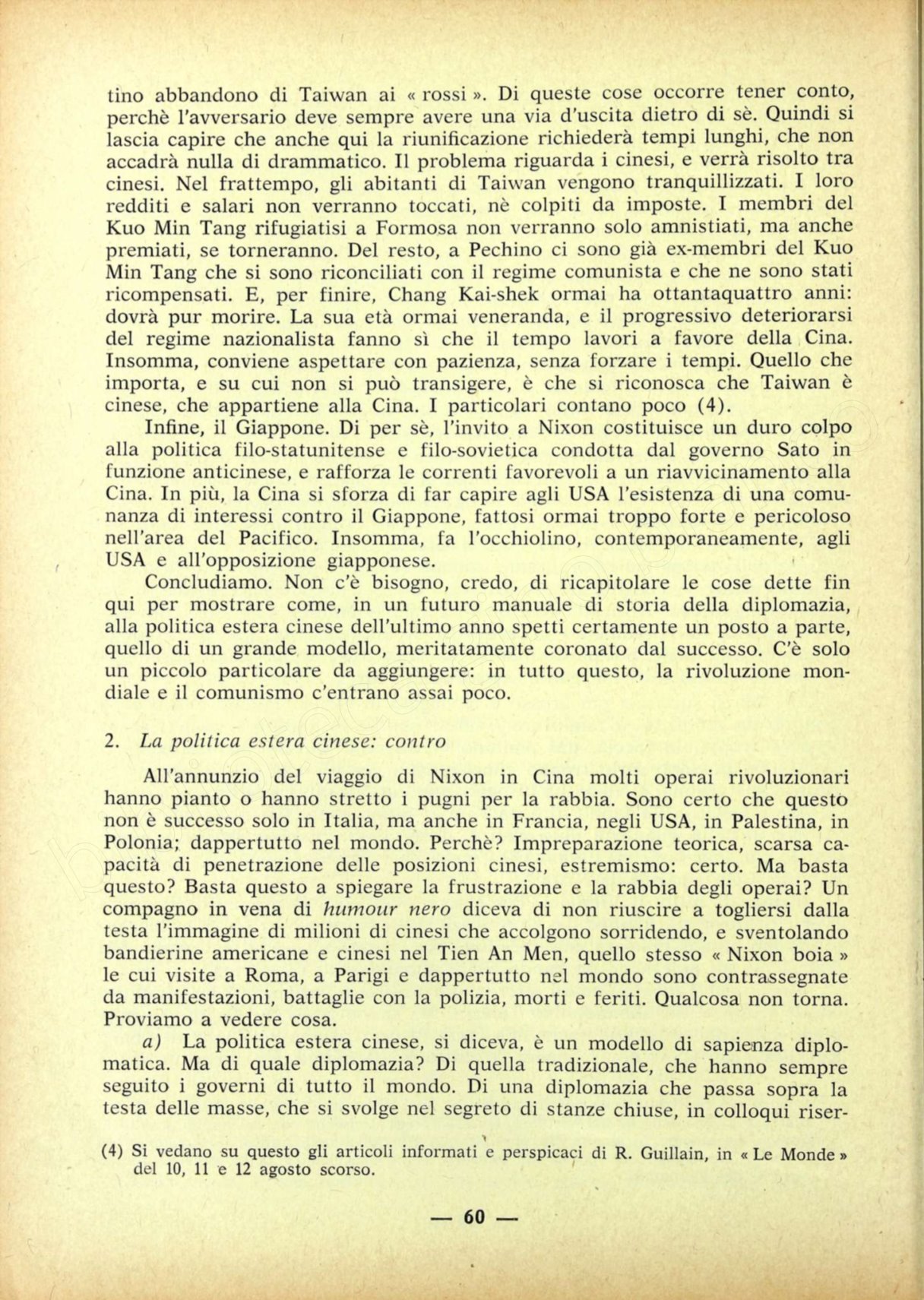
tino abbandono di Taiwan ai « rossi ». Di queste cose occorre tener conto,
perché l'avversario deve sempre avere una via d'uscita dietro di sé. Quindi si
lascia capire che anche qui la riunificazione richiederà tempi lunghi, che non
accadrà nulla di drammatico. I l problema riguarda i cinesi, e verrà risolto tra
cinesi. Nel frattempo, gli abitanti di Taiwan vengono tranquillizzati. I loro
redditi e salari non verranno toccati, nè colpiti da imposte. I membri del
Kuo Min Tang rifugiatisi a Formosa non verranno solo amnistiati, ma anche
premiati, se torneranno. Del resto, a Pechino ci sono già ex-membri del Kuo
Mmn Tang che si sono riconciliati con il regime comunista e che ne sono stati
ricompensati. E, per finire, Chang Kai-shek ormai ha ottantaquattro anni:
dovrà pur morire. La sua età ormai veneranda, e i l progressivo deteriorarsi
del regime nazionalista fanno sì che i l tempo lavori a favore della Cina.
Insomma, conviene aspettare con pazienza, senza forzare i tempi. Quello che
importa, e su cui non si può transigere, è che si riconosca che Taiwan è
cinese, che appartiene alla Cina. I particolari contano poco (4) .
Infine, i l Giappone. Di per sè, l'invito a Nixon costituisce un duro colpo
alla politica f i lo-statunitense e f i lo-sovietica condotta dal governo Sato i n
funzione anticinese, e rafforza le correnti favorevoli a un riavvicinamento alla
Cina. In più, la Cina si sforza di far capire agli USA l'esistenza di una comu-
nanza di interessi contro il Giappone, fattosi ormai troppo forte e pericoloso
nell'area del Pacifico. Insomma, f a l'occhiolino, contemporaneamente, agl i
USA e all'opposizione giapponese.
•
Concludiamo. Non c'è bisogno, credo, di ricapitolare l e cose dette f in
qui per mostrare come, i n un futuro manuale d i storia della diplomazia,
alla politica estera cinese dell'ultimo anno spetti certamente un posto a parte,
quello di un grande modello, meritatamente coronato dal successo. C'è solo
un piccolo particolare da aggiungere: i n tutto questo, l a rivoluzione mon-
diale e il comunismo c'entrano assai poco.
2.
L a politica estera cinese: contro
All'annunzio del viaggio d i Nixon i n Cina mol t i operai rivoluzionari
hanno pianto o hanno stretto i pugni per la rabbia. Sono certo che questo
non è successo solo in Italia, ma anche in Francia, negli USA, in Palestina, in
Polonia; dappertutto nel mondo. Perchè? Impreparazione teorica, scarsa ca-
pacità di penetrazione delle posizioni cinesi, estremismo: certo. Ma basta
questo? Basta questo a spiegare la frustrazione e la rabbia degli operai? Un
compagno in vena di
humour nero
diceva di non riuscire a togliersi dalla
testa l'immagine di milioni di cinesi che accolgono sorridendo, e sventolando
bandierine americane e cinesi nel Tien An Men, quello stesso « Nixon boia »
le cui visite a Roma, a Parigi e dappertutto nel mondo sono contrassegnate
da manifestazioni, battaglie con la polizia, morti e feriti. Qualcosa non torna.
Proviamo a vedere cosa.
a)
L a politica estera cinese, si diceva, è un modello di sapienza diplo-
matica. Ma di quale diplomazia? Di quella tradizionale, che hanno sempre
seguito i governi di tutto i l mondo. Di una diplomazia che passa sopra la
testa delle masse, che si svolge nel segreto di stanze chiuse, in colloqui riser-
(4) Si vedano su questo gli articoli informati e perspicaci di R. Guillain, in « Le Monde »
del 10, 11 e 12 agosto scorso.
•
60
















