
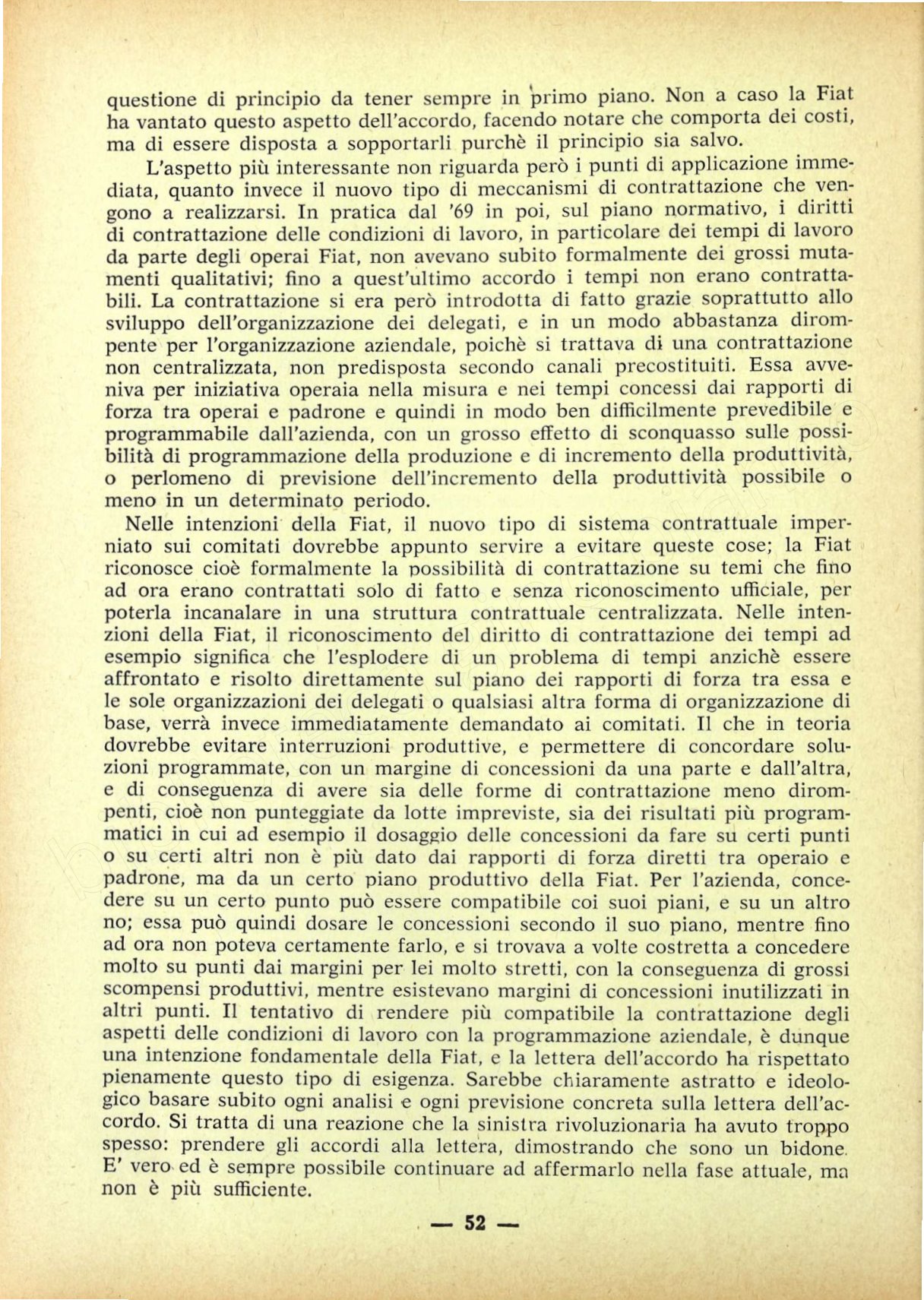
questione di principio da tener sempre in 'primo piano. Non a caso la Fiat
ha vantato questo aspetto dell'accordo, facendo notare che comporta dei costi,
ma di essere disposta a sopportarli purchè i l principio sia salvo.
L'aspetto più interessante non riguarda però i punti di applicazione imme-
diata, quanto invece i l nuovo tipo di meccanismi di contrattazione che ven-
gono a realizzarsi. I n pratica dal '69 in poi, sul piano n,ormativo, i diritti
di contrattazione delle condizioni di lavoro, in particolare dei tempi di lavoro
da parte degli operai Fiat, non avevano subito formalmente dei grossi muta-
menti qualitativi; fino a quest'ultimo accordo i tempi non erano contratta-
bili. La contrattazione si era però introdotta di fatto grazie soprattutto allo
sviluppo dell'organizzazione dei delegati, e in un modo abbastanza dirom-
pente per l'organizzazione aziendale, poichè si trattava di una contrattazione
non centralizzata, non predisposta secondo canali precostituiti. Essa avve-
niva per iniziativa operaia nella misura e nei tempi concessi dai rapporti di
forza tra operai e padrone e quindi in modo ben difficilmente prevedibile e
programmabile dall'azienda, con un grosso effetto di sconquasso sulle possi-
bilità di programmazione della produzione e di incremento della produttività,
o perlomeno d i previsione dell'incremento della produttività possibile o
meno in un determinato periodo.
Nelle intenzioni della Fiat, i l nuovo tipo di sistema contrattuale imper-
niato sui comitati dovrebbe appunto servire a evitare queste cose; l a Fiat
riconosce cioè formalmente la possibilità di contrattazione su temi che fino
ad ora erano contrattati solo di fatto e senza riconoscimento ufficiale, per
poterla incanalare in una struttura contrattuale centralizzata. Nelle inten-
zioni della Fiat, i l riconoscimento del diritto di contrattazione dei tempi ad
esempio significa che l'esplodere di un problema di tempi anzichè essere
affrontato e risolto direttamente sul piano dei rapporti di forza tra essa e
le sole organizzazioni dei delegati o qualsiasi altra forma di organizzazione di
base, verrà invece immediatamente demandato ai comitati. I l che in teoria
dovrebbe evitare interruzioni produttive, e permettere di concordare solu-
zioni programmate, con un margine di concessioni da una parte e dall'altra,
e di conseguenza di avere sia delle forme di contrattazione meno dirom-
penti, cioè non punteggiate da lotte impreviste, sia dei risultati più program-
matici in cui ad esempio il dosaggio delle concessioni da fare su certi punti
o su certi altri non è più dato dai rapporti di forza diretti tra operaio e
padrone, ma da un certo piano produttivo della Fiat. Per l'azienda, conce-
dere su un certo punto può essere compatibile coi suoi piani, e su un altro
no; essa può quindi dosare le concessioni secondo i l suo piano, mentre fino
ad ora non poteva certamente farlo, e si trovava a volte costretta a concedere
molto su punti dai margini per lei molto stretti, con la conseguenza di grossi
scompensi produttivi, mentre esistevano margini di concessioni inutilizzati in
altri punti. I l tentativo di rendere più compatibile la contrattazione degli
aspetti delle condizioni di lavoro con la programmazione aziendale, è dunque
una intenzione fondamentale della Fiat, e la lettera dell'accordo ha rispettato
pienamente questo tipo di esigenza. Sarebbe chiaramente astratto e ideolo-
gico basare subito ogni analisi e ogni previsione concreta sulla lettera dell'ac-
cordo. Si tratta di una reazione che la sinistra rivoluzionaria ha avuto troppo
spesso: prendere gli accordi alla lette'ra, dimostrando che sono un bidone.
E' vera ed è sempre possibile continuare ad affermarlo nella fase attuale, ma
non è più sufficiente.
. 5 2 e
















