
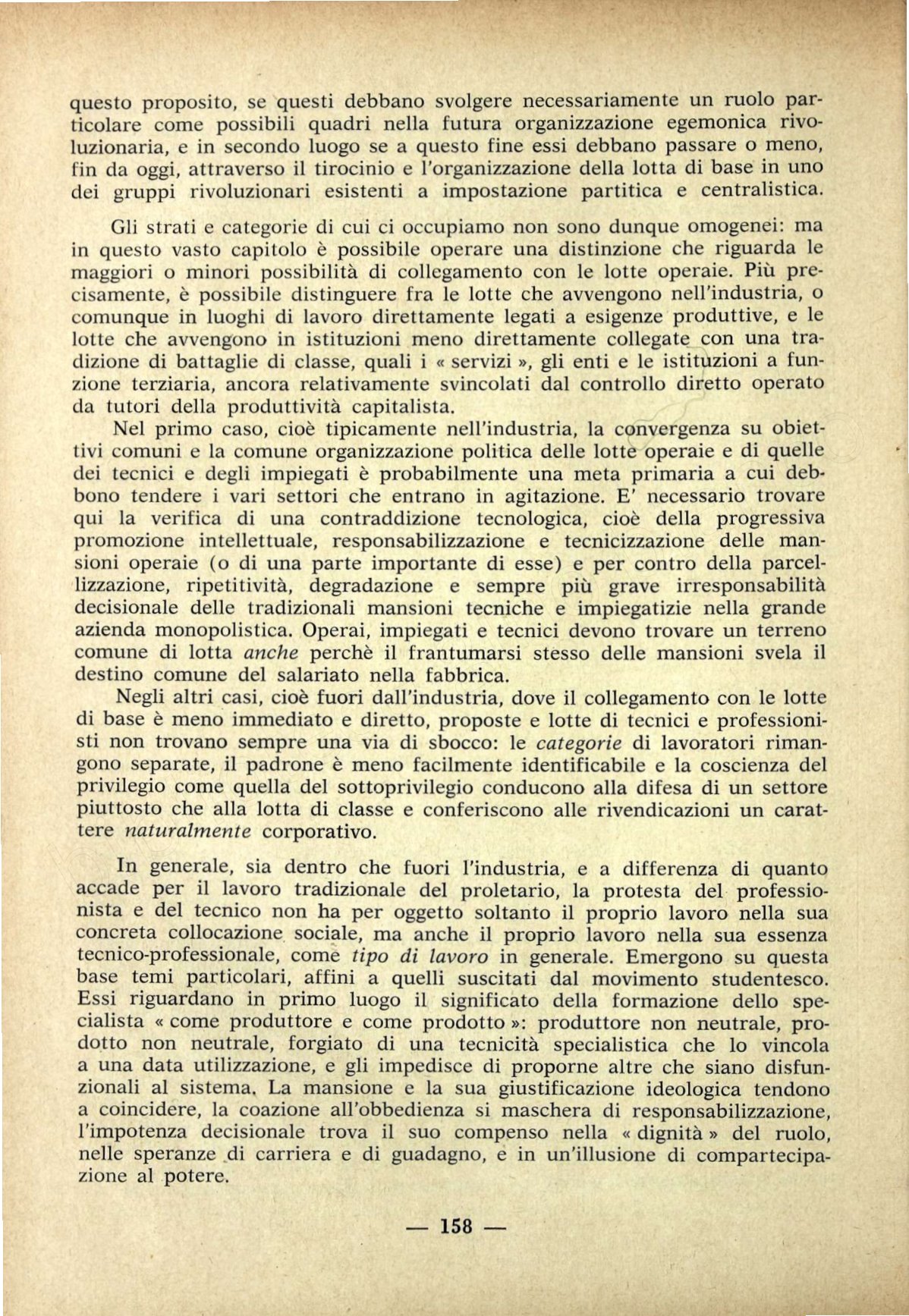
questo proposito, se questi debbano svolgere necessariamente un ruolo par-
ticolare come possibi l i quadr i nel la futura organizzazione egemonica r ivo-
luzionaria, e in secondo luogo se a questo fine essi debbano passare o meno,
fin da oggi, attraverso i l tirocinio e l'organizzazione della lotta di base in uno
dei gruppi rivoluzionari esistenti a impostazione par t i t ica e centralistica.
Gli strat i e categorie di cui ci occupiamo non sono dunque omogenei: ma
in questo vasto capitolo è possibile operare una distinzione che riguarda le
maggiori o minor i possibilità d i collegamento con le lot te operaie. Più pre-
cisamente, è possibile distinguere f ra le lotte che avvengono nell'industria, o
comunque i n luoghi d i lavoro direttamente legati a esigenze produttive, e le
lotte che avvengono i n istituzioni meno direttamente collegate con una tra-
dizione di battaglie di classe, qual i i « servizi », gl i enti e le istituzioni a fun-
zione terziaria, ancora relativamente svincolati dal control lo di ret to operato
da tutor i del la produt t ivi tà capitalista.
Nel pr imo caso, cioè tipicamente nell'industria, la convergenza su obiet-
tivi comuni e la comune organizzazione politica delle lotte operaie e di quelle
dei tecnici e degli impiegati è probabilmente una meta pr imar ia a cui deb-
bono tendere i var i settori che entrano i n agitazione. E ' necessario trovare
qui l a ver i f ica d i una contraddizione tecnologica, c ioè del la progressiva
promozione intel lettuale, responsabilizzazione e tecnicizzazione del le man-
sioni operaie ( o d i una parte importante d i esse) e per contro della parcel-
lizzazione, r ipet i t ivi tà, degradazione e sempre p i ù grave irresponsabi l i tà
decisionale del le tradizional i mansioni tecniche e impiegatizie nel la grande
azienda monopolistica. Operai, impiegati e tecnici devono trovare un terreno
comune d i lot ta
anche
perchè i l frantumarsi stesso del le mansioni svela i l
destino comune del salariato nel la fabbrica.
Negli al t r i casi, cioè fuor i dall'industria, dove i l collegamento con le lotte
di base è meno immediato e diretto, proposte e lotte di tecnici e professioni-
sti non trovano sempre una via d i sbocco: l e
categorie
d i lavoratori riman-
gono separate, i l padrone è meno facilmente identificabile e la coscienza del
privilegio come quella del sottoprivilegio conducono alla difesa di un settore
piuttosto che al la lot ta d i classe e conferiscono alle rivendicazioni un carat-
tere
naturalmente
corporativo.
In generale, sia dent ro che f uor i l ' industria, e a differenza d i quanto
accade pe r i l lavoro tradizionale de l proletario, l a protesta de l professio-
nista e del tecnico non ha per oggetto soltanto i l propr io lavoro nel la sua
concreta collocazione sociale, ma anche i l propr io lavoro nel la sua essenza
tecnico-professionale, come
t ipo d i lavoro
i n generale. Emergono su questa
base t emi part icolari , af f i n i a quel l i suscitati da l movimento studentesco.
Essi riguardano i n p r imo luogo i l significato del la formazione del lo spe-
cialista « come produttore e come prodotto »: produt tore non neutrale, pro-
dotto non neutrale, forgiato d i una tecnici tà specialistica che l o vincola
a una data utilizzazione, e gl i impedisce d i proporne al tre che siano disfun-
zionali a l sistema. La mansione e l a sua giustificazione ideologica tendono
a coincidere, la coazione all'obbedienza si maschera d i responsabilizzazione,
l'impotenza decisionale t rova i l suo compenso nel la «digni tà » de l ruolo,
nelle speranze _di carriera e d i guadagno, e i n un' illusione d i compartecipa-
zione al potere.
158
















