
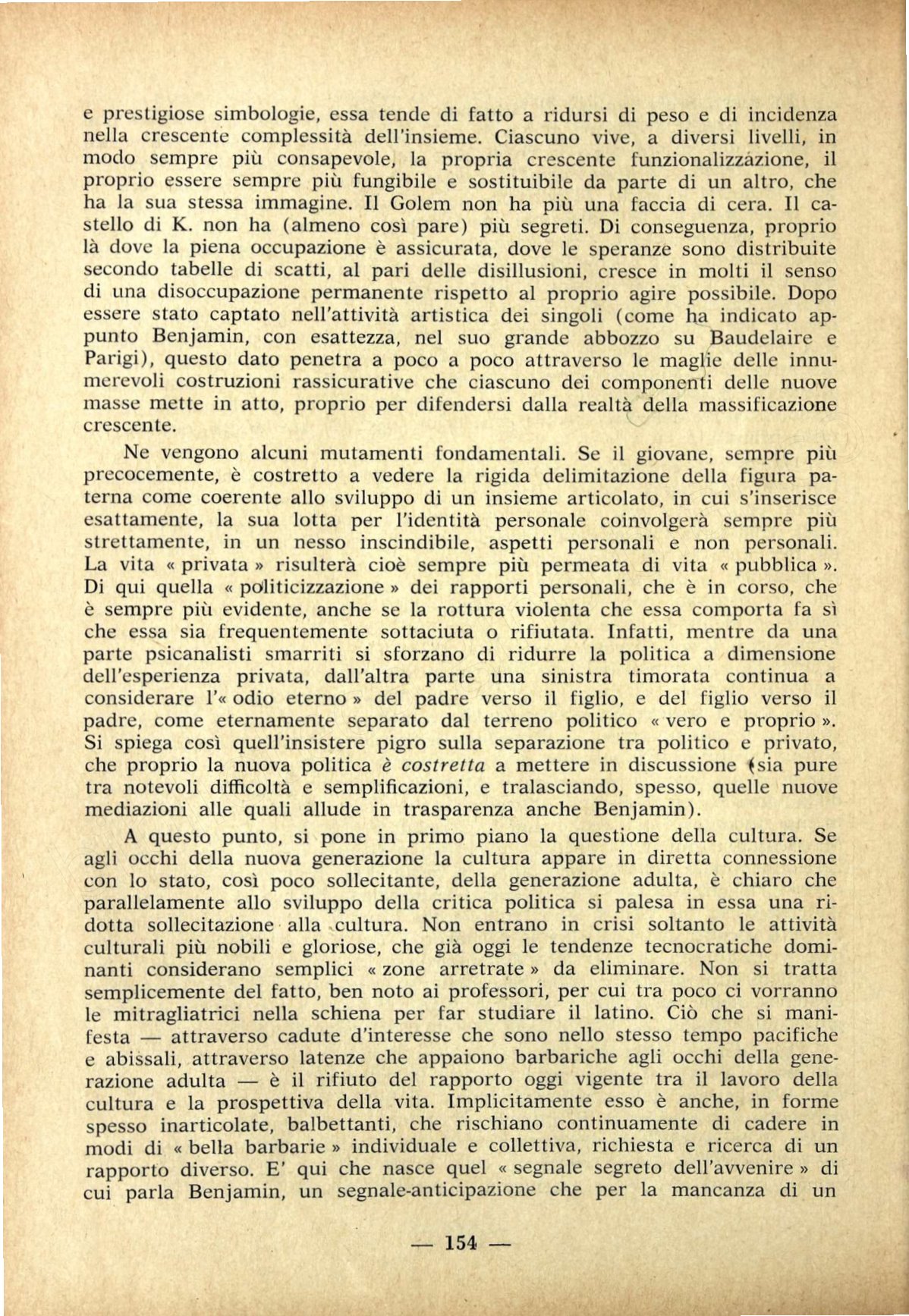
e prestigiose simbologie, essa tende d i fat to a r idursi d i peso e d i incidenza
nella crescentè complessità dell'insieme. Ciascuno vive, a diversi l ivel l i , i n
modo sempre p i ù consapevole, l a propr ia crescente funzionalizzàzione, i l
proprio essere sempre p i ù fungibi le e sostituibile da parte d i un al tro, che
ha l a sua stessa immagine. I l Golem non ha p i ù una faccia d i cera. I l ca-
stello d i K. non ha (almeno così pare) p i ù segreti. Di conseguenza, propr io
là dove la piena occupazione è assicurata, dove le speranze sono distr ibui te
secondo tabelle d i scatti, a l par i del le disillusioni, cresce i n mo l t i i l senso
di una disoccupazione permanente rispetto a l propr io agire possibile. Dopo
essere stato captato nel l 'att ivi tà art ist ica dei singol i (come ha indicato ap-
punto Benjamin, con esattezza, ne l suo grande abbozzo s u Baudelaire e
Parigi), questo dato penetra a poco a poco attraverso le ma g e del le innu-
merevoli costruzioni rassicurative che ciascuno dei component del le nuove
masse mette i n atto, propr io per difendersi dal la realtà del la massificazione
crescente.
Ne vengono alcuni mutament i fondamentali. Se i l giovane, sempre p i ù
precocemente, è costretto a vedere l a r igida delimitazione del la f igura pa-
terna come coerente al lo sviluppo di un insieme articolato, i n cui s'inserisce
esattamente, l a sua l o t t a pe r l ' ident i tà personale coinvolgerà sempre p i ù
strettamente, i n u n nesso inscindibi le, aspet t i personal i e non personal i.
La vi ta « privata » risul terà cioè sempre p i ù permeata d i v i ta «pubbl ica ».
Di qu i quella « poiliticizzazione » dei rappor t i personali, che è i n corso, che
è sempre più evidente, anche se la rot tura violenta che essa comporta fa sì
che essa sia frequentemente sottaciuta o r i f iutata. I n f a t t i , mentre da una
parte psicanalisti smar r i t i s i sforzano d i r i dur re l a pol i t ica a dimensione
dell'esperienza pr ivata, dal l 'al t ra par t e una sinist ra t imorata cont inua a
considerare l '« odio eterno » del padre verso i l f igl io, e del f i g l i o verso i l
padre, come eternamente separato dal terreno pol i t ico « vero e propr io ».
Si spiega così quell'insistere pigro sul la separazione t r a pol i t ico e pr ivato,
che proprio la nuova pol itica è
costretta
a mettere i n discussione l s i a pure
tra notevoli difficoltà e semplificazioni, e tralasciando, spesso, quelle nuove
mediazioni al le qual i al lude i n trasparenza anche Benjamin).
A questo punto, s i pone i n pr imo piano l a questione del la cul tura. Se
agli occhi del la nuova generazione l a cul tura appare i n di ret ta connessione
con l o stato, così poco sollecitante, del la generazione adulta, è chiaro che
parallelamente al lo sviluppo del la cr i t ica pol i t ica s i palesa i n essa una r i -
dotta sollecitazione• alla ,cultura. Non entrano i n cr i s i sol tanto l e at t i v i tà
culturali p i ù nobi l i e gloriose, che già oggi le tendenze tecnocratiche domi-
nanti considerano sempl ici « zone arret rate » da el iminare. Non s i t r a t t a
semplicemente del fatto, ben noto ai professori, per cui t ra poco ci vorranno
•
le mi t ragl iat r ici nel la schiena per f a r studiare i l lat ino. Ciò che s i mani -
festa — attraverso cadute d'interesse che sono nel lo stesso tempo pacifiche
e abissali, attraverso latenze che appaiono barbariche agl i occhi del la gene-
razione adul ta — è i l r i f i uto de l rapporto oggi vigente t r a i l lavoro del la
cultura e l a prospettiva del la vi ta. Impl ici tamente esso è anche, i n forme
spesso inarticolate, balbettanti, che rischiano continuamente d i cadere i n
modi d i « bella barbarie» individuale e collettiva, richiesta e ricerca d i un
rapporto diverso. E ' qu i che nasce quel « segnale segreto dell'avvenire » d i
cui par la Benjamin, u n segnale-anticipazione che pe r l a mancanza d i u n
















