
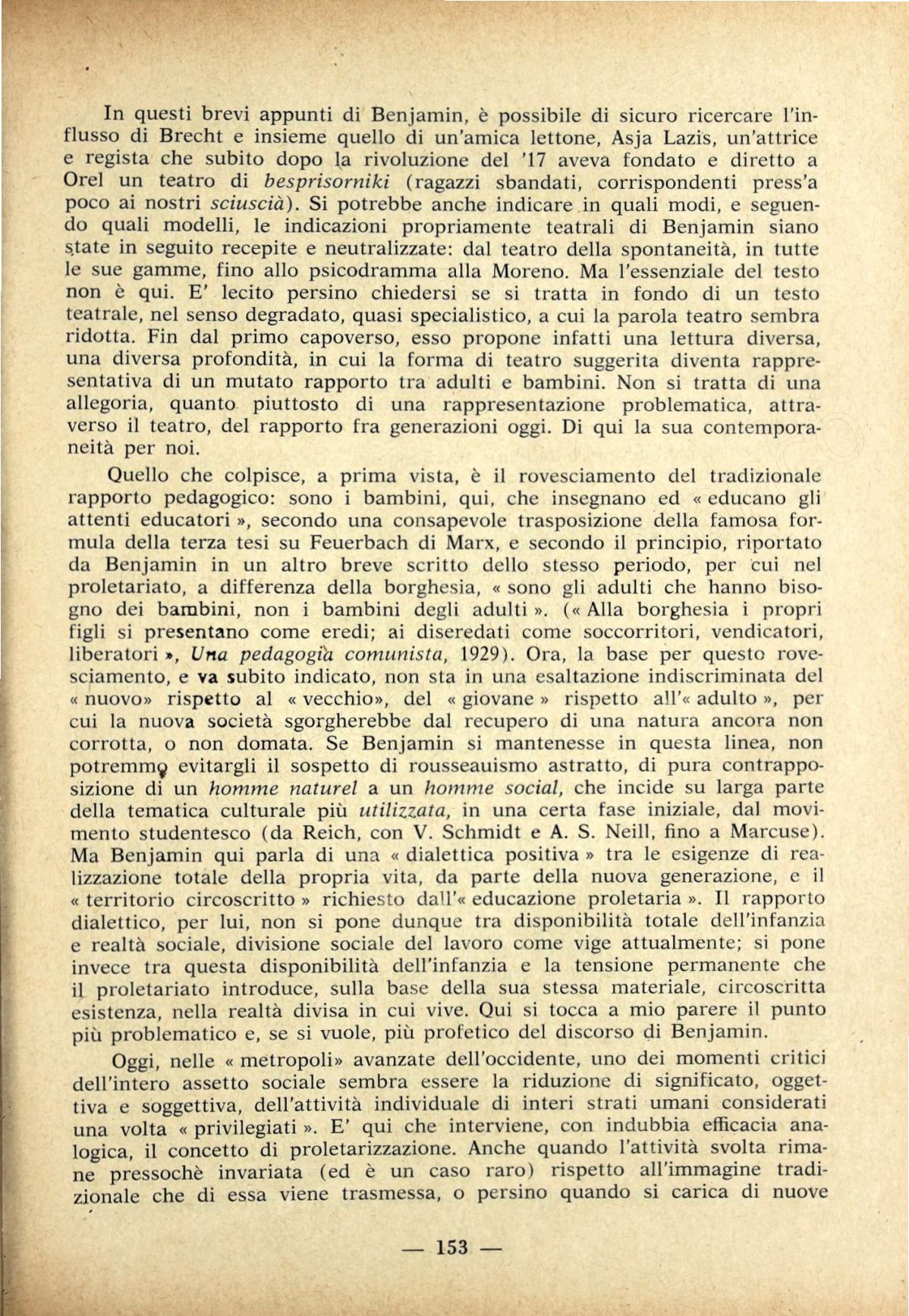
In questi brevi appunti di Benjamin, è possibile di sicuro ricercare l'in-
flusso di Brecht e insieme quello di un'amica lettone, Asja Lazis, un'attrice
e regista che subito dopo l a rivoluzione del '17 aveva fondato e diretto a
Orel un teatro d i
besprisorniki
(ragazzi sbandati, corrispondenti press'a
poco ai nostri
sciuscià).
Si potrebbe anche indicare in quali modi, e seguen-
do quali modelli, l e indicazioni propriamente teatrali d i Benjamin siano
satate in seguito recepite e neutralizzate: dal teatro della spontaneità, in tutte
le sue gamme, fino allo psicodramma alla Moreno. Ma l'essenziale del testo
non è qui. E ' lecito persino chiedersi se si tratta i n fondo d i un testo
teatrale, nel senso degradato, quasi specialistico, a cui la parola teatro sembra
ridotta. Fin dal primo capoverso, esso propone infatti una lettura diversa,
una diversa profondità, in cui la forma di teatro suggerita diventa rappre-
sentativa di un mutato rapporto tra adulti e bambini. Non si tratta di una
allegoria, quanto piuttosto d i una rappresentazione problematica, at tra-
verso i l teatro, del rapporto fra generazioni oggi. Di qui la sua contempora-
neità per noi.
Quello che colpisce, a prima vista, è i l rovesciamento del tradizionale
rapporto pedagogico: sono i bambini, qui, che insegnano ed «educano gli
•
attenti educatori », secondo una consapevole trasposizione della famosa for-
mula della terza tesi su Feuerbach di Marx, e secondo i l principio, riportato
da Benjamin i n un altro breve scritto dello stesso periodo, per *cui nel
proletariato, a differenza della borghesia, « sono gli adulti che hanno biso-
gno dei bambini, non i bambini degli adulti ». ( « Alla borghesia i propri
figli si presentano come eredi; a i diseredati come soccorritori, vendicatori,
liberatori »,
Una pedagogià comunista,
1929). Ora, la base per questo rove-
sc!amento, e
va
subito indicato, non sta in una esaltazione indiscriminata del
cnuovo» rispetto a l «vecchio», del « giovane » rispetto all'« adulto », per
cui l a nuova società sgorgherebbe dal recupero di una natura ancora non
corrotta, o non domata. Se Benjamin si mantenesse i n questa linea, non
potremm9 evitargli i l sospetto di rousseauismo astratto, di pura contrappo-
sizione di un
homme naturel
a un
homme social,
che incide su larga parte
della tematica culturale più
utilizzata,
in una certa fase iniziale, dal movi-
mento studentesco (da Reich, con V. Schmidt e A. S. Neill, fino a Marcuse).
Ma Benjamin qui parla di una « dialettica positiva » tra le esigenze di rea-
lizzazione totale della propria vita, da parte della nuova generazione, e i l
«territorio circoscritto » richiesto dall'« educazione proletaria ». I l rapporto
dialettico, per lui, non si pone dunque t ra disponibilità totale dell'infanzia
e realtà sociale, divisione sociale del lavoro come vige attualmente; si pone
invece t ra questa disponibilità dell'infanzia e l a tensione permanente che
a proletariato introduce, sulla base della sua stessa materiale, circoscritta
esistenza, nella realtà divisa in cui vive. Qui si tocca a mio parere i l punto
più problematico e, se si vuole, più profetico del discorso di Benjamin.
Oggi, nelle «metropoli» avanzate dell'occidente, uno dei momenti critici
dell'intero assetto sociale sembra essere l a riduzione d i significato, ogget-
tiva e soggettiva, dell'attività individuale d i interi strati umani considerati
una volta « privilegiati ». E ' qui che interviene, con indubbia efficacia ana-
logica, i l concetto di proletarizzazione. Anche quando l'attività svolta rima-
ne pressochè invariata ( ed è un caso raro) rispetto all'immagine tradi-
zionale che d i essa viene trasmessa, o persino quando si carica di nuove
153
















