
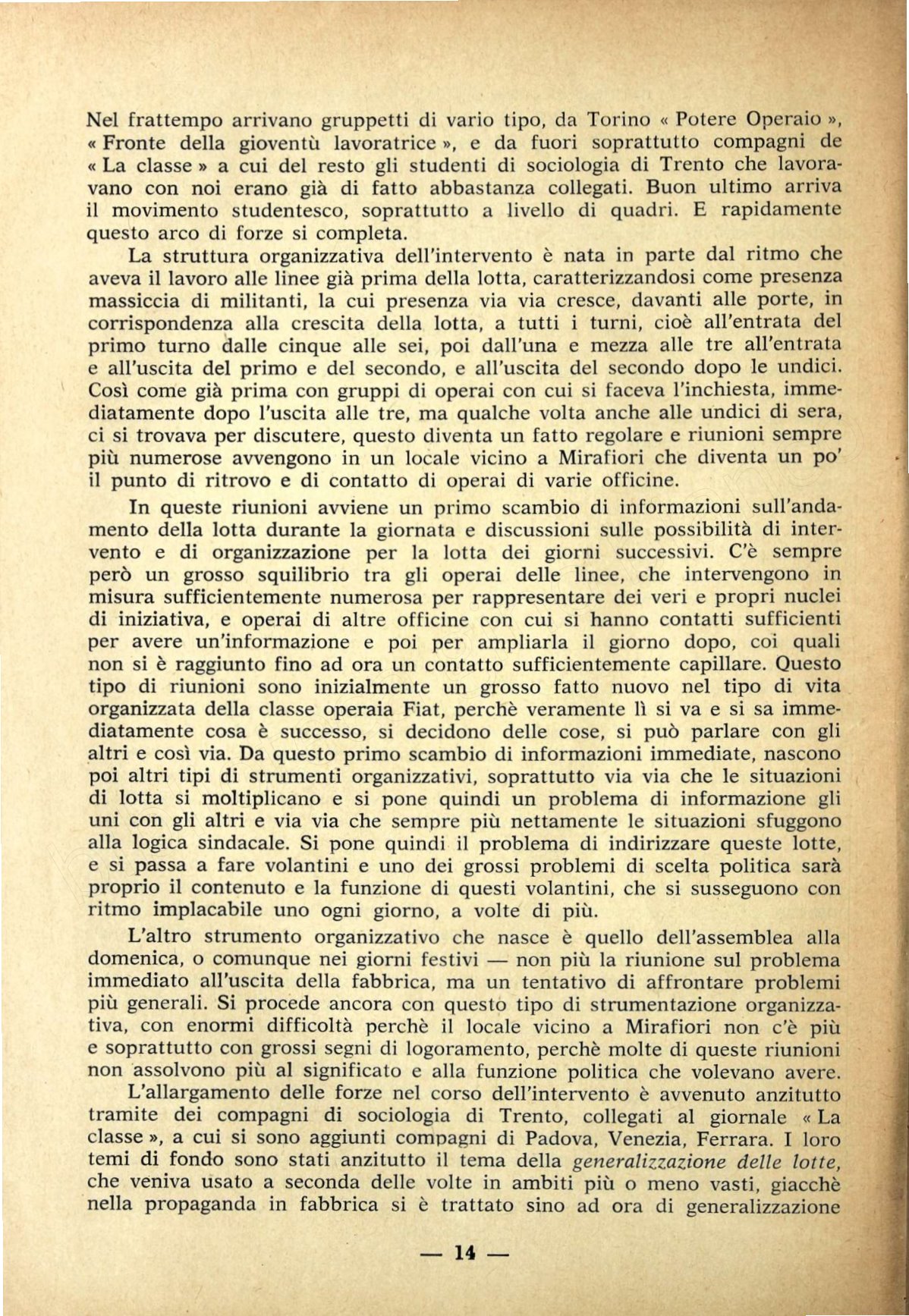
Nel frattempo arrivano gruppetti d i vario tipo, da Tor ino « Potere Operaio »,
«Fronte del la gioventù lavoratrice », e da f uo r i soprat tut to compagni de
«La classe)) a cui del resto gl i studenti d i sociologia d i Trento che lavora-
vano con no i erano già d i fat to abbastanza collegati. Buon u l t imo ar r i va
il movimento studentesco, soprat tut to a l ivel lo d i quadr i . E rapidamente
questo arco di forze si completa.
La strut tura organizzativa dell'intervento è nata i n parte dal r i tmo che
aveva i l lavoro alle linee già prima della lotta, caratterizzandosi come presenza
massiccia d i mi l i tant i , l a cui presenza via via cresce, davanti al le porte, i n
corrispondenza al la crescita del la lot ta, a t u t t i i turni , cioè al l 'entrata del
primo turno dal le cinque al le sei, po i dal l 'una e mezza al le t r e al l 'entrata
e all'uscita del pr imo e del secondo, e all'uscita del secondo dopo le undici.
Così come già prima con gruppi di operai con cui si faceva l'inchiesta, imme-
diatamente dopo l'uscita alle tre, ma qualche volta anche alle undici d i sera,
ci si trovava per discutere, questo diventa un fatto regolare e riunioni sempre
più numerose avvengono i n un locale vicino a Mi raf ior i che diventa un po'
il punto d i r i t rovo e d i contatto d i operai d i varie officine.
In queste r iunioni avviene un pr imo scambio d i informazioni sull'anda-
mento della lot ta durante la giornata e discussioni sulle possibilità d i inter-
vento e d i organizzazione p e r l a l o t t a de i g i orn i successivi. C' è sempre
però u n grosso squi l ibr io t r a g l i operai del le l inee, che intervengono i n
misura sufficientemente numerosa per rappresentare dei veri e propr i nuclei
di iniziativa, e operai d i al t re off icine con cui s i hanno contat t i suff icient i
per avere un' informazione e po i pe r ampl iar la i l giorno dopo, co i qua l i
non si è raggiunto f ino ad ora un contatto sufficientemente capillare. Questo
tipo d i r iunioni sono inizialmente un grosso fat to nuovo ne l t i po d i v i t a
organizzata della classe operaia Fiat, perchè veramente l ì si va e si sa imme-
diatamente cosa è successo, s i decidono del le cose, s i può parlare con g l i
altri e così via. Da questo primo scambio di informazioni immediate, nascono
poi al t r i t i p i d i strument i organizzativi, soprattutto via via che le situazioni
di lot ta s i mol t ipl icano e s i pone quindi un problema d i informazione g l i
uni con gl i al t r i e via via che sempre più nettamente le situazioni sfuggono
alla logica sindacale. Si pone quindi i l problema d i indirizzare queste lotte,
e si passa a fare volantini e uno dei grossi problemi d i scelta pol i t ica sarà
proprio i l contenuto e la funzione di questi volantini, che si susseguono con
ri tmo implacabile uno ogni giorno, a vol te d i più.
L'altro strumento organizzativo che nasce è quel lo dell'assemblea al la
domenica, o comunque nei giorni festivi — non più la riunione sul problema
immediato all 'uscita del la fabbrica, ma un tentativo d i affrontare problemi
più generali. Si procede ancora con questo t ipo di strumentazione organizza-
tiva, con enormi di ff icol tà perchè i l locale vicino a Mi raf ior i non c'è p i ù
e soprattutto con grossi segni di logoramento, perchè molte di queste riunioni
non assolvono più al significato e al la funzione pol i t ica che volevano avere.
L'allargamento delle forze nel corso dell'intervento è avvenuto anzitutto
tramite de i compagni d i sociologia d i Trento, col legat i a l giornale « La
classe », a cui si sono aggiunti compagni d i Padova, Venezia, Ferrara. I loro
temi d i fondo sono stat i anzitutto i l tema del la
generalizzazione delle lotte,
che veniva usato a seconda delle vol te i n ambi t i p i ù o meno vasti, giacchè
nella propaganda i n fabbr ica s i è t rat tato sino ad ora d i generalizzazione
14
















