
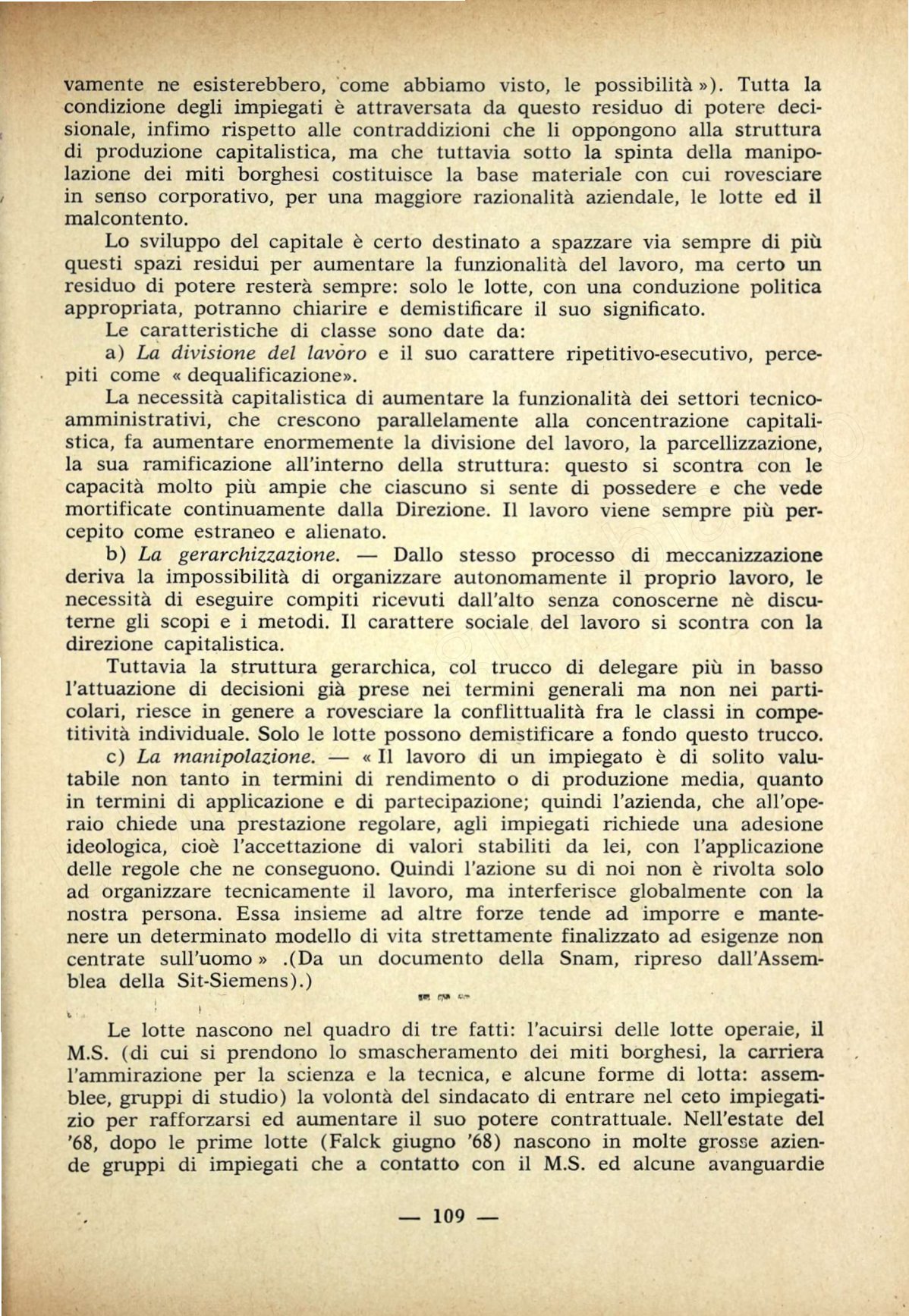
vamente ne esisterebbero, 'come abbiamo visto, l e possibi l i tà »). Tu t t a l a
condizione degl i impiegati è attraversata da questo residuo d i potere deci-
sionale, inf imo r ispet to al le contraddizioni che l i oppongono al la st rut tura
di produzione capitalistica, ma che tut tavia sot to l a spinta del la manipo-
lazione de i m i t i borghesi costituisce l a base materiale con cu i rovesciare
in senso corporativo, per una maggiore razional ità aziendale, l e lot te ed i l
malcontento.
Lo sviluppo del capitale è certo destinato a spazzare via sempre d i p i ù
questi spazi residui per aumentare l a funzional ità del lavoro, ma cer to un
residuo d i potere resterà sempre: solo le lotte, con una conduzione pol i t ica
appropriata, potranno chiar i re e demistificare i l suo significato.
Le caratteristiche d i classe sono date da:
a)
La divisione del lavo- ro
e i l suo carattere r ipet i t ivo-esecutivo, perce-
pi t i come « dequalificazione».
La necessità capitalistica di aumentare la funzionalità dei settori tecnico-
amministrativi, che crescono paral lelamente a l l a concentrazione capi tal i -
stica, fa aumentare enormemente l a divisione del lavoro, l a parcellizzazione,
la sua ramificazione al l ' interno del la st rut tura: questo s i scontra con l e
capacità mo l to p i ù ampie che ciascuno s i sente d i possedere e che vede
mortificate continuamente dal la Direzione. I l lavoro viene sempre p i ù per-
cepito come estraneo e alienato.
b)
La gerarchizzazione.
— Da l l o stesso processo d i meccanizzazione
deriva l a impossibi l ità d i organizzare autonomamente i l propr io lavoro, l e
necessità d i eseguire compi t i r icevut i dal l 'al to senza conoscerne nè discu-
terne g l i scopi e i metodi. I l carattere sociale del lavoro s i scontra con l a
direzione capitalistica.
Tuttavia l a st rut tura gerarchica, co l t rucco d i delegare p i ù i n basso
l'attuazione d i decisioni g i à prese ne i t e l g e n e r a l i ma non ne i par t i -
colari, riesce i n genere a rovesciare l a conf l i ttual i tà f r a l e classi i n compe-
t i t ivi tà individuale. Solo le lotte possono demistificare a fondo questo trucco.
c)
La manipolazione.
— « I l lavoro •di u n impiegato è d i sol i to valu-
tabile non tanto i n termini d i rendimento o d i produzione media, quanto
in termini d i applicazione e d i partecipazione; quindi l'azienda, che all'ope-
raio chiede una prestazione regolare, agl i impiegat i richiede una adesione
ideologica, cioè l'accettazione d i va l or i stabi l i t i d a l e i , con l'applicazione
delle regole che ne conseguono. Quindi l'azione su d i noi non è r ivol ta solo
ad organizzare tecnicamente i l lavoro, ma interferisce globalmente con l a
nostra persona. Essa insieme ad a l t re forze tende a d impor re e mante-
nere un determinato modello di vi ta strettamente finalizzato ad esigenze non
centrate sul l 'uomo» . (Da u n documento de l l a Snam, r ipreso dall'Assem-
blea del la Sit-Siemens).)
Le lot telotenascono nel quadro d i t re fat t i : l 'acui rsi del le lot te operaie,
i l
M.S.
( d i cu i s i prendono l o smascheramento dei mi t i borghesi, l a carriera
l'ammirazione per l a scienza e l a tecnica, e alcune forme d i lot ta: assem-
blee, gruppi di studio) l a volontà del sindacato di entrare nel ceto impiegati-
zio per rafforzarsi ed aumentare i l suo potere contrattuale. Nell'estate del
'68, dopo l e pr ime lot te (Falck giugno '68) nascono i n mol te grosse azien-
de gruppi d i impiegat i che a contat to con i l M.S. ed alcune avanguardie
109
















