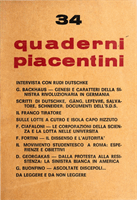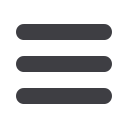
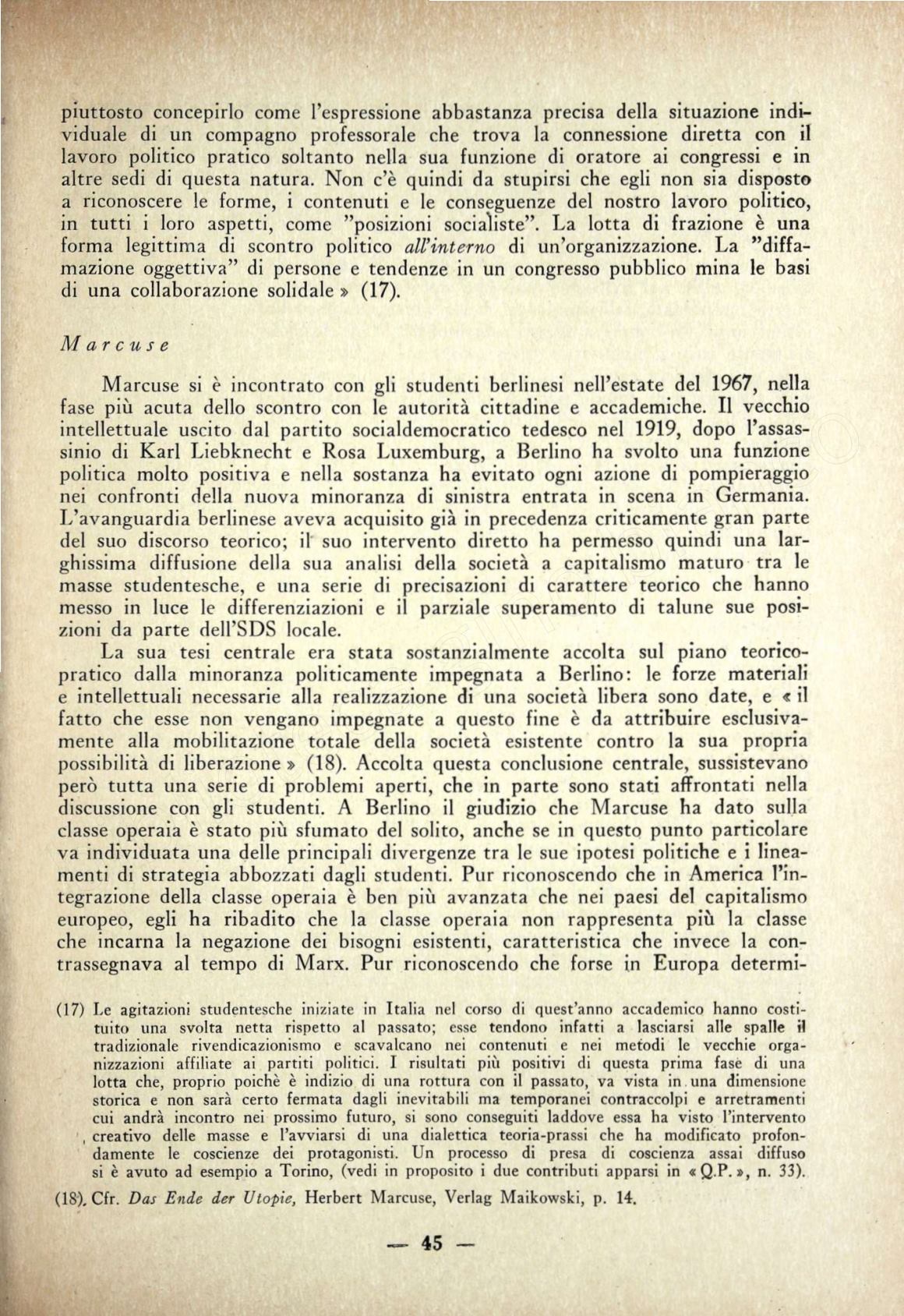
piuttosto concepirlo come l'espressione abbastanza precisa della situazione indi-
viduale di un compagno professorale che trova la connessione diretta con i l
lavoro politico pratico soltanto nella sua funzione di oratore ai congressi e in
altre sedi di questa natura. Non c'è quindi da stupirsi che egli non sia disposto
ariconoscere le forme, i contenuti e le conseguenze del nostro lavoro politico,
in tut t i i loro aspetti, come "posizioni socialiste". La lotta di frazione è una
forma legittima di scontro politico
all'interno
di un'organizzazione. La "diffa-
mazione oggettiva" di persone e tendenze in un congresso pubblico mina le basi
di una collaborazione solidale » (17).
Ma r c u s e
Marcuse si è incontrato con gli studenti berlinesi nell'estate del 1967, nella
fase più acuta dello scontro con le autorità cittadine e accademiche. I l vecchio
intellettuale uscito dal partito socialdemocratico tedesco nel 1919, dopo l'assas-
sinio di Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg, a Berlino ha svolto una funzione
politica molto positiva e nella sostanza ha evitato ogni azione di pompieraggio
nei confronti della nuova minoranza di sinistra entrata in scena in Germania.
L'avanguardia berlinese aveva acquisito già in precedenza criticamente gran parte
del suo discorso teorico; i f suo intervento diretto ha permesso quindi una lar-
ghissima diffusione della sua analisi della società a capitalismo maturo tra le
massestudentesche, e una serie di precisazioni di carattere teorico che hanno
messo in luce le differenziazioni e i l parziale superamento di talune sue posi-
zioni da parte dell'SDS locale.
La sua tesi centrale era stata sostanzialmente accolta sul piano teorico-
pratico dalla minoranza politicamente impegnata a Berlino: l e forze materiali
eintellettuali necessarie alla realizzazione di una società libera sono date, e € il
fatto che esse non vengano impegnate a questo fine è da attribuire esclusiva-
mente alla mobilitazione totale della società esistente contro l a sua propria
possibilità di liberazione » (18). Accolta questa conclusione centrale, sussistevano
però tutta una serie di problemi aperti, che in parte sono stati affrontati nella
discussione con gl i studenti. A Berlino i l giudizio che Marcuse ha dato sulla
classeoperaia è stato più sfumato del solito, anche se in questo punto particolare
va individuata una delle principali divergenze tra le sue ipotesi politiche e i linea-
menti di strategia abbozzati dagli studenti. Pur riconoscendo che in America l'in-
tegrazione della classe operaia è ben più avanzata che nei paesi del capitalismo
europeo, egli ha ribadito che la classe operaia non rappresenta più la classe
che incarna la negazione dei bisogni esistenti, caratteristica che invece la con-
trassegnava al tempo di Marx. Pur riconoscendo che forse in Europa determi-
(17) Le agitazioni studentesche iniziate in Italia nel corso di quest'anno accademico hanno costi-
tuito una svolta netta rispetto a l passato; esse tendono infatt i a lasciarsi al le spalle i !
tradizionale rivendicazionismo e scavalcano nei contenuti e nei metodi l e vecchie orga-
nizzazioni affiliate a i part i t i politici. I risultati più positivi d i questa prima fase d i una
lotta che, proprio poichè è indizio di una rottura con i l passato, va vista in una dimensione
storica e non sarà certo fermata dagli inevitabili ma temporanei contraccolpi e arretrarnenti
cui andrà incontro nei prossimo futuro, si sono conseguiti laddove essa ha visto l'intervento
. creativo delle masse e l'avviarsi d i una dialettica teoria-prassi che ha modificato profon-
damente l e coscienze dei protagonisti. Un processo d i presa d i coscienza assai diffuso
si è avuto ad esempio a Torino, (vedi in proposito i due contributi apparsi in « Q.P. »,
n.
33).
(18), Cfr.
Das Ende der Utopie,
Herbert Marcuse, Verlag Maikowski, p. 14.
— 45 —