
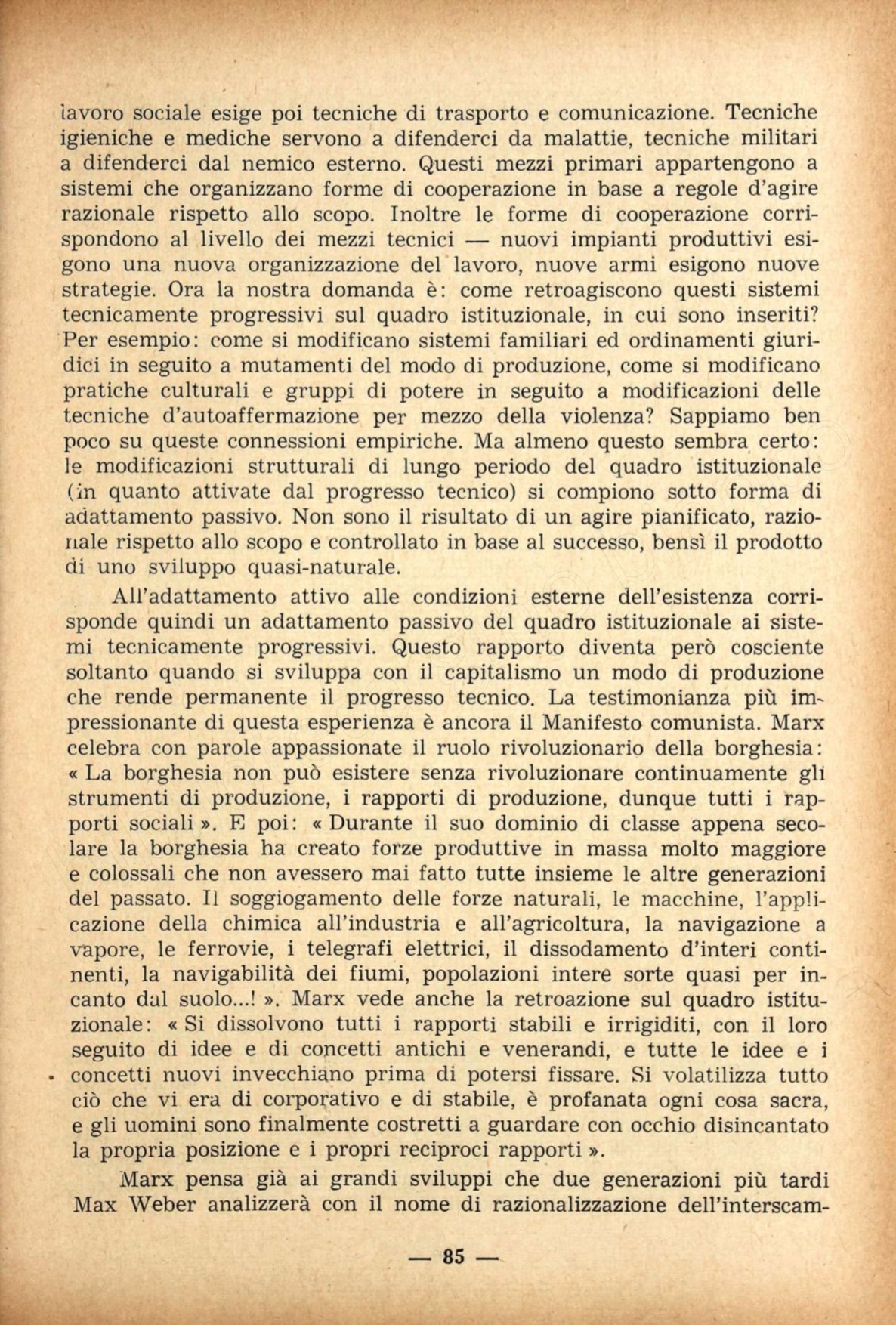
lavoro sociale esige poi tecniche di trasporto e comunicazione. Tecniche
igieniche e mediche servono a difenderci da malattie, tecniche mi l i tar i
a di fenderci dal nemico esterno. Questi mezzi pr imar i appartengono a
sistemi che organizzano forme d i cooperazione i n base a regole d'agire
razionale r ispet to a l l o scopo. I no l t r e l e forme d i cooperazione cor r i -
spondono a l l ivel lo dei mezzi tecnici — nuovi impiant i produt t ivi esi-
gono una nuova organizzazione del lavoro, nuove armi esigono nuove
strategie. Ora l a nostra domanda è: come retroagiscono questi sistemi
tecnicamente progressivi sul quadro istituzionale, i n cu i sono inseriti?
Per esempio: come si modificano sistemi fami l iar i ed ordinamenti giur i -
dici in seguito a mutamenti del modo di produzione, come si modificano
pratiche cul tural i e gruppi d i potere i n seguito a modificazioni del le
tecniche d'autoaffermazione pe r mezzo del la violenza? Sappiamo ben
poco su queste connessioni empiriche. Ma almeno questo sembra, certo:
le modi f icazioni s t rut tura l i d i l ungo periodo de l quadro ist i tuzionale
(in quanto at t ivate dal progresso tecnico) s i compiono sotto forma d i
adattamento passivo. Non sono i l risul tato di un agire pianificato, razio-
nale rispetto allo scopo e controllato in base al successo, bensì i l prodotto
di uno svi luppo quasi-naturale.
All'adattamento at t i vo al le condizioni esterne dell'esistenza cor r i -
sponde quindi un adattamento passivo del quadro istituzionale ai siste-
mi tecnicamente progressivi. Questo rappor to diventa per t , cosciente
soltanto quando s i svi luppa con i l capitalismo un modo d i produzione
che rende permanente i l progresso tecnico. L a testimonianza p i ù im-
pressionante di questa esperienza è ancora i l Manifesto comunista. Marx
celebra con parole appassionate i l ruolo rivoluzionario del la borghesia:
«La borghesia non pile) esistere senza rivoluzionare continuamente g l i
strumenti d i produzione, i rapport i d i produzione, dunque t u t t i i rap-
porti sociali ». E poi : « Durante i l suo dominio d i classe appena seco-
lare l a borghesia ha creato forze produt t ive i n massa mol to maggiore
e colossali che non avessero mai fatto tut te insieme le al tre generazioni
del passato. I l soggiogamento delle forze natural i , le macchine, l 'appl i -
cazione del la chimica al l ' indust r ia e al l 'agricoltura, l a navigazione a
vapore, l e ferrovie, i telegraf i elet tr ici , i l dissodamento d ' inter i cont i -
nenti, l a navigabi l i tà dei f iumi , popolazioni intere sorte quasi per i n-
canto dal suolo...! ». Mar x vede anche l a retroazione sul quadro ist i tu-
zionale: « Si dissolvono t u t t i i rappor t i stabi l i e i r r igidi t i , con i l loro
seguito d i idee e d i concetti ant ichi e venerandi, e tut te l e idee e i
• concet t i nuovi invecchiano pr ima d i potersi fissare. S i volatilizza tut to
ciò che v i era d i corporativo e d i stabile, è profanata ogni cosa sacra,
e gl i uomini sono finalmente costretti a guardare con occhio disincantato
la propria posizione e i propr i reciproci rapport i ».
Marx pensa g i à a i grandi svi luppi che due generazioni p i ù tard i
Max Weber analizzerà con i l nome d i razionalizzazione dell'interscam-
















