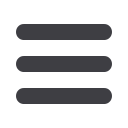
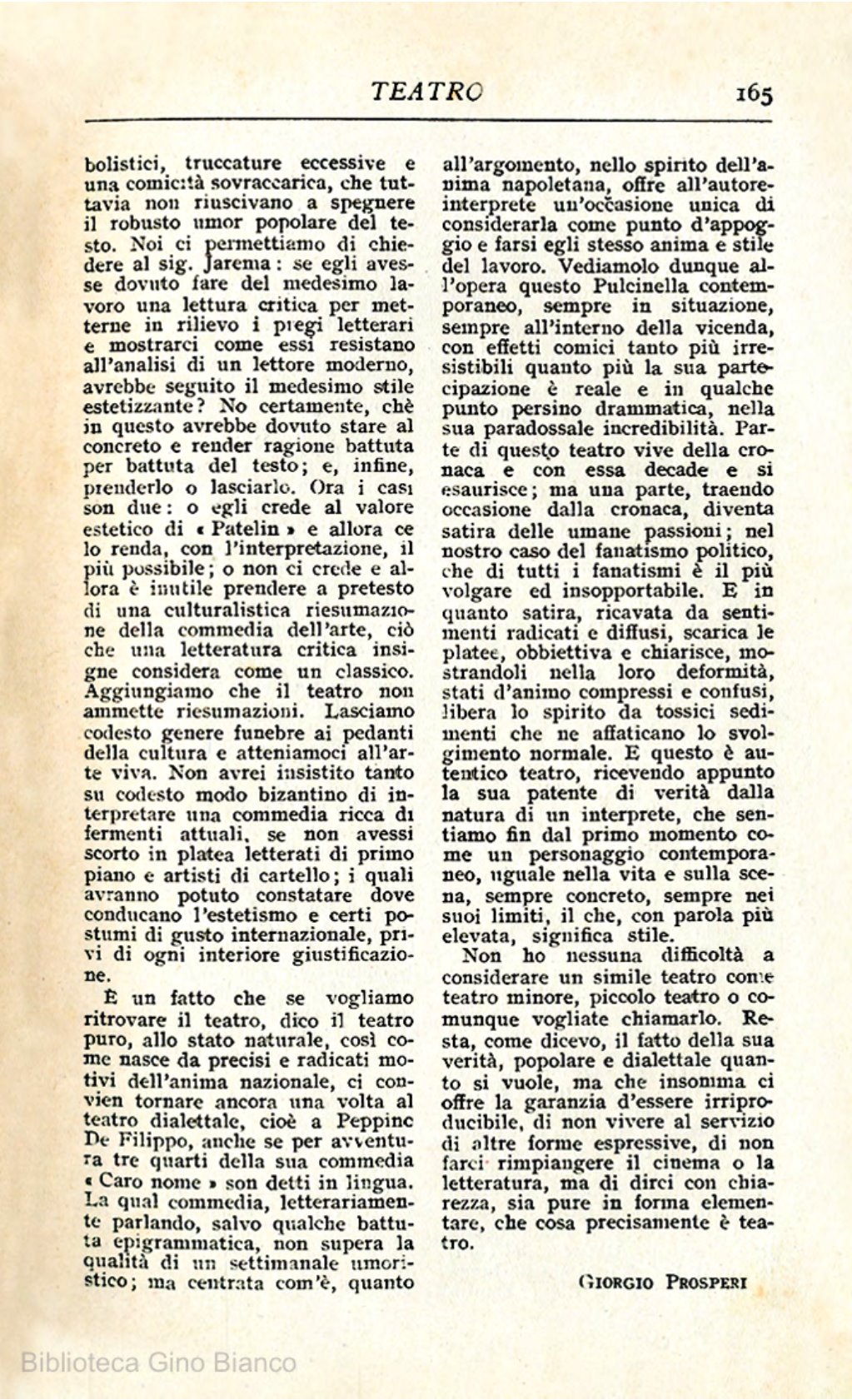
TEATRO
bolistid, truttature
ecc:essi,;e e
una comic:!à ~v rac.:arica, che tut –
tavia non riuscivano a spegnere
il robusto
11mor
porolare del te-
~~~C
~J°~i;~
r:::~{!~
11
;:
0
c;\~
!!!:
se do\·nto fare del medtsimo la–
voro una lettura critica per met–
terne in ri)ievo
i
piegi
let_terari
e mostrar ci come essi resistano
all'analisi di un l<-ttore moderno,
avrebbe seguito il medesimo stile
estdizz.1ntc? No certa me11te, cbè
in questo avrebbe dovuto stare al
concreto e render ragione battuta
per battuta del test o ;
e,
infine,
ptcndc:rlo o lasciar h,. Ora
i
casi
son due: o <:jtli crede
al
valore
estetico di • Patelin • e a11ora ce
lo rend a, con J'intcrprct.tzione, il
r~:~
~si~!~i!i~
;,:!de~~
c;~:e:e~;
di
una
culturali stic11 ries11maz10-
ne della commedia dell'arte , ciò
che
1111a
letteratura critica insi–
gne considera come un classico.
Aggiung iamo che il teatro non
ammette
ricsu mazil.:rni.
Lasciamo
codesto genere funebre ai ~anti
clclla cultura e atte niamoci all'ar–
te ,·h·a. Non anci insistito tanto
su codesto modo bizantino di in–
t.<:rprctare
una
commedia ricca
d1
fermenti attuali,
se
non
avessi
scorto in platea letterati di primo
piru10
e
artisti di cartello;
i
quali
avrnnno potuto consta tare dove
conducano
1
'estetismo
e certi
po–
stumi di gusto inten1a1,ion~e, pn–
,·i
di ogni interio re giust
1ficaz.io–
nc.
E un fatto che se vogliamo
ritrovare
il
teatr o, dico
il
teatro
puro, allo stato naturale, cosl
co–
me nasce da precisi e radicati mo–
tivi dEll'anima nazionale,
ci
con–
vien tornare ancora una ,·olla al
teatro dialettale, cioè a Peypinc
~
Filippo,
anc11ese
per anentu–
ra tre quarti della sua commedia
• Caro nome • son detti in ling ua.
La qual commedia, lettera riamen–
te parlando, sako quakbe battu –
ta
epigrammatica, non supera la
qualità lli
1111
H.-ttinmnal e umori•
stico; ma (.'(-lllr.:ita
com•~. quanto
all'argo1uento, nello spinto dell'a–
nima napoletana, offre all'autore–
int erprete uu'ocbsioue unica
di
~~~1~:~:1:gu°:
del lavoro. Vediamolo dunque
al–
l'opera questo Pukinclla contem–
poraneo, sempre in situazione,
sempre all'interno della vicenda,
con effetti comici tanto più irre–
sistibili quanto
più
la sua
part&–
cipazion e
è
reale e in_ qual che
punto persino drammatica, nella
sua paradossale incredibilità . Par–
te di questo teatro vive della ero:,
naca
e
con
essa decade e s1
1:saurisce; ma una parte , traendo
O('Casione
dalla cronaca,
diventa
satira delle umane passioni ; nel
~~ tr3i
c~idi
1
l:~1:ti'::::r
rNt~'fà
,·olgare
ed
insoppo rtabile. E io
quanto satira, ricavata da senti•
menti radicati
e
diffusi, scarica
}e
platct , obbietti,·a e chiarisce, mo–
strandoli nella loro deformità,
stati d'animo compressi e confusi ,
libera lo spirito da tossici sedi–
menti che ne affaticano lo svol–
gin1ento normale.
E
questo
è
au–
tentico teatr o, riee,·endo appunto
la
sua patente di ,·erità dalla
natura di
un
interprete, che
sen–
tiamo fin dal primo momento
co–
me un personaggio contempora–
neo,
uguale nella vita e sulla sce–
na, s,c,mpre concreto, sempre
nei
suoi limiti, il che, con parola più
elevata, significa stile.
Non ho nessuna difficoltà a
considerar e un sim ile teat ro contt'
teatro minore, piccolo teatro o
co–
munque ,·ogliatc chiamarlo .
Re–
sta, come dicevo, il
fatto
della sua
verità,
popola re
e
dialettal e quan–
to si vuo le, ma che insonima
ci
offre
la
garanzia d'essere irripro–
ducibil e,
di
non ,·i\'ere al sen-izio
di :iltre
fonue
espressh-e, di non
farci- rimpianger e il dno.>mao la
letteratura, ma di dirci con chia–
rez1A'\, sia
pu re
in forma elemen–
tare, che cosa precisamente
l-
tea–
tro.
liJORGIO PROSPDI
















