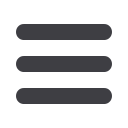
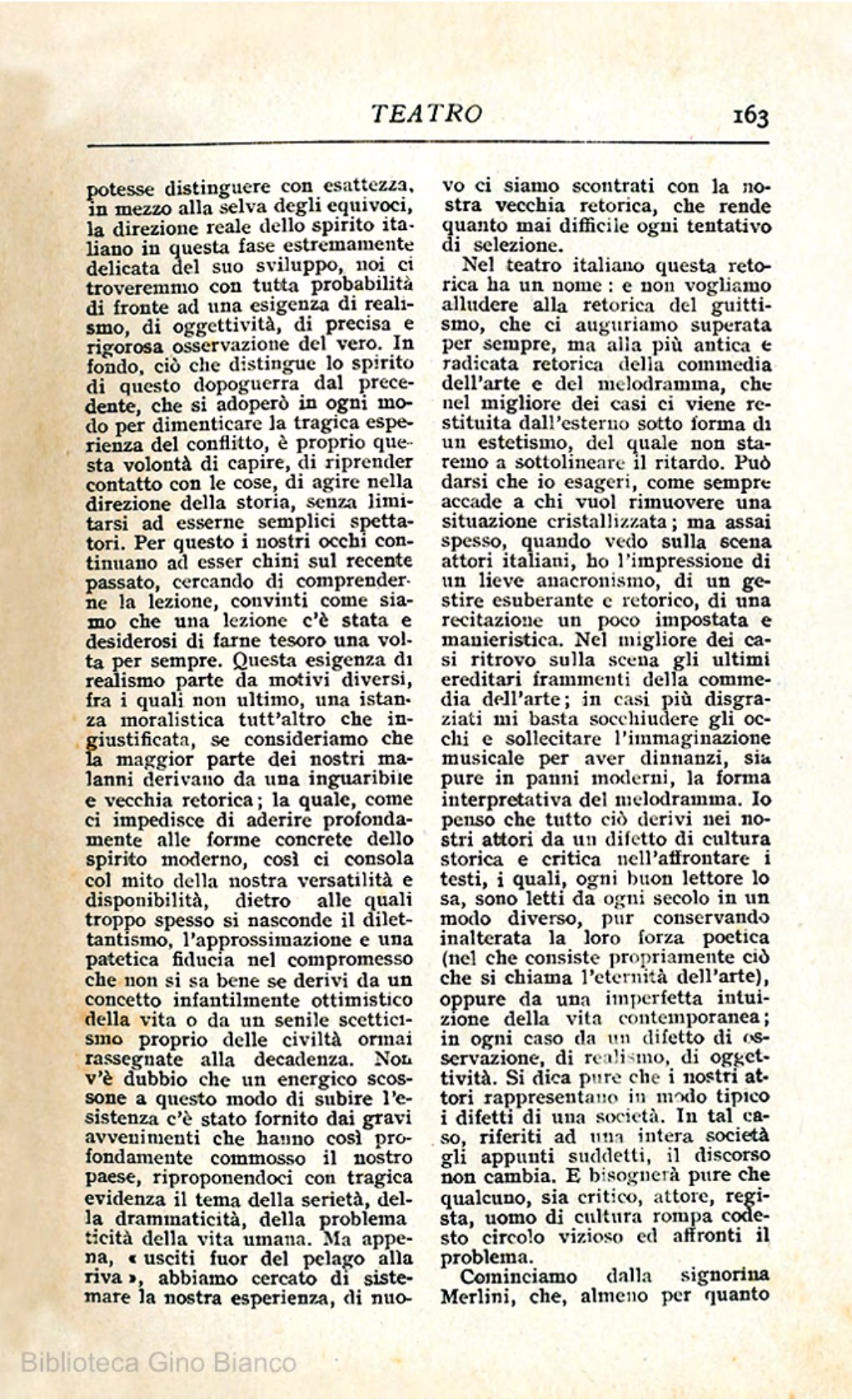
TEATRO
potesse distingue re ron
csat~cu:1,
1n
mez.zo alla .selva degli
eqm voci,
la direzione reale 1lcllospirito ita-
~:li~a~:
a t~J
3
~iii~~a:::t~
tro veremmo con tutta probabilit.à
di fronte ad una esigenza di rc:ah–
smo, di oggctth-!tà, di precisa e
rigorosa ossc rvaz1onc
del
,·ero.
ln
fondo,
ciò
che di$l i11!,"UCIo spirit o
di questo dopoguerra dal prece–
dente, che si adoperò in ogni mo–
do per dimcntic_arc la tra gic:' espe–
rienza del confhtto,
è
prop rio qu~
sta volontà di capire, di riprender
contatto con le cose, di agire nell_a
direzione della storia, senza
)im i–
tarsi ad esserne semplici spetta–
tori. Per questo
i
nostri 0tt b1con–
tin uano ad esser chini sul recente
passato, cercando di comprender–
ne la lezione, convinti come sia–
mo che unn lcidonc c'è sta ta e
desiderosi di farne te.soro una voi-
~~:~~~~
~~c:-~f:!gdf::rj:
fra
i
quali non ultimo , una istan –
za inor3listica tutt'a ltro che in–
giustificata,
se
consideri3mo che
la m3ggior parte dei nostri ma–
lanni derivano d3 una inguaribi le
e vecchia retorica; la quale, come
ci
impedisce di aderire profonda–
mente alle !onne concrete dello
spirito moderno, cosl ci consola
col mito della nostra versatilità
e
disponibilità,
dietro alle quali
troppo
spesso
si nasconde il dilet–
tanti smo, l'appross imazione
e
una
patetica fiil11c1a nel comprom esso
che
11011
si sa bene se derivi da un
concetto infantilmente ottimi stico
della vita o da un senile
scettict·
smo proprio delle civiltà onnai
~~è?ubb\~
~~a u ~:~~~~ ~
sone a questo modo di subire l
'e–
sistenza c'è stato fornito dai gra,, i
av,·euimeuti che haimo
cosl
prc,.
fondamcute commosso il nostro
paCS(I:, riproponendoci con tragica
evidenza il tema della serietà, del-
!fci1Id~JJt! ,(!~~t~~~~-
~~~b~~7!-
na, •
usciti fuor
del pcla~o alla
riva •• abbiamo cercalo dt
sis*
mare la nostra esperienza ,
<li
nu~
vo ci siamo scontrati con la no–
stra vecchia retorica, che rende
q~anto i_naidifficile
ogui
tent ativo
d1 sclez1one.
Nel teatro italiano questa reto-–
rica ba un nome : e non vogli -.mo
alludere
alla
retorica
tk l
guitti–
smo, che ci auguriam o supi:rata
per sempre, ma alla.
più
antica
t:
radicata retorica della commedia
dell'arte
e
del melodramma, che
nel miglior e dei casi ci viene
re•
stitu ita dall 'esterno sotto forma di
un cstetismo
1
del quale non sta–
remo
a ,;otlolmenrc
11ritar do.
Può
darsi che io esager i, come semp re
accade a chi vuol rimuovere una
situaz ione cristalliz:-.ata; ma assai
!~r[it i!\i!~~
0
ho\·~•~:~n;~J~:io:C~~
11.n
lieve anacronismo , di un
ge-
:!!:J~::!~!r~n~c
~tor~~tt:n:
manieristica. Nel migliore dei
ca–
si ritrovo suJla scena gli ultimi
eredi tari frammenti della comme-
~!!tid~}•~~:/a
i::OC~~:lucf;
t·~
chi
e
sollccitare l'imntag luazione
musicale per
averdinnanzi,
sic,.
pure in pan ni moderni, la fom1a
interpretativa del melodramma . Io
penso che tutto ciò derivi nei no-–
stri attori da
un
difetto
di
cultu ra
storica
e critica
11cll'atfrontarc
i
testi,
i
quali, ogni buon lettore lo
sa, sono letti
da
ogni secolo in un
modo dh·erso, plir conservando
inaltera ta la loro forza poetica
(nel che cons iste propriamente ciò
che si chiama l'etcr mt à dell'arte),
oppure da
una
imperfett a intui–
zione della
vit:i
rontcm1>0ranea;
in
ogni
caso da
1111
difetto di
1.-s–
scrvazion t<,
di
reali-;mo.
di
ogi,:et–
tività. Si dica pure che
i
n~tri at–
tori rappr esenta no in m"ltlo tipK'O
i
difetti di una soc.·ktà. In tal c:a•
so, riferiti ad
11111
int era società
gli appunti sudM ll i,
il
<liscorso
non cambia . E bi~ogucrà pure cbie
~:,
1
~°:~
%a:,::~;~
;~~ir
:Jt
sto circolo
,•i1.ioso cd
arironti il
problema.
Cominciamo
d:tlla signorina
MerHni, che, almeno per quanto
















