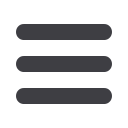
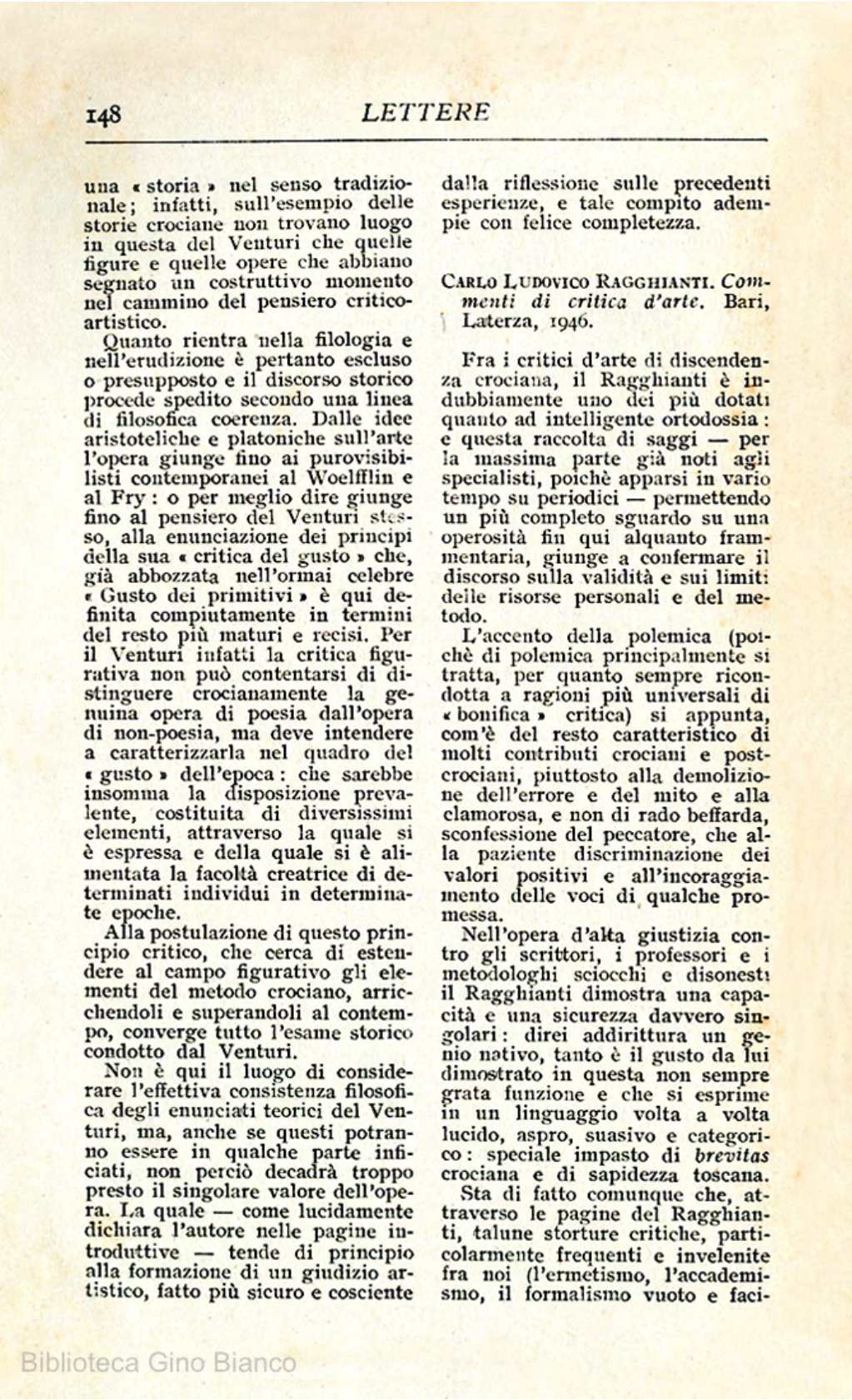
LETTERE
uua • storia • nel senso tradizio–
nale;
infatti,
sull'c:icmpio delle
storie cr«i: mc
11011
trova no luogo
~~,~~t!t~t~c~~e
Vo~!~~\,~:~-ibti~::~
~f'~
3
;::i
11
~i
1
~
det~~~~fcr!'~~~~i~
artistico.
Q11:111to
rientra
uella 61o1ogfo,
e
ncll'cn1dizione
è
pertanto escluso
o presuppos to e
il
discorso storico
::f°riì'~~
i~=~~o
D~
1
l~
tJ~!
::iristotclichc e platoniche sull'arte
1'01><:ragiunge
iiuo ai puro,•i~ibi–
li:ui coutemporand
al Woelfflm e
al Fry: o per meglio dire J{iunge
fino al pensiero del Ventun
:<.tc~–
M>,
alla enunciazion e dei
prmcip1
della su.a • critica del gusto • che,
già abbou :ata nell'onn ai cclcbre
• Gusto dei primiti •i •
è
qui de-–
finita compiutamente in termini
del resto
più
maturi e recisi. Per
il \'cn lurt iufott i la critica figu–
rativa non può contentarsi
di di•
stinguc rc crocianamcn te
la
ge–
nuina opeTa di poesia dall'opera
di
non-poesia ,
nia
dc\·e intendeTe
a earatterizzaTla
ne l C(ll:ldTOdel
i~:~t;
dl~u•r~izi~!e
~~~~
lente,
costituita
di dh•CTS1ssimi
elementi,
attra\'CTSO
la
quale
si
è
espTCSS.'\ e
della
quale
si
è
::,;li•
mcuta ta
la facollà
cTeatTkc di
dc–
tcnn inati
iudh·idui in
dcteTmina •
te
lri:"~tulazione
di qu~to pTin–
cipio
critico ,
che cera. di esteu–
dcTe
al
campo
figurath·o
gli el<-–
menti del melO<lo cTociano, anic-•
d1cndoli e
supcr:mdo li al contem•
pn, oon\'eTgc tutto l'esame sloTioo
condotto
tlal
Ventu ri.
Non
è
qui il luogo di conside–
rare l'effettiva co11s1stcn1.a filosofi–
ca
degli enunciat i teorici del Ven•
turi,
ma,
anche
se questi
potTan-
~Gt~~
i~1~ÌÒa 1
d~atf:~r~;;;
pn~sto
il
singol:ue valore dell'ope–
n.
J.3
quale -
come lucidamente
dichiara
l'autore
nelle pagine
iu–
lTodntth·e
-
temlc di principio
alla
foTm;"11.
io11c
di un gimHzio ar–
tistioo, fatto
pitì
sicuro e
coscien te
dalla
ri11cs."ioue sulle pTeced.enti
espe rienze, e tale
compito
adcm•
pie cou felice completezza.
CULO
L UDO\'ICORA.GGUl,\:-.TI.
Cot11-
m~11tl
di
triti(ll
d'a,tc,
&ri,
· L..:rtcrza,
19-i6.
Fra
i
critici d'arte
di
11isttndco·
za
crociana,
il Raggbfo11ti
è
i.n–
dnbbiamentc:
11110
dd
più
dotali
quaulo ad
iutclligen tc
ortodossia.:
e quesla
r.iccolta
di sagg i -
per
la massima parte
g!à noti agli
specialis ti,
po1chè
apparsi
in
,·ario
tempo
su periodici -
permet tendo
un più c-ompleto
sguardo
su una
~rOdilà
fin
qui alquauto
fram•
menlaria,
1,.'lu11ge
a
c.o11fcrmare il
disoor!lO11ulla
,·alidità
e
sui
limit:
dcilc
risone
personali
e del me–
todo.
L'acc ento
della
polemica
(poi•
chè di polemica pri11cipal111entc s1
tratta,
per
11 rnnto
sempre
ric-on–
dotta
a
ragioni
_pi\\
unl\·enali
di
~':!~ifid!1
"
r!~c:!rn~!er~f~nl:i
molti contributi
c.rociaui
e
po6l•
crocia11i,
piuttosto
alla demoli zio–
ne dell' erroTe e del mito e alla
clamorosa, e non di
rndo
beffarda,
sco11fo"ioue
del pcce:atore,
clic: al·
la
paziente
discrimiuazione
dei
l~I~~~[!
1Fc'Ìf~
1\~'
/
dt!'!~kb!'g:~
tuC:5$3,
Nell'opera
d'alta
giustizia
e.on•tro gli 11Crittori,
i professori
e imetodoloihi
sciocc::hi
e
disonesti
il Raggbmnt
i dimostra una
CDJXl·
cità e 1111
:t sicurc1.zadn"\·ero sin•
~f~a:i~~i\~i.r~111:!trl, t~~=to
11
:1\.
~
dim()S-trnto in ques ta non
sempre
g-rata
funzione
e
che
si
esprunc
111
un
linguaggio
volta
a volta
lucido, aspro,
suasi\'o
e c-ategori•
co:
spcdalc
impasto di
brniltas
crociana e
di
sapidcua
toscana.
Sta di
fatto
comunque
che,
o.t•
:r~~~~:1
1\l:; ~1!
!
!~~i~!!g;~
colanncntc
frequenti e invelen ite
fra
uoi (l'e nnctis mo, l'ac.cademi•
smo,
il
formalismo
\'uoto e foci-
















