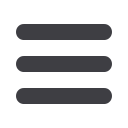
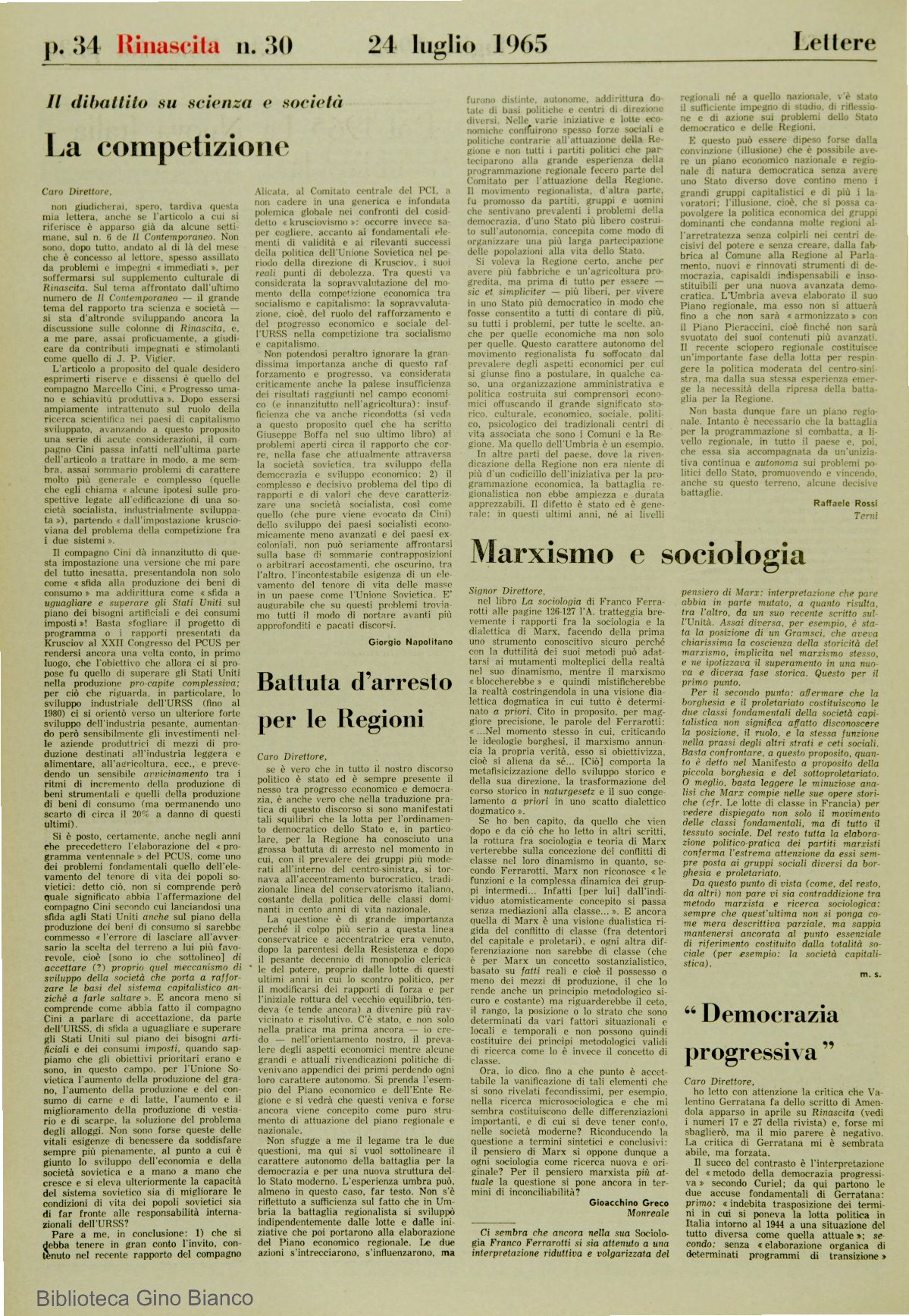
Ildibatitosuscienzaesocietà
La competizione
CaroDiretore,
nongiudicherai,spero,tardivaquesta
mia letera,anchesel'articoloacuisi
riferisceèapparsogiàdaalcuneseti-
mane,suln.6de
IlContemporaneo.
Non
sono,dopo tuto,andatoaldilàdelmese
cheèconcesoallettore,spesoassilato
daproblemieimpegni«immediati»,per
sofermarsisulsupplementoculturaledi
Rinascita.
Sul temaafrontatodal'ultimo
numerodeIl
Contemporaneo
—ilgrande
temadelrapportotrascienzaesocietà—
sistad'altrondesviluppandoancorala
discusionesulecolonnedi
Rinascita,
e,
amepare,assaiproficuamente.agiudi-
caredacontributi impegnatiestimolanti
come quelodiJ.P.Vigier.
L'articoloapropositodelqualedesidero
esprimertiriserveedissensièquelodel
compagnoMarcelloCini.«Progresouma-
noeschiavitùprodutiva».Dopoessersi
ampiamente intratenutosulruolodella
ricercascientificaneipaesidicapitalismo
sviluppato,avanzandoaquestoproposito
unaseriediacuteconsiderazioni,ilcom-
pagnoCinipassa infatinel'ultimaparte
del'articoloatratareinmodo,ame sem-
bra,assaisommarioproblemidicaratere
moltopiùgeneraleecompleso (quelle
cheeglichiama«alcune ipotesisulepro-
spetive legateal'edificazionediunaso-
cietàsocialista, industrialmentesviluppa-
ta»),partendo«dal'impostazionekruscio-
vianadelproblemadelacompetizionefra
iduesistemi».
IlcompagnoCinidà innanzitutodique-
sta impostazioneunaversionechemipare
del tutoinesata,presentandolanonsolo
come«sfidaalaproduzionedeibenidi
consumo »maaddirituracome«sfidaa
uguagliareesuperaregliStatiUnitisul
pianodeibisogniartificialiedeiconsumi
imposti»!Bastasfogliareilprogetodi
programmao i rapportipresentatida
KrusciovalXXICongressodelPCUSper
rendersiancoraunavoltaconto,
in
primo
luogo,che l'obietivochealloracisipro-
pose fuquelodisuperaregliStatiUniti
nelaproduzionepro-capitecomplessiva;
perciòcheriguarda,inparticolare,lo
sviluppo industrialedel'URSS(finoal
1980)cisiorientòversounulterioreforte
sviluppodell'industriapesante,aumentan-
do peròsensibilmentegliinvestimentinel-
leaziendeprodutricidimezzidipro-
duzionedestinatial'industrialeggerae
alimentare,all'aericoltura,ecc.,epreve-
dendounsensibileavvicinamentotra i
ritmi
diincrementodellaproduzionedi
benistrumentaliequelidelaproduzione
dibenidiconsumo (mapermanendouno
scartodicircail20%adannodiquesti
ultimi).Sièposto,certamente,ancheneglianni
cheprecedetero l'elaborazionedel«pro-
gramma ventennale»delPCUS.comeuno
deiproblemi fondamentaliquelodel'ele-
vamentodeltenoredivitadeipopoliso-
vietici:dettociò,nonsicomprendeperò
qualesignificatoabbia l'afermazionedel
compagnoCinisecondocui lanciandosiuna
sfidaagliStatiUniti
anche
sulpianodela
produzionedeibenidiconsumosisarebbe
commeso«l'eroredilasciareal'avver-
sariolasceltadelterenoaluipiùfavo-
revole,cioè[sonoiochesotolineo]
di
accetare(?)proprioquelmeccanismodi
sviluppodelasocietàcheportaarafor-
zarelebasidelsistemacapitalisticoan-
zichéafarlesaltare».Eancoramenosi
comprende comeabbiafatoilcompagno
Ciniaparlarediaccetazione,daparte
del'URSS,disfidaauguagliareesuperare
gliStatiUnitisulpianodeibisogni
arti-
ficiali
edeiconsumi
imposti.
quandosap-
piamo chegliobietiviprioritarieranoe
sono,
in
questocampo,perl'UnioneSo-
vietica l'aumentodelaproduzionedelgra-
no, l'aumentodellaproduzioneedelcon-
sumodicarneedilatte,l'aumentoeil
miglioramentodelaproduzionedivestia-
rioediscarpe,lasoluzionedelproblema
deglialoggi.Nonsono forsequestedele
vitaliesigenzedibenesseredasoddisfare
semprepiùpienamente,alpuntoacuiè
giuntolosviluppodel'economiaedella
societàsovieticaeamanoamanoche
cresceesielevaulteriormentelacapacità
delsistemasovieticosiadimigliorarele
condizionidivitadeipopolisovieticisia
difarfrontealleresponsabilità interna-
zionalidell'URSS? Pareame,inconclusione:1)chesi
deba tenereingrancontol'invito,con-
tìnutonelrecenterapportodelcompagno
Alicata,alComitatocentraledelPCI,a
non cadereinunagenericaeinfondata
polemicaglobaleneiconfrontidelcosid-
detto«krusciovismo»:occore invecesa-
percogliere,accantoaifondamentaliele-
mentidivaliditàeairilevantisuccessi
dellapoliticadell'UnioneSovieticanelpe-
riododeladirezionediKrusciov,isuoi
reali
puntididebolezza.Traquestiva
consideratalasopravvalutazionedelmo-
mentodellacompetizioneeconomicatra
socialismoecapitalismo:lasopravvaluta-
zione.cioè,delruolodelraforzamentoe
delprogressoeconomicoesocialedel-
l'URSSnelacompetizionetrasocialismo
e capitalismo.
Non potendosiperaltro ignorarelagran-
dissima importanzaanchediquestoraf-
forzamentoeprogresso,vaconsiderata
criticamenteanchelapalese insuficienza
deirisultatiraggiuntinelcampo economi-
co (einnanzituttonell'agricoltura):insuf-
ficienzachevaanche ricondota(siveda
aquestopropositoquelchehascritto
GiuseppeBofanelsuoultimolibro)ai
problemiaperticircailrapportochecor-
re,nelafasecheatualmenteatraversa
lasocietàsovietica,trasviluppodela
clemecraziaesviluppoeconomico:2) il
complessoedecisivoproblemadeltipodi
rapportiedivalorichedevecaratteriz-
zareunasocietàsocialista,cosìcome
quelo (chepurevieneevocatodaCini)
delosviluppodeipaesisocialistiecono-
micamentemenoavanzatiedeipaesiex-
coloniali,nonpuòseriamenteafrontarsi
sulabasedisommariecontrapposizioni
o arbitrariaccostamenti.cheoscurino,tra
l'altro,l'incontestabileesigenzadiunele-
vamentodeltenoredivitadelemasse
inunpaesecome l'UnioneSovietica.E'
augurabilechesuquestiproblemitrovia-
mo tutti ilmododinortareavantipiù
approfonditiepacatidiscorci.
GiorgioNapolitano
Batutad'aresto per leRegioni
CaroDiretore,
seèverocheintutoilnostrodiscorso
politicoèstatoedèsemprepresenteil
neso traprogressoeconomicoedemocra-
zia,èancheverochenela traduzionepra-
ticadiquestodiscorsosisonomanifestati
talisquilibrichelalottaper l'ordinamen-
todemocraticodeloStato
e,in
partico-
lare,perlaRegionehaconosciutouna
grosabattutadiarrestonelmomento in
cui,conilprevaleredeigruppipiùmode-
ratial'internodelcentro-sinistra,sitor-
navaal'accentramentoburocratico,tradi-
zionale lineadelconservatorismo italiano,
costantedelapoliticadeleclassidomi-
nanti incentoannidivitanazionale.
Laquestioneèdigrande importanza
perchéilcolpopiùserioaquesta linea
conservatriceeaccentratriceeravenuto,
dopo laparentesidellaResistenzaedopo
ilpesantedecenniodimonopolioelenca-
ledelpotere,propriodallelotediquesti
ultimianniincuiloscontropolitico,per
ilmodificarsideirapportidiforzaeper
l'inizialeroturadelvecchioequilibrio,ten-
deva (etendeancora)adivenirepiùrav-
vicinatoerisolutivo.C'èstato,enonsolo
nelapraticamaprimaancora— iocre-
do—nell'orientamentonostro,ilpreva-
leredegliaspetieconomicimentrealcune
grandieatualirivendicazionipolitichedi-
venivano appendicideiprimiperdendoogni
lorocaratereautonomo.Siprenda l'esem-
piodelPianoeconomicoedell'EnteRe-
gioneesivedràchequestivenivaeforse
ancoravieneconcepitocomepurostru-
mentodiatuazionedelpiano regionalee
nazionale. Non sfuggea
me
il
legametra
ledue
questioni,maquisivuoisotolineareil
caratereautonomodellabatagliaperla
democraziaeperunanuovastruturadel-
loStatomoderno.L'esperienzaumbrapuò,
almeno inquestocaso,fartesto.Nons'è
rifletutoasuficienzasul fattoche inUm-
brialabattagliaregionalistasisviluppò
indipendentementedaleloteedaleini-
ziativechepoiportaronoalaelaborazione
delPianoeconomico regionale.Ledue
azionis'intrecciarono,s'influenzarono,
ma
furonodistinte,autonome,addiriturado-
tatedibasipoliticheecentrididirezione
diversi.Nelevarieiniziativeeloteeco-
nomiche confruironospeso forzesocialie
politichecontrarieal'attuazionedelaRe-
gioneenontuttiipartitipoliticichepar-
teciparonoallagrandeesperienzadela
programmazione regionale feceropartedel
Comitatoperl'atuazionedelaRegione.
Ilmovimento regionalista,d'altraparte,
fupromossodapartiti,gruppieuomini
che sentivanoprevalentiiproblemidela
democrazia.d'unoStatopiù liberocostrui-
tosul'autonomia,concepitacomemododi
organizareunapiùlargapartecipazione
delepopolazionialavitadeloStato.
SivolevalaRegionecerto,ancheper
averepiùfabbricheeun'agricolturapro-
gredita,maprimadituttoperessere—
sicetsimpliciter
—piùliberi,pervivere
inunoStatopiùdemocratico inmodo che
fosse consentitoatuttidicontaredipiù,
su tuttiiproblemi,pertuttelescelte,an-
cheperqueleeconomichemanonsolo
perquele.Questocarattereautonomodel
movimento regionalistafusofocatodal
prevaleredegliaspettieconomicipercui
sigiunse finoapostulare,inqualcheca-
so,unaorganizazioneamministrativae
politicacostruitasuicomprensoriecono-
miciofuscandoilgrandesignificatosto-
rico.culturale,economico,sociale,politi-
co,psicologicodeitradizionalicentridi
vitaassociatachesonoiComunielaRe-
gione.Maquelodel'Umbriaèunesempio.
Inaltrepartidelpaese.dovelariven-
dicazionedelaRegionenoneranientedi
piùd'uncodicilodel'iniziativaperlapro-
grammazione economica,labattagliare-
gionalisticanonebbeampiezaedurata
apprezzabili.Ildifetoèstatoedègene-
rale:inquestiultimianni,
néai
liveli
regionalinéaquelonazionale,v'èstato
ilsuficiente
impegnodistudio.
diriflessio-
neediazionesuiproblemideloStato
democraticoedelleRegioni.
E questopuòesseredipeso forsedala
convinzione (illusione)cheèpossibileave-
reunpianoeconomiconazionaleeregio-
naledinaturademocraticasenzaavere
unoStatodiversodovecontinomenoi
grandigruppicapitalisticiedipiùi la-
voratori: l'ilusione,cioè,chesiposaca-
povolgere lapoliticaeconomicadeigruppi
dominantichecondannamolteregionial-
l'aretratezzasenzacolpirlineicentride-
cisividelpotereesenzacreare,dalafab-
bricaalComunealaRegionealParla-
mento,nuovierinnovatistrumentidide-
mocrazia,capisaldi indispensabilieinso-
stituibiliperunanuovaavanzatademo-
cratica.L'Umbriaavevaelaboratoilsuo
Piano regionale,maessononsiatuerà
finoachenonsarà«armonizzato,con
ilPianoPieracciní,
cioèfinchénonsarà
svuotatodeisuoicontenutipiùavanzati.
Ilrecentescioperoregionalecostituisce
un'importante fasedelalotaperrespin-
gerelapoliticamoderatadelcentro-sini-
stra,madalasuastessaesperienzaemer-
ge lanecessitàdelaripresadelabata-
gliaperlaRegione.
Non bastadunque fareunpianoregio-
nale. Intantoènecessariochelabataglia
per laprogrammazionesicombatta,ali-
velo regionale,intutoilpaesee,poi,
che essasiaaccompagnatadaun'unizia-
tivacontinuae
autonoma
suiproblemipo-
liticideloStato,promuovendoevincendo,
anchesuquesto tereno,alcunedecisive
battaglie.
Marxismoesociologia
SignorDirettore,
nel libroLa
sociologia
diFrancoFera-
rotialepagine126-127 l'A.trateggiabre-
vementeirapportifralasociologiaela
dialetticadiMarx,facendodelaprima
uno strumentoconoscitivosicuroperché
con ladutilitàdeisuoimetodipuòadat-
tarsiaimutamentimolteplicidelarealtà
nelsuodinamismo,mentreilmarxismo
« blocherebbe»equindimistificherebbe
larealtàcostringendola inunavisionedia-
leticadogmaticaincuitutoèdetermi-
natoapriori.Citoinproposito.permag-
gioreprecisione,leparoledelFerraroti:
« ...Nelmomento stessoincui,criticando
le ideologieborghesi,ilmarxismoannun-
cialapropriaverità,essosiobietivizza,
cioèsialienadasé..[Ciò]comportala
metafisicizazionedelosviluppostoricoe
delasuadirezione,latrasformazionedel
corsostorico in
naturgesetz
eilsuoconge-
lamentoa
priori
inunoscattodialettico
dogmatico».
Sehobencapito,daquelochevien
dopoedaciòcheho letoinaltriscriti,
larotturafrasociologiaeteoriadiMarx
verterebbesullaconcezion
edeiconflitidiclassenellorodinamism
o inquanto.se-condoFeraroti.Marxno
n riconosce«lefunzionielacomplessadinamicadeigrup-
pi intermedi..Infatti[perlui]dall'indi-
viduo atomisticamenteconcepitosipassa
senzamediazionialaclasse..».Eancora
queladiMarxèunavisionedualisticari-
gidadelconflitodiclasse(fradetentori
delcapitaleeproletari),eognialtradif-
ferenziazionenonsarebbediclasse(che
èperMarxunconcetosostanzialistico,
basatosu
fatti
realiecioèilpossesoo
menodeimezzidiproduzione,ilchelo
rende ancheunprincipiometodologicosi-
curoecostante)ma riguarderebbeilceto.
ilrango,laposizioneolostratochesono
determinatidavarifatorisituazionalie
localietemporalienonpossonoquindi
costituiredeiprincipimetodologicivalidi
diricercacome loèinveceilconcetodi
classe.Ora,iodico,finoachepuntoèaccet-
tabilelavanificazioneditalielementiche
sisonorivelatifecondissimi,peresempio,
nelaricercamicrosociologicaechemi
sembra costituisconodelediferenziazioni
importanti,edicuisidevetenerconto,
nelesocietàmoderne?Riconducendola
questioneaterminisinteticieconclusivi:
ilpensierodiMarxsiopponedunquea
ognisociologiacome ricercanuovaeori-
ginale?Perilpensieromarxistapiù
at-
tuale
laquestionesiponeancorainter-
minidiinconciliabilità?
Gioachino
Greco
Monreale
CisembracheancoranelasuaSociolo-
giaFrancoFerarotisisiaatenutoauna
interpretazioneridutivaevolgarizzatadel
RafaeleRossi
Terni
pensierodiMarx: interpretazionechepare
abbiainpartemutato,aquantorisulta,
tral'altro,daunsuo recentescrittosul-
l'Unità.Assaidiversa,peresempio,èsta-
talaposizionediunGramsci,cheaveva
chiarissima lacoscienzadelastoricitàdel
marxismo, implicitanelmarxismostesso,
ene ipotizzavailsuperamento inunanuo-
vaediversafasestorica.Questoperil
primopunto.
Perilsecondopunto:afermarechela
borghesiaeilproletariatocostituisconole
due classi fondamentalidelasocietàcapi-
talisticanonsignificaaffatodisconoscere
laposizione,ilruolo,elastessa funzione
nelaprassideglialtristratiecetisociali.
Bastaconfrontare,aquestoproposito,quan-
toèdetonelManifestoapropositodela
piccolaborghesiaedelsotoproletariato.
Omeglio,basta leggereleminuzioseana-
lisicheMarxcompienelesueoperestori-
che (cfr.
Lelottediclasse inFrancia)per
vederedispiegatononsoloilmovimento
deleclassifondamentali,maditutoil
tesutosociale.Delrestotutalaelabora-
zionepolitico-praticadeipartitimarxisti
conferma l'estremaatenzionedaessisem-
prepostaaigruppisocialidiversidabor-
ghesiaeproletariato.
Da questopuntodivista (come,delresto,
daaltri)nonparevisiacontraddizionetra
metodomarxistaericercasociologica:
sempre chequest'ultimanonsipongaco-
memeradescritivaparziale.masappia
mantenersiancorataalpuntoessenziale
diriferimentocostituitodalatotalitàso-
ciale(peresempio:lasocietàcapitali-
stica).
"Democrazia progressiva"
CaroDiretore,
ho lettoconatenzionelacriticacheVa-
lentinoGerratanafadeloscritodiAmen-
dolaapparsoinaprilesu
Rinascita
(vedi
inumeri17e27dellarivista)e,forsemi
sbaglierò,mailmioparereènegativo.
LacriticadiGeratanamièsembrata
abile,maforzata.
Ilsuccodelcontrastoèl'interpretazione
del«metododelademocraziaprogressi-
va»secondoCuriel;daquipartonole
due accuse fondamentalidiGeratana:
primo:
«indebita trasposizionedeitermi-
ni
in
cuisiponevalalotapoliticain
Italiaintornoal1944aunasituazionedel
tutodiversacomequelaattuale»;
se-
condo:
senza«elaborazioneorganicadi
determinatiprogrammiditransizione»
















