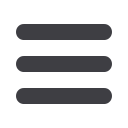
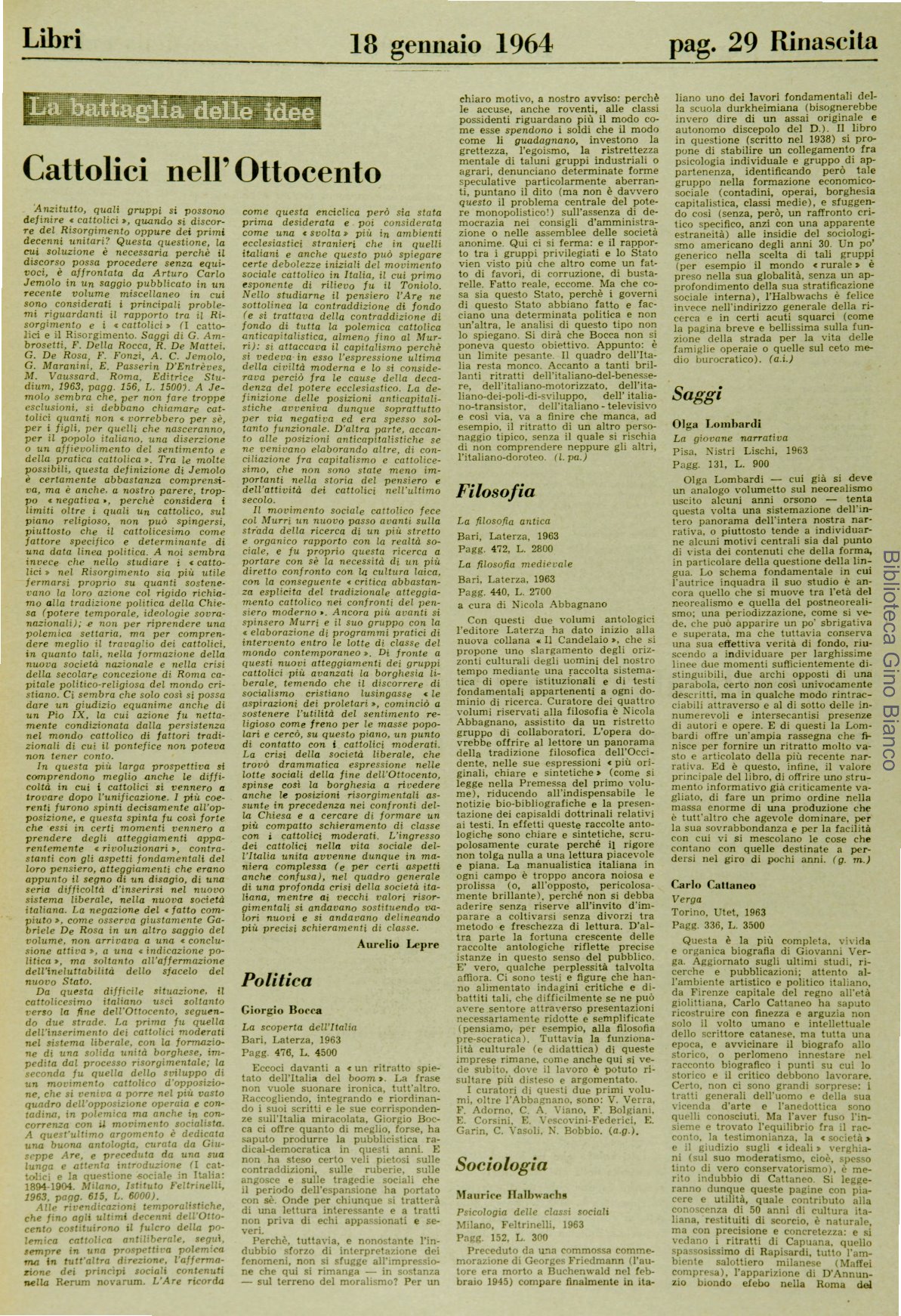
*
•
- •"«
.•
co-
Pr 5 - - • .
_
-- . •
.
...
..
--t:retttrm2err,nx22,••_vett
.t.nu-
CattolicinellOtocento
Anzituto,quailgruppisipossono
definire«catoliciquandosidiscor-
redelRisorgimentooppuredeiprimi
decenniunitari?Questaquestione,la
cuisoluzioneènecessariaperchèil
discorsopossaprocederesenzaequi-
voci,èafrontatadaArturoCarlo
Jemolo inunsaggiopubblicatoinun
recentevolumemiscelaneoincui
sonoconsiderati iprincipaliproble-
miriguardantiilrapportotrailRi-
sorgimentoe i cattolici ( I cato-
licieilRisorgimento.SaggidiG.Am-
brosetti,F.DelaRocca,R.DeMattei,
G.DeRosa,F.Fonzi,A.C.Jemolo,
G.Maranini,E.PasserinD'Entrèves,
M.Vaussard.Roma,EditriceStu-
dium,1963,pagg.156,L.1500).AJe-
molo sembrache,pernonfaretroppe
esclusioni,sidebbanochiamarecat-
toliciquantinonevorebberopersè,
peri figli,perquelichenasceranno,
perilpopoloitaliano,unadiserzione
ounaffievolimentodelsentimentoe
dellapraticacattolicaP.Tratemolte
possibili,questadefinizionediJemolo
certamenteabbastanzacomprensi-
va,maèanche.anostroparere,trop-
ponegativa»,perchèconsiderai
limitioltre iqualiuncattolico,sui
pianoreligioso,nonpuòspingersi,
piutostocheilcatolicesimocome
fatorespecificoedeterminantedi
unadatalineapolitica.Anoisembra
invecechenelostudiarei catto-
lici»nelRisorgimentosiapiùutile
fermarsipropriosuquantisostene-
vano laloroazionecolrigidorichia-
moalatradizionepoliticadeltaChie-
sa (poteretemporale, ideologiesovra-
nazionali);enonperriprendereuna
polemicasetaria,?Tinpercompren-
deremeglioiltravagliodeicatolici,
inquantotali,nellaformazionedella
nuovasocietànazionaleenelacrisi
delasecolareconcezionediRomaca-
pitalepolitico-religiosadelmondocri-
stiano.Cisembrachesolocosìsipossa
dareungiudizioequanimeanchedi
unPioIX, lacuiazionefuneta-
mentecondizionatadalapersistenza
netmondocattolicodifattoritradi-
zionalidicuiilponteficenonpoteva
non tenerconto.
Inquestapiùlargaprospetivasi
comprendonomeglioanchelediffi-
coltäincui icatolicisivenneroa
trovaredopo l'unificazione.Ipiùcoe-
rentifuronospintidecisamenteal'op-
posizione,equestaspintafucosìforte
cheessiincertimomentivenneroa
prenderedegliateggiamentiappa-
rentementecrivoluzionari»,contra-
stanticongliaspetifondamentalidel
loropensiero,atteggiamenticheerano
appuntoilsegnodiundisagio,diuna
seriadifficoltàd'inserirsinelnuovo
sistema liberale,nellanuovasocietà
italiana.Lanegazionedel'fattocom-
piuto),comeosservagiustamenteGa-
brieleDeRosainunaltrosaggiodel
volume,nonarrivavaaunacconclu-
sioneattiva3.,aunaeindicazionepo-
litica',masoltantoall'afermazione
del'inelutabilitàdellosfacelodel
nuovoStato.
Daquestadifficilesituazione, il
catolicesimoitalianoIcasoltanto
versolafinedel'Ottocento,seguen-
doduestrade.Laprimafuquela
del'inserimentodeicatolicimoderati
nelsistemaliberale.conlaformazio-
nediunasolidaunitàborghese,im-
peditadalprocesso risorgimentale;la
secondafuqueladelosviluppodi
unmovimentocattolicod'opposizio-
ne.chesi
venivaaporrenelpiù
vasto
quadrodel'opposizioneoperaiaecon-
tadin,a,inpolemicamaancheincon-
corenzaconi4movimentosocialista.
A quest'ultimoargomentoèdedicata
unabuonaantologia,curatadaGiu-
seppeAre,eprecedutadaunasua
lungaeattentaintroduzione(Icat-
tolicielaquestione .socialeinItalia:
1894-1904.Milano,IstitutoFeltrinetti,
1963,paag.615,L.6000).
Ailerivendicazionitemporalistiche,
che finoagliultimidecennidel'Otto-
centocostituironoilfulcrodellapo-
le-micacattolicaantiliberale,seguì,
sempreinunaprospetivapolemica
ma intutraltradirezione,l'aferma-
zionedeiprincipisocialicontenuti
nela
Rerurnnovarum.
L'Are
ricorda
comequestaenciclicaperòsiastata
primadesiderataepoiconsiderata
comeunacsvolta2.piùinambienti
ecclesiasticistraniericheinquelli
italianieanchequestopuòspiegare
certedebolezzeinizialidelmovimento
socialecatolicoinItalia,ilcuiprimo
esponentedirilievofu ilToniolo.
Nelostudiarneilpensierol'Arene
sotolinealacontraddizionedifondo
(esitrattavadelacontraddizionedi
fondodituttalapolemicacatolica
anticapitalistica,almenofinoalMur-
ri):siataccavailcapitalismoperchè
sivedevainesso l'espressioneultima
delaciviltàmodernaelosiconside-
ravaperciòfralecausedeladeca-
denzadelpotereecclesiastico.Lade-
finizionedelleposizionianticapitali-
sticheavvenivadunquesopratutto
pervianegativaederaspessosob-
tanto funzionale.D'altraparte,accan-
toaleposizionianticapitalistichese
nevenivanoelaborandoaltre,dicon-
ciliazionefracapitalismoecatolice-
simo,chenonsonostatemenoim-
portantinellastoriadelpensieroe
del'ativitàdeicattolicinel'ultimo
secolo. Ilmovimentosocialecatolicofece
colMurriunnuovopassoavantisula
stradadeltaricercadiunpiùstreto
eorganicorapportoconlarealtàso-
ciale,efuproprioquestaricercaa
portareconsèlanecessitàdiunpiù
diretoconfrontoconlaculturalaica,
con laconseguenteccriticaabbastan-
zaesplicitadeltradizionaleatteggia-
mentocatoliconeiconfrontidelpen-
sieromodernop.Ancorapiùavantisi
spinseroMurrieilsuogruppoconla
« elaborazionediprogrammipraticidi
interventoentrolelottediclassedel
mondo contemporaneo.Difrontea
questinuoviateggiamentideigruppi
catolicipiùavanzatilaborghesiali-
berale, temendocheitdiscoreredi
socialismocristianolusingassecle
aspirazionideiproletaricominciòa
sostenerel'utilitàdelsentimentore-
ligiosocame frenoperlemasepopo-
lariecercò,suquestopiano,unpunto
dicontattoconicattolicimoderati.
Lacrisidelasocietàliberale,che
trove)drammaticaespressionenele
lottesocialidelafinedel'Ottocento,
spinsecosìlaborghesiaarivedere
ancheleposizionirisorgimentalias-
sunte inprecedenzaneiconfrontidel-
taChiesaeacercarediformareun
piùcompatoschieramentodiclasse
coni cattolicimoderati.L'ingresso
deicattolicinellavitasocialedel-
l'Italiaunitaavvennedunqueinma-
nieracomplessa(epercertiaspetti
ancheconfusa),nelquadrogenerale
diunaprofondacrisidelasocietàita-
liana,mentreaivecchivaloririsor-
gimentalisiandavanosostituendova-
lorinuoviesiandavanodelineando
piùprecisischieramentidiclasse.
AurelioLepre
Politica
GiorgioBocea
Lascopertadel'Italia
Bari,Laterza,1963
Pagg.476,L.4500
Eccocidavantiacunritrattospie-
tatodell'Italiadelboom,.Lafrase
nonvuolesuonare ironica,tutt'altro.
Raccogliendo, integrandoeriordinan-
doisuoiscrittielesuecorisponden-
zesul'Italiamiracolata,GiorgioBoc-
cacioffrequantodimeglio,forse,ha
saputoprodurrelapubblicisticara-
dical-democraticainquestianni.E
nonhastesocertovelipietosisulle
contraddizioni,sulleruberie,sulle
angosceesuletragediesocialiche
ilperiododel'espansionehaportato
consè.Ondeperchiunquesitraterà
diunaleturainteressanteeatratti
nonprivadiechiappassionatiese-
veri.Perchè,tuttavia,enonostantel'in-
dubbiosforzodiinterpretazionedei
fenomeni,nonsisfuggeall'impressio-
nechequisirimanga—insostanza
— sulterenodelmoralismo?Perun
chiaromotivo,anostroavviso:perchè
leaccuse,ancheroventi,alleclassi
possidenti riguardanopiùilmodoco-
me esse
spendono
isoldicheilmodo
comeli
guadagnano,
investonola
gretezza, l'egoismo,laristretezza
mentaleditalunigruppiindustrialio
agrari,denuncianodeterminateforme
speculativeparticolarmenteaberran-
ti,puntanoildito(manonèdavvero
questo
ilproblemacentraledelpote-
remonopolistico!)sul'assenzadide-
mocrazianeiconsiglid'amministra-
zioneonelleassembleedelesocietà
anonime.Quicisiferma:eilrappor-
totraigruppiprivilegiatieloStato
vienvistopiùchealtrocomeunfat-
todifavori,dicoruzione,dibusta-
rele.Fatoreale,eccome.Macheco-
sasiaquestoStato,perchèigoverni
diquestoStatoabbianofattoefac-
cianounadeterminatapoliticaenon
un'altra,leanalisidiquestotiponon
lospiegano.SidiràcheBoccanonsi
ponevaquestoobietivo.Appunto:
un limitepesante.Ilquadrodell'Ita-
liarestamonco.Accantoatantibril-
lantiritrattidell'italiano-del-benesse-
re,del'italiano-motorizzato,dell'ita-
liano-dei-poli-di-sviluppo,dell'italia-
no-transistor,dell'italiano-televisivo
ecosìvia,vaafinirechemanca,ad
esempio,ilritrattodiunaltroperso-
naggio tipico,senzailqualesirischia
dinoncomprendereneppureglialtri,
l'italiano-doroteo.
(I.
pa.)
Filosofia
La
filosofiaantica
Bari,Laterza,1963
Pagg.472,L.2800
La
filosofiamedievale
Bari,Laterza,1963
Pagg.440,L.2700
acuradiNicolaAbbagnano
Conquestiduevolumiantologici
l'editoreLaterzahadatoinizioalla
nuovacolana«UCandelaio›,chesi
proponeunoslargamentodeglioriz-
zonticulturalidegliuominidelnostro
tempomedianteunaraccoltasistema-
ticadiopereistituzionalieditesti
fondamentaliappartenentiaognido-
miniodiricerca.Curatoredeiquattro
volumiriservatialafilosofiaèNicola
Abbagnano,assistitodaunristretto
gruppodicolaboratori.L'operado-
vrebbeoffrireallettoreunpanorama
delatradizionefilosoficadel'Occi-
dente,nellesueespressioni(piùori-
ginali,chiaree
sintetiche
(come
si
leggenelaPremessadelprimovolu-
me),riducendoal'indispensabilele
notiziebio-bibliograficheelapresen-
tazionedeicapisaldidottrinalirelativi
aitesti.Ineffettiquesteraccolteanto-
logichesonochiareesintetiche,scru-
polosamentecurateperchéilrigore
non tolganulaauna letturapiacevole
epiana.Lamanualisticaitalianain
ognicampoètroppoancoranoiosae
prolissa(o,all'opposto,pericolosa-
mentebrilante),perchénonsidebba
aderiresenzariserveal'invitod'im-
parareacoltivarsisenzadivorzitra
metodoefreschezzadilettura.D'al-
trapartelafortunacrescentedele
raccolteantologicherifletteprecise
istanzeinquestosensodelpubblico.
E'vero,qualcheperplessitàtalvolta
afiora.Cisonotestiefigurechehan-
noalimentatoindaginicriticheedi-
battititali,chedificilmentesenepuò
averesentoreattraversopresentazioni
necessariamenteridoteesemplificate
(pensiamo,peresempio,alafilosofia
pre-socratica).Tuttavialafunziona-
litàculturale(edidatica)diqueste
imprese rimane,comeanchequisive-
desubito,doveillavoroèpotutori-
sultarepiùdistesoeargomentato.
Icuratoridiquesti
dueprimivolu-mi,oltrel'Abbagnano,
sono:V.Verra,F.Adorno,C.A.Via
no,F.Bolgiani.E.Corsini,E.Vescovini-Federici,E.
Garin,C.Vasoli,N.Bobbio.
(a.g.).
Sociologia
MauriceHalbwachs
Psicologiadeleclassisociali
Milano,Feltrineli,1963
Pagg.152,L.300
Precedutodaunacommosa comme-
morazionediGeorgesFriedmann(l'au-
toreeramortoaBuchenwaldnelfeb-
braio1945)compare finalmente inita-
lianounodeilavorifondamentalidel-
lascuoladurkheimiana (bisognerebbe
inverodirediunassaioriginalee
autonomodiscepolodelD.). Il libro
inquestione(scritonel1938)sipro-
ponedistabilireuncolegamentofra
psicologia individualeegruppodiap-
partenenza, identificandoperò
tale
grupponellaformazioneeconomico-
sociale(contadini,operai,borghesia
capitalistica,classimedie),esfuggen-
do così(senza,però,unrafrontocri-
ticospecifico,anziconunaapparente
estraneità)alleinsidiedelsociologi-
smo americanodeglianni30.Unpo'
genericonellasceltadi taligruppi
(peresempioilmondocrurale è
presonelasuaglobalità,senzaunap-
profondimentodelasuastratificazione
sociale interna),l'Halbwachsèfelice
invecenel'indirizzogeneraledelari-
cercaeincertiacutisquarci(come
lapaginabreveebelissimasulafun-
zionedelastradaperlavitadele
famiglieoperaieoquelesulcetome-
dioburocratico).(ai.)
Saggi
OlgaLombardi
Lagiovane
narrativa
Pisa,NistriLischi,1963
Pagg.131,L.900
OlgaLombardi—cuigiàsideve
un analogovolumetosulneorealismo
uscitoalcunianniorsono—tenta
questavoltaunasistemazionedel'in-
teropanoramadel'interanostranar-
rativa,opiutostotendeaindividuar-
nealcunimotivicentralisiadalpunto
divistadeicontenutichedelaforma,
inparticolaredelaquestionedelalin-
gua.Loschema fondamentaleincui
l'autrice inquadrailsuostudioèan-
coraquelochesimuovetral'etàdel
neorealismoequeladelpostneoreali-
smo;unaperiodizzazione,comesiv&
de.chepuòapparireunpo'sbrigativa
esuperata.machetutaviaconserva
unasuaefetivaveritàdifondo,riu-
scendoaindividuareperlarghissime
lineeduemomentisufficientementedi-
stinguibili,duearchioppostidiuna
parabola,certononcosìunivocamente
descriti,mainqualchemodorintrac-
ciabiliattraversoealdisotodellein-
numerevolieintersecantisipresenze
diautorieopere.EdiquestilaLom-
bardiofreun'ampia rassegnachefi-
nisceperfornireunritrattomoltova-
stoearticolatodelapiùrecentenar-
rativa.Edèquesto,infine,ilvalore
principaledellibro,dioffrireunostru-
mento informativogiàcriticamenteva-
gliato,difareunprimoordinenela
masa enormediunaproduzioneche
tutt'altrocheagevoledominare,per
lasuasovrabbondanzaeperlafacilità
concuivisimescolanolecoseche
contanoconqueledestinateaper-
dersinelgirodipochianni.
(g.m.)
CarloCahaneo
Verga
Torino,Utet,1963
Pagg.336,L.3500
Questaè lapiùcompleta,vivida
eorganicabiografiadiGiovanniVer-
ga.Aggiornatosugliultimistudi,ri-
cercheepubblicazioni:attentoal-
l'ambienteartisticoepoliticoitaliano,
daFirenzecapitaledelregnoal'età
giolittiana,CarloCataneohasaputo
ricostruireconfinezzaearguzianon
soloilvoltoumanoeintelletuale
deloscritorecatanese.matuttauna
epoca,eavvicinareilbiografoallo
storico,operlomeno innestarenel
raccontobiograficoipuntisucuilo
storicoeilcriticodebbono lavorare.
Certo,noncisonograndisorprese:i
trattigeneralidell'uomoedellasua
vicendad'arteel'anedoticasono
queliconosciuti.Maraverfusol'in-
siemeetrovatol'equilibriofrailrac-
conto,latestimonianza,lacsocietà
eilgiudiziosuglicidealiverghia-
ni(sulsuomoderatismo,cioè,spesso
tintodiveroconservatorismo),ème-
ritoindubbiodiCataneo.Silegge-
rannodunquequestepagineconpia-
cereeutilità,qualecontributoalla
conoscenzadi50annidiculturaita-
liana,restituitidiscorcio,ènaturale,
ma conprecisioneeconcretezza:esi
vedanoi ritrattidiCapuana,quelo
spassosissimodiRapisardi,tutol'am-
bientesalottieromilanese(Maffei
compresa), l'apparizionediD'Annun-
ziobiondoefebonellaRomadel
3
















