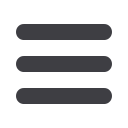
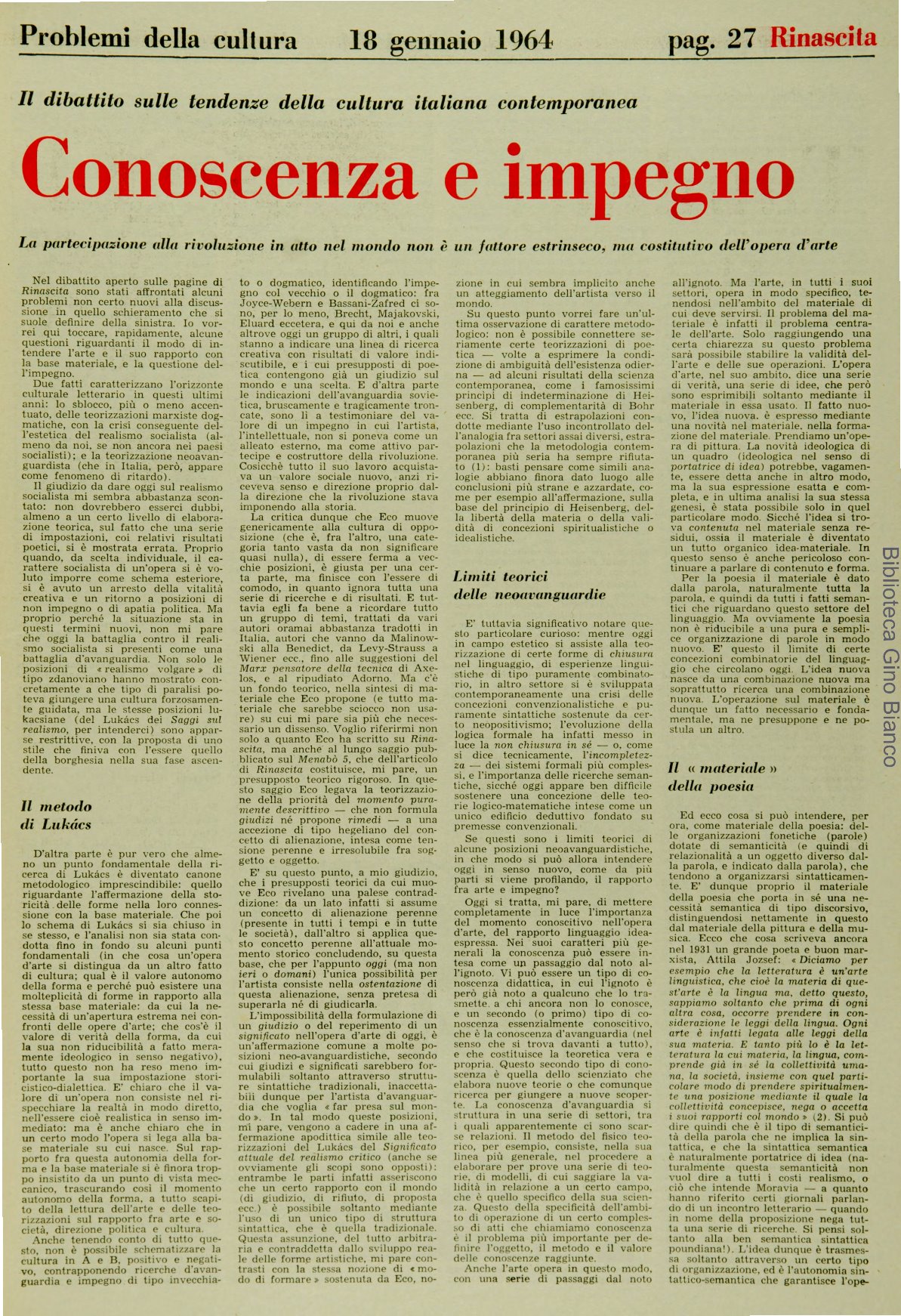
Ildibatitosule tendenzedelaculturaitalianacontemporanea
Lapartecipazionealarivoluzione inatonelmondo nonèun fatoreestrinseco,11(1costitutivodel'operad'arte
Neldibatitoapertosulepaginedi
Rinascita
sonostatiaffrontatialcuni
probleminoncertonuovialadiscus-
sioneinquelloschieramentochesi
suoledefiniredelasinistra.Iovor-
reiquitoccare,rapidamente,alcune
questioniriguardantiilmododiin-
tenderel'artee ilsuorapportocon
labasemateriale,elaquestionedel-
l'impegno. Duefatticaraterizzanol'orizzonte
culturaleletterarioinquestiultimi
anni:losblocco,piùomenoaccen-
tuato,deleteorizzazionimarxistedog-
matiche,conlacrisiconseguentedel-
l'esteticadelrealismosocialista(al-
menodanoi,senonancoraneipaesi
socialisti);elateorizzazioneneoavan-
guardista (cheinItalia,però,appare
come fenomenodiritardo).
Ilgiudiziodadareoggisulrealismo
socialistamisembraabbastanzascon-
tato:nondovrebberoessercidubbi,
almenoauncertolivelodielabora-
zione teorica,sulfatocheunaserie
di impostazioni,coirelativirisultati
poetici,sièmostrataerrata.Proprio
quando,dasceltaindividuale,ilca-
ratteresocialistadiun'operasièvo-
luto imporecomeschemaesteriore,
sièavutounarestodelavitalità
creativaeunritornoaposizionidi
non impegnoodiapatiapolitica.Ma
proprioperchélasituazionestain
questitermininuovi,nonmipare
cheoggilabatagliacontroilreali-
smo socialistasipresenticomeuna
batagliad'avanguardia.Nonsolole
posizionidi «realismovolgare»di
tipozdanovianohannomostratocon-
cretamenteachetipodiparalisipo-
tevagiungereunacultura forzosamen-
teguidata,malestesseposizionilu-
kacsiane(delLukácsdei
Saggisul
realismo,
perintenderci)sonoappar-
se restritive,conlapropostadiuno
stilechefinivacon l'esserequelo
delaborghesianellasuafaseascen-
dente.
Ilmetodo diLukács
D'altraparteèpurverochealme-
nounpunto fondamentaledelari-
cercadiLukácsèdiventatocanone
metodologico imprescindibile:quello
riguardante l'afermazionedellasto-
ricitàdeleformenelaloroconnes-
sioneconlabasemateriale.Chepoi
loschemadiLukácssisiachiusoin
se stesso,el'analisinonsiastatacon-
dottalinoinfondosualcunipunti
fondamentali(inchecosaun'opera
d'artesidistinguadaunaltrofatto
dicultura;qualèilvaloreautonomo
dela formaeperchépuòesistereuna
molteplicitàdiformeinrapportoala
stessabasemateriale:dacuilane-
cessitàdiun'aperturaestremaneicon-
frontidelleopered'arte;checos'èil
valorediveritàdellaforma,dacui
lasuanonriducibilitäafatomera-
mente ideologicoinsensonegativo),
tuttoquestononharesomeno im-
portantelasua impostazionestori-
cistico-dialetica.E'chiarocheilva-
lorediun'operanonconsistenelri-
specchiarelarealtàinmododiretto,
nel'esserecioèrealisticainsenso im-
mediato:maèanchechiarochein
uncertomodo l'operasilegaallaba-
sematerialesucuinasce.Sulrap-
portofraquestaautonomiadelafor-
ma elabasematerialesièfinora trop-
po insistitodaunpuntodivistamec-
canico, trascurandocosìilmomento
autonomodellaforma,atutoscapi-
todelaleturadel'arteedeleteo-
rizzazionisulrapportofraarteeso-
cietà,direzionepoliticaecultura.
Anche tenendocontodituttoque-
sto,nonèpossibileschematizzarela
culturainAe13,positivoenegati-
vo,contrapponendoricerched'avan-
guardiaeimpegnoditipoinvecchia-
toodogmatico, identificando l'impe-
gnocolvecchiooildogmatico:fra
Joyce-WeberneBassani-Zafredciso-
no,perlomeno,Brecht,Majakovski,
Eluardeccetera,equidanoieanche
altroveoggiungruppodialtri,iquali
stannoaindicareuna lineadiricerca
creativaconrisultatidivaloreindi-
scutibile,e icuipresuppostidipoe-
ticacontengonogiàungiudiziosul
mondoeunascelta.Ed'altraparte
le indicazionidel'avanguardiasovie-
tica,bruscamenteetragicamentetron-
cate,sonolì atestimoniaredelva-
lorediun impegnoincuil'artista,
l'intelettuale,nonsiponevacomeun
aleatoesterno,macomeattivopar-
tecipeecostruttoredelarivoluzione.
Cosicchè tuttoilsuo lavoroacquista-
vaunvaloresocialenuovo,anziri-
ceveva sensoedirezionepropriodal-
ladirezionechelarivoluzionestava
imponendoalastoria.
LacriticadunquecheEcomuove
genericamentealaculturadioppo-
sizione (cheè,fral'altro,unacate-
goriatantovastadanonsignificare
quasinula),diessere fermaavec-
chieposizioni,ègiustaperunacer-
taparte,mafiniscecon l'esseredi
comodo,inquanto ignoratuttauna
seriediricercheedirisultati.Etut-
taviaeglifabenearicordaretuto
ungruppoditemi,trattatidavari
autorioramaiabbastanzatradottiin
Italia,autorichevannodaMalinow-
skiallaBenedict,daLevy-Straussa
Wienerecc.,finoallesuggestionidel
MarxpensatoredellatecnicadiAxe-
los,ealripudiatoAdorno.Mac'è
un fondo teorico,nelasintesidima-
terialecheEcopropone(etutoma-
terialechesarebbescioccononusa-
re)sucuimiparesiapiùcheneces-
sarioundissenso.Voglioriferirminon
soloaquantoEcohascritosu
Rina-
scita,
maancheallungosaggiopub-
blicatosul
Menabò
5,chedel'articolo
di
Rinascita
costituisce,mipare,un
presupposto teoricorigoroso.Inque-
stosaggioEco legavalateorizzazio-
nedelaprioritàdel
momentopura-
mentedescritivo—chenon formula
giudizi
népropone
rimedi
—auna
acezioneditipohegelianodelcon-
cetodialienazione, intesacome ten-
sioneperenneeiresolubilefrasog-
getoeoggeto.
E'suquestopunto,amiogiudizio,
cheipresuppostiteoricidacuimuo-
veEcorivelanounapalesecontrad-
dizione:daunlatoinfattisiassume
unconcetodialienazioneperenne
(presenteintutti itempieintutte
lesocietà),dal'altrosiapplicaque-
stoconcettoperenneal'atualemo-
mentostoricoconcludendo,suquesta
base,cheper l'appunto
oggi
(manon
ieri
o
domani)
l'unicapossibilitàper
l'artistaconsistenela
ostentazione
di
questaalienazione,senzapretesadi
superarlanédigiudicarla.
L'impossibilitàdela formulazionedi
un
giudizio
odelreperimentodiun
significato
nel'operad'artedioggi,
un'afermazionecomuneamoltepo-
sizionineo-avanguardistiche,secondo
cuigiudiziesignificatisarebberofor-
mulabilisoltantoatraversostrutu-
resintatichetradizionali,inacceta-
bili p e r l'artistad'avanguar-
diachevogliaafarpresasulmon-
do,.Intalmodoquesteposizioni,
mipare,vengonoacadereinunaaf-
fermazioneapoditicasimilealeteo-
rizzazionidelLukácsdel
Significato
attualedelrealismocritico(anchese
ovviamentegliscopisonoopposti):
entrambelepartiinfattiasseriscono
cheuncertorapportoconilmondo
(digiudizio,dirifiuto,diproposta
ecc.)èpossibilesoltantomediante
Fusodiununicotipodistruttura
sintattica,cheèquelatradizionale.
Questaassunzione,deltutoarbitra-
riaecontraddetadalosvilupporea-
ledeleformeartistiche,miparecon-
trasticonlastessanozionedimo-
dodiformaressostenutadaEco,no-
zioneincuisembra implicitoanche
un atteggiamentodell'artistaversoil
mondo.Suquestapuntovorreifareun'ul-
timaosservazionedicarateremetodo-
logico:nonèpossibileconneterese-
riamentecerteteorizzazionidipoe-
tica—volteaesprimerelacondi-
zionediambiguitàdel'esistenzaodier-
na—adalcunirisultatidelascienza
contemporanea,comei famosissimi
principidiindeterminazionediHei-
senberg,dicomplementaritàdiBohr
ec.Sitrattadiestrapolazionicon-
donemediante l'uso incontrolatodel-
l'analogiafrasetoriassaidiversi,estra-
polazionichelametodologiacontem-
poraneapiùseriahasemprerifiuta-
to(1):bastipensarecomesimiliana-
logieabbianofinoradato luogoalle
conclusionipiùstraneeazzardate,co-
me peresempioal'afermazione,sula
basedelprincipiodiHeisenberg,del-
lalibertàdelamateriaodelavali-
ditàdiconcezionispiritualisticheo
idealistiche.
Limititeorici
deleneoavanguardie
E'tutaviasignificativonotareque-
stoparticolarecurioso:mentreoggi
incampoesteticosiassistealateo-
rizzazionedicerteformedi
chiusura
nel linguaggio,diesperienzelingui-
sticheditipopuramentecombinato-
rio,inaltrosetoresièsviluppata
contemporaneamenteunacrisidele
concezioniconvenzionalisticheepu-
ramentesintatichesostenutedacer-
toneopositivismo; l'evoluzionedela
logica formalehainfattimessoin
lucelanonchiusurainsé—o,come
sidicetecnicamente,
l'incompletez-
za
—deisistemiformalipiùcomples-
si,e l'importanzadelericercheseman-
tiche,sicchéoggiapparebendificile
sostenereunaconcezionedeleteo-
rie logico-matematiche intesecomeun
unicoedificiodeduttivofondatosu
premeseconvenzionali.
Sequestisonoi limititeoricidi
alcuneposizionineoavanguardistiche,
inchemodosipubaloraintendere
oggiinsensonuovo,comedapiù
partisivieneprofilando,ilrapporto
fraartee impegno?
Oggisitratta,mipare,dimetere
completamenteinlucel'importanza
delmomentoconoscitivonell'opera
d'arte,delrapporto linguaggio idea-
espressa.Neisuoicarateripiùge-
neralilaconoscenzapuòesserein-
tesacomeunpassaggiodalnotoal-
l'ignoto.Vipuòessereuntipodico-
noscenzadidattica,incuil'ignotoè
perògiànotoaqualcunochelotra-
smete.achiancoranonloconosce,
eunsecondo(oprimo)tipodico-
noscenzaessenzialmenteconoscitivo,
cheèlaconoscenzad'avanguardia(nel
sensochesitrovadavantiatutto),
echecostituiscelateoreticaverae
propria.Questosecondo tipodicono-
scenzaèquelladeloscienziatoche
elaboranuove teorieochecomunque
ricercapergiungereanuovescoper-
te.Laconoscenzad'avanguardiasi
struturainunaseriedisetori,tra
iqualiapparentementecisonoscar-
se relazioni.Ilmetododelfisicoteo-
rico,peresempio,consiste,nelasua
lineapiùgenerale,nelprocederea
elaborareperproveunaseriediteo-
rie,dimodeli,dicuisaggiarelava-
liditàinrelazioneauncertocampo,
cheèquelospecificodelasuascien-
za.Questodelaspecificitàdell'ambi-
todioperazionediuncertocomples-
sodiattichechiamiamoconoscenza
è ilproblemapiù importanteperde-
finire l'oggeto,ilmetodoeilvalore
deleconoscenze raggiunte.
Anche l'arteoperainquestomodo,
conunaseriedipassaggidalnoto
al'ignoto.Mal'arte,intutti isuoi
setori,operainmodospecifico,te-
nendosinel'ambitodelmaterialedi
cuideveservirsi.Ilproblemadelma-
terialeèinfatti ilproblemacentra-
ledel'arte.Soloraggiungendouna
certachiarezzasuquestoproblema
saràpossibilestabilirelavaliditàdel-
l'arteedelesueoperazioni.L'opera
d'arte,nelsuoambito,diceunaserie
diverità,unaseriediidee,cheperò
sonoesprimibilisoltantomedianteil
materialeinessausato.Ilfatonuo-
vo, l'ideanuova,èespressomediante
unanovitànelmateriale,nelaforma-
zionedelmateriale.Prendiamoun'ope-
radipitura.Lanovità ideologicadi
unquadro(ideologicanelsensodi
portatricediidea)potrebbe,vagamen-
te,esseredetaancheinaltromodo,
ma lasuaespressioneesataecom-
pleta,einultimaanalisilasuastessa
genesi,èstatapossibilesoloinquel
particolaremodo.Sicché l'ideasitro-
va
contenuta
nelmaterialesenzare-
sidui,ossiailmaterialeèdiventato
un tuttoorganico idea-materiale.In
questo sensoèanchepericolosocon-
tinuareaparlaredicontenutoeforma.
Perlapoesiailmaterialeèdato
dalaparola,naturalmentetuttala
parola,equindidatuttiifattiseman-
ticicheriguardanoquestosetoredel
linguaggio.Maovviamentelapoesia
nonèriducibileaunapuraesempli-
ceorganizzazionediparoleinmodo
nuovo.E'questoil limitedicerte
concezionicombinatoriedellinguag-
giochecircolanooggi.L'ideanuova
nascedaunacombinazionenuovama
sopratuttoricercaunacombinazione
nuova.L'operazionesulmaterialeè
dunqueunfattonecessarioefonda-
mentale,manepresupponeenepo-
stulaunaltro.
Il«materiale)
delapoesia
Ed eccocosasipuò intendere,per
ora,comematerialedelapoesia:del-
leorganizzazionifonetiche(parole)
dotatedisemanticitä(equindidi
relazionalitäaunoggettodiversodal-
laparola,eindicatodalaparola),che
tendonoaorganizzarsisintaticamen-
te.E'dunqueproprioilmateriale
delapoesiacheportainséunane-
cessitàsemanticaditipodiscorsivo,
distinguendosinetamenteinquesto
dalmaterialedelapituraedelamu-
sica.Eccochecosascrivevaancora
nel1931ungrandepoetaebuonmar-
xista,AttilaJozsef:«
Diciamoper
esempiochelaletteraturaèun'arte
linguistica,checioèlamateriadique-
st'arteèlalinguama,detoquesto,
sapiamosoltantocheprimadiogni
altracosa,occoreprendereincon-
siderazioneleleggidelalingua.Ogni
arteèinfattilegataalleleggidela
suamateria.Etantopiùloèlalet-
teraturalacuimateria,lalingua,com-
prendegiàinsélacolettivitàuma-
na,lasocietà, insiemeconquelparti-
colaremododiprenderespiritualmen-
teunaposizionemedianteilqualela
colletivitàconcepisce,negaoacceta
i
suoi
rapporti
col
mondo I.(2).Sipuò
direquindicheèiltipodisemantici-
tädellaparolachene implicalasin-
tatica,echelasintaticasemantica
ènaturalmenteportatricediidea(na-
turalméntequestasemanticitänon
vuoldireatutti icostirealismo,o
ciòche intendeMoravia—aquanto
hannoriferitocertigiornaliparlan-
dodiun incontro letterario—quando
innomedelaproposizionenegatut-
taunaseriediricerche.Sipensisol-
tantoallabensemanticasintattica
poundiana!).L'ideadunqueètrasmes-
sasoltantoatraversouncertotipo
diorganizzazione,edè l'autonomiasin-
tattico-semanticachegarantisce l'ope-
















