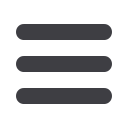
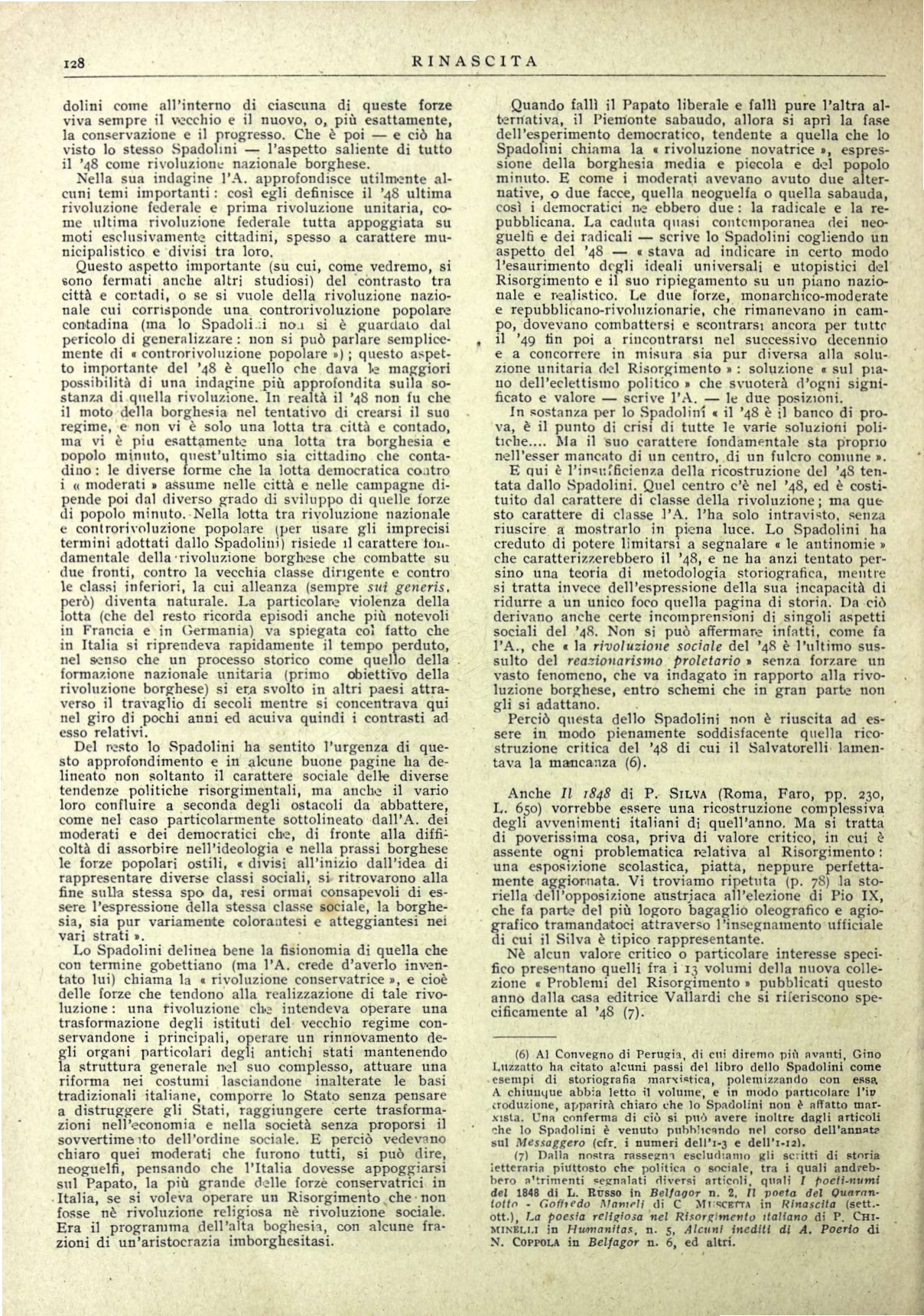
128
RINASCITA
dolinicomeall'internodiciascunadiquesteforze
vivasempreilvecchioe ilnuovo,o,piùesatamente,
laconservazionee ilprogresso.Cheèpoi—eciòha
vistolostessoSpadolini—l'aspettosalientedi tutto
il '48comerivoluzionenazionaleborghese.
Nelasuaindaginel'A.approfondisceutilmenteal-
cunitemiimportanti:cosìeglidefinisceil '48ultima
rivoluzionefederaleeprimarivoluzioneunitaria,co-
meultimarivoluzionefederaletuttaappoggiatasu
motiesclusivamentecittadini,spessoacaratteremu-
nicipalisticoedivisi traloro.
Questoaspettoimportante(sucui,comevedremo,si
sonofermatianchealtristudiosi)del'cóntrastotra
cittàecortadi,osesivuoledellarivoluzionenazio-
nalecuicorrispondeunacontrorivoluzionepopolare
contadina(ma loSpadoli.:inoi si èguardatodal
pericolodigeneralizzare:nonsipuòparlaresemplice-
mentedi«controrivoluzionepopolare»);questoaspet-
toimportantedel '48èquellochedavalemaggiori
possibilitàdiunaindagine.piùapprofonditasullaso-
stanzadiquelarivoluzione.Inrealtàil '48nonfuche
ilmotodellaborghesianeltentativodicrearsi ilsuo
regime,enonvi èsolounalottatracittàecontado,
mavi è piaesatamenteunalotta traborghesiae
Popolominuto,quest'ultimosiacittadinocheconta-
dino:lediverseformechelalottademocraticacoutro
i«moderati»assumenellecittàenellecampagnedi-
pendepoidaldiversogradodisviluppodiqueleforze
dipopolominuto.-Nellalottatrarivoluzionenazionale
econtrorivoluzionepopolare(perUsaregli imprecisi
terminiadottatidaloSpadolini)risiedeilcarattereJou-
damentaledella'rivoluzioneborghesechecombattesu
duefronti,controlavecchiaclassedirigenteecontro
leclassiinferiori, lacuialeanza(sempre
suigeneris.
però)diventanaturale.Laparticolareviolenzadella
lotta(chedelrestoricordaepisodianchepiùnotevoli
inFranciae inGermania)vaspiegatacolfattoche
inItaliasiriprendevarapidamenteil tempoperduto,
nelsensocheunprocessostoricocomequellodella
formazionenazionaleunitaria(primoobiettivodella
rivoluzioneborghese)sierasvoltoinaltripaesiattra-
versoil travagliodisecolimentresiconcentravaqui
nelgirodipochianniedacuivaquindi icontrastiad
essorelativi.
DelrestoloSpadolinihasentitol'urgenzadique-
stoapprofondimentoe inalcunebuonepaginehade-
lineatononsoltanto il caratteresocialedellediverse
tendenzepoliticherisorgimentali,maanche il vario
loroconfluireasecondadegliostacolidaabbattere,
comenelcasoparticolarmentesottolineatodall'A.dei
moderatie deidemocraticiche, di frontealladiffi:-
coltàdiassorbirenell'ideologiaenellaprassiborghese
leforzepopolariostili, «divisiall'iniziodall'ideadi
rappresentarediverseclassisociali,siritrovaronoalla
finesulastessaspoda,resiormaiconsapevolidies-
serel'espressionedellastessaclassesociale,laborghe-
sia,siapurvariamentecoloraatesieatteggiantesinei
varistratiD.
LoSpadolinidelineabenelafisionomiadiquellache
conterminegobetiano(mal'A.creded'averloinven-
tatolui)chiamala«rivoluzioneconservatrice»,ecioè
deleforzechetendonoallarealizzazionedi talerivo-
luzione:unarivoluzionecheintendevaoperareuna
trasformazionedegli istitutidelvecchioregimecon-
servandonei principali,operareunrinnovamentode-
gliorganiparticolaridegliantichistatimantenendo
lastrutturageneralenelsuocomplesso,attuareuna
riformaneicostumilasciandoneinalterate le basi
tradizionaliitaliane,comporeloStatosenzapensare
adistruggeregli Stati,raggiungerecertetrasforma-
zioninel'economiaenellasocietàsenzaproporsi il
sovvertimeItodell'ordinesociale. Eperciòvedevano
chiaroqueimoderatichefuronotutti, sipuòdire,
neoguelfi,pensandochel'Italiadovesseappoggiarsi
sulPapato,lapiùgrandedelleforzeconservatriciin
Italia,sesivolevaoperareunRisorgimen'to,che•non
fossenérivoluzionereligiosanérivoluzionesociale.
Erailprogrammadell'altaboghesia,conalcunefra-
zionidiun'aristocraziaimborghesitasi.
Quandofallì ilPapatoliberaleefallìpurel'altraal-
ternativa, il Pieniontesabaudo,allorasiaprì lafase
del'esperimentodemocratico,tendenteaquellachelo
Spadolinichiamala «rivoluzionenovatrice»,espres-
sionedellaborghesiamediaepiccolae delpopolo
minuto.Ecomeimoderatiavevanoavutoduealter-
native,oduefacce,quelaneoguelfaoquelasabauda,
cosìi democraticineebberodue: laradicalee lare-
pubblicana.Lacadutaquasicontemporaneadeineo-
guelfiedeiradicali—scriveloSpadolinicogliendoun
aspetodel '48—«stavaadindicareincertomodo
l'esaurimentodegliidealiuniversali eutopisticidel
Risorgimentoeilsuoripiegamentosuunpianonazio-
naleerealistico.Ledueforze,monarchico-moderate
erepubblicano-rivoluzionarie,cherimanevanoincam-
po,dovevanocombatersiescontrarsiancorapertutte
il '49 finpoi arincontrarsinelsuccessivodecennio
eaconcorrereinmisurasiapurdiversaallasolu-
zioneunitariadelRisorgimento»:soluzione«sulpia-
nodel'eclettismopolitico»chesvuoteràd'ognisigni-
ficatoevalore—scrivel'A.—ledueposizioni.
InsostanzaperloSpadolini«il '48èilbancodipro-
va,è ilpuntodicrisidi tuttelevariesoluzionipoli-
tiche...Ma il suocaratterefondamentalestaproprio
nel'essermancatodiuncentro,diunfulcrocomune».
E(luièl'insufficienzadelaricostruzionedel'48ten-
tatadaloSpadolini.Quelcentroc'ènel'48,edècosti-
tuitodalcaratterediclassedellarivoluzione;maque-
stocaratterediclassel'A. l'hasolointravisto,senza
riuscireamostrarloinpienaluce.LoSpadoliniha
credutodipoterelimitarsiasegnalare«leantinomie»
checaraterizzerebberoil '48,enehaanzitentatoper-
sinounateoriadimetodologiastoriografica,mentre
sitrattainvecedel'espressionedellasuaincapacitàdi
ridurreaununicofocoquelapaginadistoria.Daciò
derivanoanchecerteincomprensionidisingoliaspetti
socialidel'48.Nonsipuòaffermareinfatti,comefa
l'A.,che«la
rivoluzionesociale
del'48èl'ultimosus-
sultodel
reazionarismoproletario
»senzaforzareun
vastofenomeno,chevaindagatoinrapportoallarivo-
luzioneborghese,entroschemicheingranpartenon
glisiadatano.
PerciòquestadelloSpadolininonèriuscitaades-
sereinmodopienamentesoddisfacentequellarico-
struzionecriticadel '48di cui il Salvatorelilamen-
tavalamancanza(6).
AncheIl
1848
di P. SILVA(Roma,Faro,pp.230,
L.650)vorrebbeessereunaricostruzionecomplessiva
degliavvenimentiitalianidiquel'anno.Masi tratta
dipoverissimacosa,privadivalorecritico, incui è
assenteogniproblematicarelativaalRisorgimento:
unaesposizionescolastica,piatta,neppureperfetta-
menteaggiornata.Vitroviamoripetuta(p.78) lasto-
rielladel'opposizioneaustrjacaal'elezionediPioIX,
chefapartedelpiùlogorobagagliooleograficoeagio-
graficotramandatociattraversol'insegnamentoufficiale
dicui ilSilvaètipicorappresentante.
Nèalcunvalorecriticooparticolareinteressespeci-
ficopresentanoquellifra i13volumidellanuovacole-
zione«ProblemidelRisorgimento»pubblicatiquesto
annodallacasaeditriceVallardichesiriferisconospe-
cificamenteal'48(7).
(6)AlConvegnodiPerugia,dicuidiremopiAavanti,Gino
'Aizzanohacitatoalcunipassidel librodelloSpadolinicome
.esempi di storiografiamarxistica,polemizzandoconessa
AchiunqueabWaletto il volume,e inmodoparticolarel'in
croduzione,appariràchiarocheloSpadolininonèaffattomar-
xista.Unaconfermadi ciòsipuòavereinoltredagliarticoli
•che loSpadolini èvenutopubblicandonelcorsodell'annatr
sul
Messaggero
(cfr. i numeridell'i-3 edell'i-12).
(7)Dallanostrarassegniescludiamogli scritti di storia
letterariapitittostochepoliticaosociale, tra i qualiandreb-
beroaltrimenticegnalatidiversiarticoli,quali I
poeti-numi
del1848di L.Russoin
Belfagor
n. 2,
11poetadelQuaran-
totto - GoffiedoMorrei' di CMURCETTAinRinascita(sett.-
ott.),Lapoesiareligiosa'nelRisorgimentoitalianodi P. CHI-
MINEL.I.IinHufmanilas,n. 5,Alcuni inediti di A.Poeriodi
N.COPPOLAin
Belfagor
n. 6, edaltri.
















