
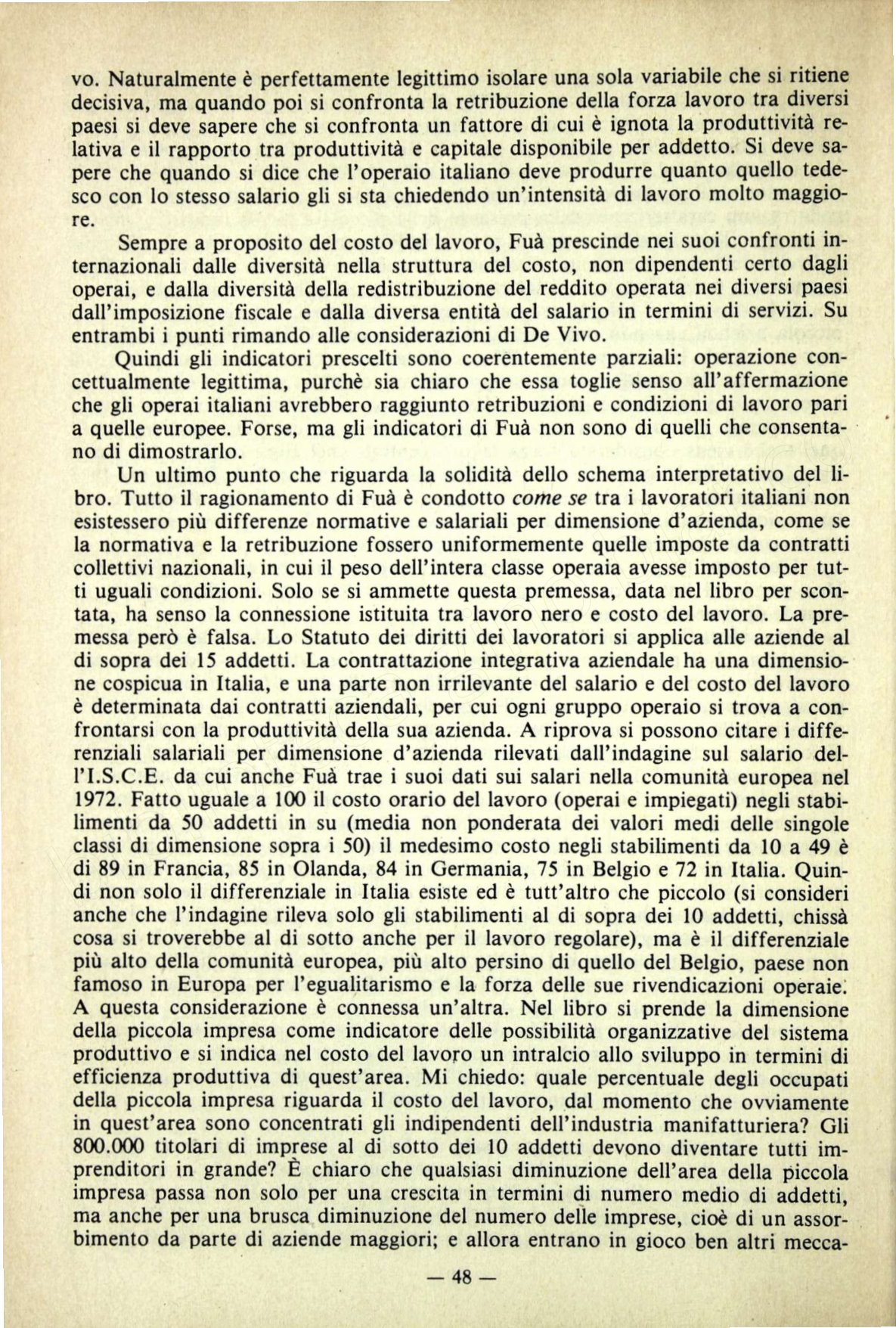
vo. Naturalmente è perfettamente legittimo isolare una sola variabile che si ritiene
decisiva, ma quando poi si confronta la retribuzione della forza lavoro tra diversi
paesi si deve sapere che si confronta un fattore di cui è ignota la produttività re-
lativa e il rapporto tra produttività e capitale disponibile per addetto. Si deve sa-
pere che quando si dice che l'operaio italiano deve produrre quanto quello tede-
scocon lo stesso salario gli si sta chiedendo un'intensità di lavoro molto maggio-
re.
Sempre a proposito del costo del lavoro, Fuà prescinde nei suoi confronti in-
ternazionali dalle diversità nella struttura del costo, non dipendenti certo dagli
operai, e dalla diversità della redistribuzione del reddito operata nei diversi paesi
dall'imposizione fiscale e dalla diversa entità del salario in termini di servizi. Su
entrambi i punti rimando alle considerazioni di De Vivo.
Quindi gli indicatori prescelti sono coerentemente parziali: operazione con-
cettualmente legittima, purchè sia chiaro che essa toglie senso all'affermazione
che gli operai italiani avrebbero raggiunto retribuzioni e condizioni di lavoro pari
aquelle europee. Forse, ma gli indicatori di Fuà non sono di quelli che consenta-
no di dimostrarlo.
Un ultimo punto che riguarda la solidità dello schema interpretativo del li-
bro. Tutto il ragionamento di Fuà è condotto
come se tra
i lavoratori italiani non
esistessero più differenze normative e salariali per dimensione d'azienda, come se
la normativa e la retribuzione fossero uniformemente quelle imposte da contratti
collettivi nazionali, in cui il peso dell'intera classe operaia avesse imposto per tut-
ti uguali condizioni. Solo se si ammette questa premessa, data nel libro per scon-
tata, ha senso la connessione istituita tra lavoro nero e costo del lavoro. La pre-
messaperò è falsa. Lo Statuto dei diritti dei lavoratori si applica alle aziende al
di sopra dei 15 addetti. La contrattazione integrativa aziendale ha una dimensio-
necospicua in Italia, e una parte non irrilevante del salario e del costo del lavoro
èdeterminata dai contratti aziendali, per cui ogni gruppo operaio si trova a con-
frontarsi con la produttività della sua azienda. A riprova si possono citare i diffe-
renziali salariali per dimensione d'azienda rilevati dall'indagine sul salario del-
l'I.S.C.E. da cui anche Fuà trae i suoi dati sui salari nella comunità europea nel
1972. Fatto uguale a 100 il costo orario del lavoro (operai e impiegati) negli stabi-
limenti da 50 addetti in su (media non ponderata dei valori medi delle singole
classi di dimensione sopra i 50) il medesimo costo negli stabilimenti da 10 a 49 è
di 89 in Francia, 85 in Olanda, 84 in Germania, 75 in Belgio e 72 in Italia. Quin-
di non solo il differenziale in Italia esiste ed è tutt'altro che piccolo (si consideri
anche che l'indagine rileva solo gli stabilimenti al di sopra dei 10 addetti, chissà
cosa si troverebbe al di sotto anche per il lavoro regolare), ma è il differenziale
più alto della comunità europea, più alto persino di quello del Belgio, paese non
famoso in Europa per l'egualitarismo e la forza delle sue rivendicazioni operaie.
A questa considerazione è connessa un'altra. Nel libro si prende la dimensione
della piccola impresa come indicatore delle possibilità organizzative del sistema
produttivo e si indica nel costo del lavoro un intralcio allo sviluppo in termini di
efficienza produttiva di quest'area. Mi chiedo: quale percentuale degli occupati
della piccola impresa riguarda il costo del lavoro, •dal momento che ovviamente
in quest'area sono concentrati gli indipendenti dell'industria manifatturiera? Gli
800.000 titolari di imprese al di sotto dei 10 addetti devono diventare tutti im-
prenditori in grande? È chiaro che qualsiasi diminuzione dell'area della piccola
impresapassa non solo per una crescita in termini di numero medio di addetti,
maanche per una brusca diminuzione del numero delle imprese, cioè di un assor-
bimento da parte di aziende maggiori; e allora entrano in gioco ben altri mecca-
48
















