
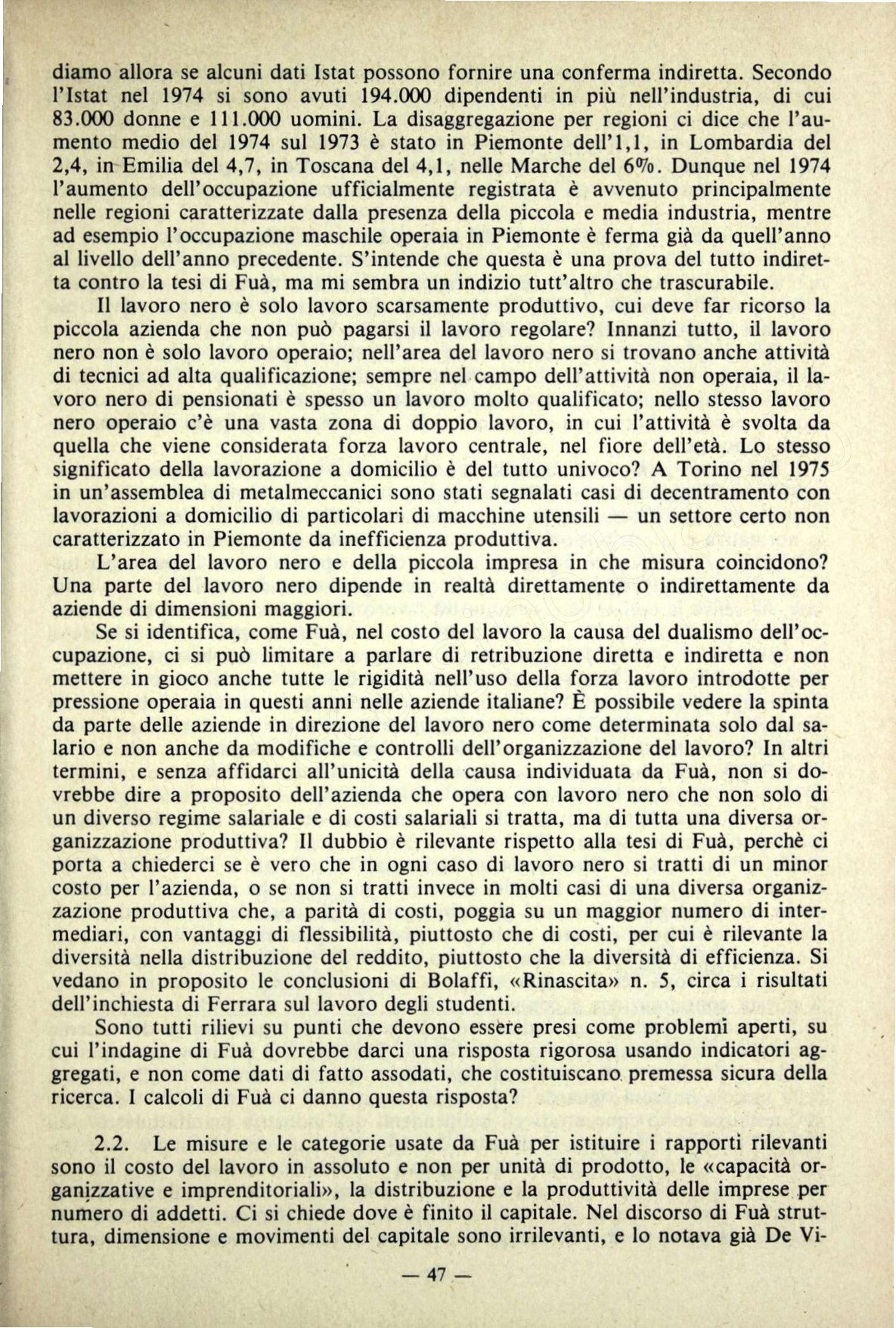
diamo allora se alcuni dati Istat possono fornire una conferma indiretta. Secondo
l'Istat nel 1974 si sono avuti 194.000 dipendenti in più nell'industria, di cui
83.000 donne e 111.000 uomini. La disaggregazione per regioni ci dice che l'au-
mento medio del 1974 sul 1973 è stato in Piemonte dell'1,1, in Lombardia del
2,4, in Emilia del 4,7, in Toscana del 4,1, nelle Marche del 607o. Dunque nel 1974
l'aumento dell'occupazione ufficialmente registrata è avvenuto principalmente
nelle regioni caratterizzate dalla presenza della piccola e media industria, mentre
adesempio l'occupazione maschile operaia in Piemonte è ferma già da quell'anno
al livello dell'anno precedente. S'intende che questa è una prova del tutto indiret-
ta contro la tesi di Fuà, ma mi sembra un indizio tutt'altro che trascurabile.
Il lavoro nero è solo lavoro scarsamente produttivo, cui deve far ricorso la
piccola azienda che non può pagarsi il lavoro regolare? Innanzi tutto, i l lavoro
nero non è solo lavoro operaio; nell'area del lavoro nero si trovano anche attività
di tecnici ad alta qualificazione; sempre nel campo dell'attività non operaia, il la-
voro nero di pensionati è spesso un lavoro molto qualificato; nello stesso lavoro
nero operaio c'è una vasta zona di doppio lavoro, in cui l'attività è svolta da
quella che viene considerata forza lavoro centrale, nel fiore dell'età. Lo stesso
significato della lavorazione a domicilio è del tutto univoco? A Torino nel 1975
in un'assemblea di metalmeccanici sono stati segnalati casi di decentramento con
lavorazioni a domicilio di particolari di macchine utensili — un settore certo non
caratterizzato in Piemonte da inefficienza produttiva.
L'area del lavoro nero e della piccola impresa in che misura coincidono?
Una parte del lavoro nero dipende in realtà direttamente o indirettamente da
aziende di dimensioni maggiori.
Sesi identifica, come Fuà, nel costo del lavoro la causa del dualismo dell'oc-
cupazione, ci si può limitare a parlare di retribuzione diretta e indiretta e non
mettere in gioco anche tutte le rigidità nell'uso della forza lavoro introdotte per
pressione operaia in questi anni nelle aziende italiane? È possibile vedere la spinta
da parte delle aziende in direzione del lavoro nero come determinata solo dal sa-
lario e non anche da modifiche e controlli dell'organizzazione del lavoro? In altri
termini, e senza affidarci all'unicità della causa individuata da Fuà, non si do-
vrebbe dire a proposito dell'azienda che opera con lavoro nero che non solo di
undiverso regime salariale e di costi salariali si tratta, ma di tutta una diversa or-
ganizzazione produttiva? I l dubbio è rilevante rispetto alla tesi di Fuà, perchè ci
porta a chiederci se è vero che in ogni caso di lavoro nero si tratti di un minor
costo per l'azienda, o se non si tratti invece in molti casi di una diversa organiz-
zazione produttiva che, a parità di costi, poggia su un maggior numero di inter-
mediari, con vantaggi di flessibilità, piuttosto che di costi, per cui è rilevante la
diversità nella distribuzione del reddito, piuttosto che la diversità di efficienza. Si
vedano in proposito le conclusioni di Bolaffi, «Rinascita» n. 5, circa i risultati
dell'inchiesta di Ferrara sul lavoro degli studenti.
Sono tutti rilievi su punti che devono essere presi come problemi aperti, su
cui l'indagine di Fuà dovrebbe darci una risposta rigorosa usando indicatori ag-
gregati, e non come dati di fatto assodati, che costituiscano. premessa sicura della
ricerca. I calcoli di Fuà ci danno questa risposta?
2.2. L e misure e le categorie usate da Fuà per istituire i rapporti rilevanti
sono il costo del lavoro in assoluto e non per unità di prodotto, le «capacità or-
ganizzative e imprenditoriali», la distribuzione e la produttività delle imprese per
numero di addetti. Ci si chiede dove è finito il capitale. Nel discorso di Fuà strut-
tura, dimensione e movimenti del capitale sono irrilevanti, e lo notava già De Vi-
47 - .
















