
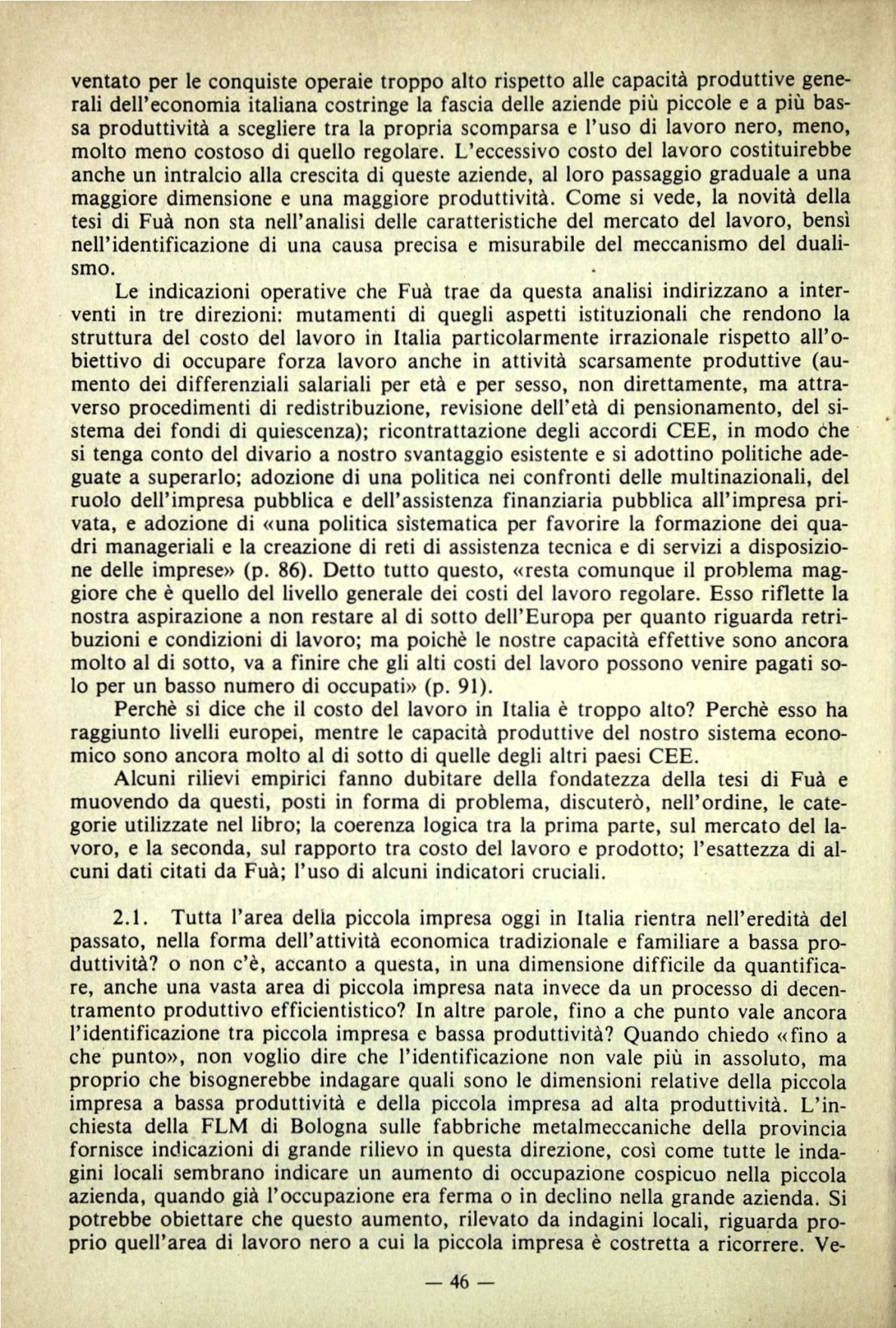
ventato per le conquiste operaie troppo alto rispetto alle capacità produttive gene-
rali dell'economia italiana costringe la fascia delle aziende più piccole e a più bas-
saproduttività a scegliere tra la propria scomparsa e l'uso di lavoro nero, meno,
molto meno costoso di quello regolare. L'eccessivo costo del lavoro costituirebbe
anche un intralcio alla crescita di queste aziende, al loro passaggio graduale a una
maggiore dimensione e una maggiore produttività. Come si vede, la novità della
tesi di Fuà non sta nell'analisi delle caratteristiche del mercato del lavoro, bensì
nell'identificazione di una causa precisa e misurabile del meccanismo del duali-
smo.
•
Le indicazioni operative che Fuà trae da questa analisi indirizzano a inter-
venti in tre direzioni: mutamenti di quegli aspetti istituzionali che rendono la
struttura del costo del lavoro in Italia particolarmente irrazionale rispetto all'o-
biettivo di occupare forza lavoro anche in attività scarsamente produttive (au-
mento dei differenziali salariali per età e per sesso, non direttamente, ma attra-
verso procedimenti di redistribuzione, revisione dell'età di pensionamento, del si-
stema dei fondi di quiescenza); ricontrattazione degli accordi CEE, in modo Che
si tenga conto del divario a nostro svantaggio esistente e si adottino politiche ade-
guate a superarlo; adozione di una politica nei confronti delle multinazionali, del
ruolo dell'impresa pubblica e dell'assistenza finanziaria pubblica all'impresa pri-
vata, e adozione di «una politica sistematica per favorire la formazione dei qua-
dri manageriali e la creazione di reti di assistenza tecnica e di servizi a disposizio-
nedelle imprese» (p. 86). Detto tutto questo, «resta comunque il problema mag-
giore che è quello del livello generale dei costi del lavoro regolare. Esso riflette la
nostra aspirazione a non restare al di sotto dell'Europa per quanto riguarda retri-
buzioni e condizioni di lavoro; ma poiché le nostre capacità effettive sono ancora
molto al di sotto, va a finire che gli alti costi del lavoro possono venire pagati so-
lo per un basso numero di occupati» (p. 91).
Perché si dice che il costo del lavoro in Italia è troppo alto? Perché esso ha
raggiunto livelli europei, mentre le capacità produttive del nostro sistema econo-
mico sono ancora molto al di sotto di quelle degli altri paesi CEE.
Alcuni rilievi empirici fanno dubitare della fondatezza della tesi di Fuà e
muovendo da questi, posti in forma di problema, discuterò, nell'ordine, le cate-
gorie utilizzate nel libro; la coerenza logica tra la prima parte, sul mercato del la-
voro, e la seconda, sul rapporto tra costo del lavoro e prodotto; l'esattezza di al-
cuni dati citati da Fuà, l'uso di alcuni indicatori cruciali.
2.1. Tu t t a l'area della piccola impresa oggi in Italia rientra nell'eredità del
passato, nella forma dell'attività economica tradizionale e familiare a bassa pro-
duttività? o non c'è, accanto a questa, in una dimensione difficile da quantifica-
re, anche una vasta area di piccola impresa nata invece da un processo di decen-
tramento produttivo efficientistico? In altre parole, fino a che punto vale ancora
l'identificazione tra piccola impresa e bassa produttività? Quando chiedo «fino a
che punto», non voglio dire che l'identificazione non vale più in assoluto, ma
proprio che bisognerebbe indagare quali sono le dimensioni relative della piccola
impresa a bassa produttività e della piccola impresa ad alta produttività. L'in-
chiesta della FLM di Bologna sulle fabbriche metalmeccaniche della provincia
fornisce indicazioni di grande rilievo in questa direzione, così come tutte le inda-
gini locali sembrano indicare un aumento di occupazione cospicuo nella piccola
azienda, quando già l'occupazione era ferma o in declino nella grande azienda. Si
potrebbe obiettare che questo aumento, rilevato da indagini locali, riguarda pro-
prio quell'area di lavoro nero a cui la piccola impresa è costretta a ricorrere. Ve-
- 4 6
















