
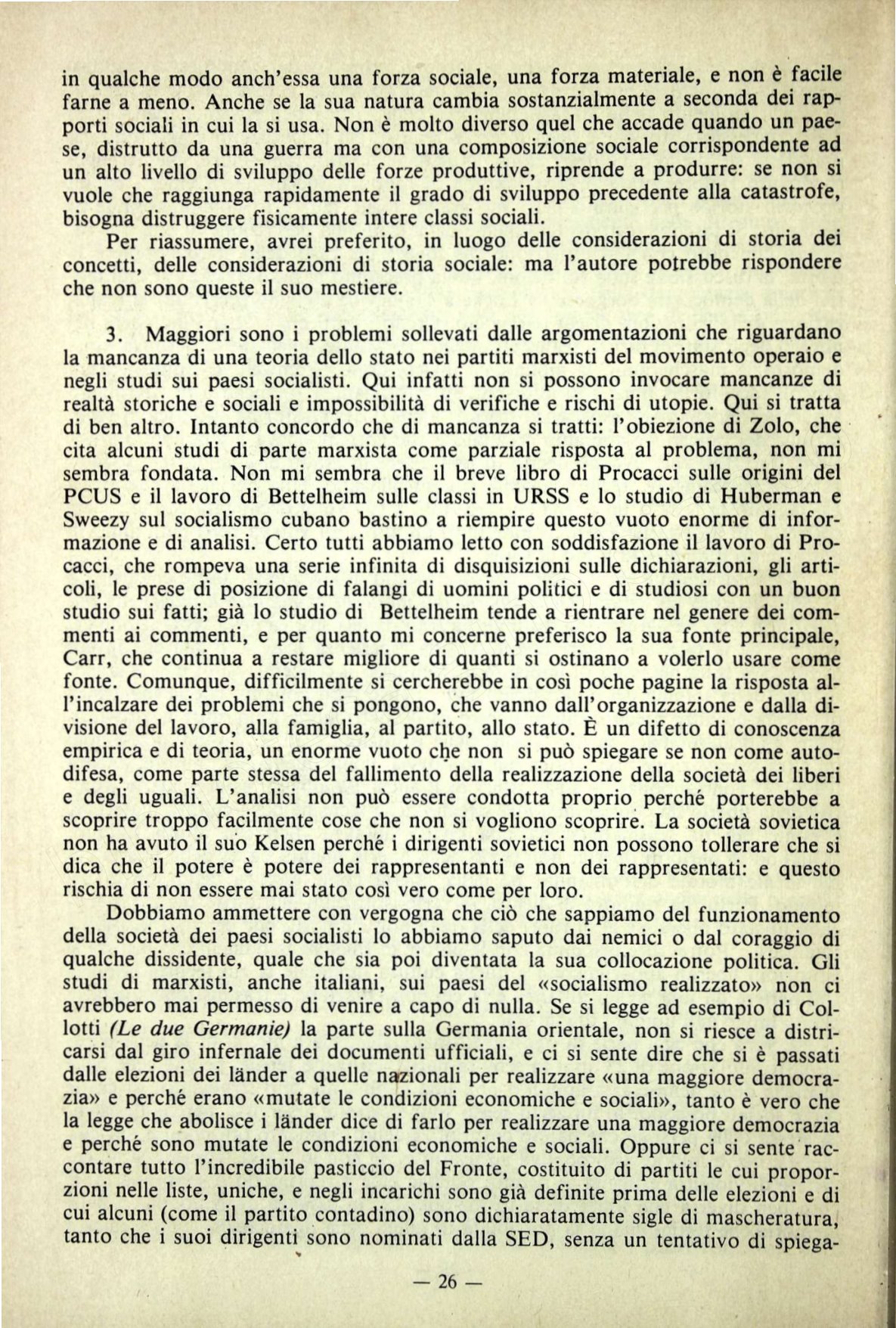
in qualche modo anch'essa una forza sociale, una forza materiale, e non è facile
farne a meno. Anche se la sua natura cambia sostanzialmente a seconda dei rap-
porti sociali in cui la si usa. Non è molto diverso quel che accade quando un pae-
se, distrutto da una guerra ma con una composizione sociale corrispondente ad
un alto livello di sviluppo delle forze produttive, riprende a produrre: se non si
vuole che raggiunga rapidamente il grado di sviluppo precedente alla catastrofe,
bisognadistruggere fisicamente intere classi sociali.
Per riassumere, avrei preferito, in luogo delle considerazioni di storia dei
concetti, delle considerazioni di storia sociale: ma l'autore potrebbe rispondere
chenon sono queste il suomestiere.
3. Maggiori sono i problemi sollevati dalle argomentazioni che riguardano
lamancanza di una teoria dello stato nei partiti marxisti del movimento operaio e
negli studi sui paesi socialisti. Qui infatti non si possono invocare mancanze di
realtà storiche e sociali e impossibilità di verifiche e rischi di utopie. Qui si tratta
di ben altro. Intanto concordo che di mancanza si tratti: l'obiezione di Zolo, che
cita alcuni studi di parte marxista come parziale risposta al problema, non mi
sembra fondata. Non mi sembra che il breve libro di Procacci sulle origini del
PCUS e il lavoro di Bettelheim sulle classi in URSS e lo studio di Huberman e
Sweezy sul socialismo cubano bastino a riempire questo vuoto enorme di infor-
mazione e di analisi. Certo tutti abbiamo letto con soddisfazione il lavoro di Pro-
cacci, che rompeva una serie infinita di disquisizioni sulle dichiarazioni, gli arti-
coli, le prese di posizione di falangi di uomini politici e di studiosi con un buon
studio sui fatti; già lo studio di Bettelheim tende a rientrare nel genere dei com-
menti ai commenti, e per quanto mi concerne preferisco la sua fonte principale,
Carr, che continua a restare migliore di quanti si ostinano a volerlo usare come
fonte. Comunque, difficilmente si cercherebbe in così poche pagine la risposta al-
l'incalzare dei problemi che si pongono, che vanno dall'organizzazione e dalla di-
visione del lavoro, alla famiglia, al partito, allo stato. È un difetto di conoscenza
empirica e di teoria, un enorme vuoto che non si può spiegare se non come auto-
difesa, come parte stessa del fallimento della realizzazione della società dei liberi
edegli uguali. L'analisi non può essere condotta proprio perché porterebbe a
scoprire troppo facilmente cose che non si vogliono scoprire'. La società sovietica
non ha avuto il subKelsen perché i dirigenti sovietici non possono tollerare che si
dica che il potere è potere dei rappresentanti e non dei rappresentati: e questo
rischia di non esseremai stato così vero come per loro.
Dobbiamo ammettere con vergogna che ciò che sappiamo del funzionamento
della società dei paesi socialisti lo abbiamo saputo dai nemici o dal coraggio di
qualche dissidente, quale che sia poi diventata la sua collocazione politica. Gl i
studi di marxisti, anche italiani, sui paesi del «socialismo realizzato» non ci
avrebbero mai permesso di venire a capo di nulla. Se si legge ad esempio di Col-
lotti
(Le due Germanie)
la parte sulla Germania orientale, non si riesce a distri-
carsi dal giro infernale dei documenti ufficiali, e ci si sente dire che si è passati
dalle elezioni dei lander a quelle nazionali per realizzare «una maggiore democra-
zia» e perché erano «mutate le condizioni economiche e sociali», tanto è vero che
la legge che abolisce i lander dice di farlo per realizzare una maggiore democrazia
eperché sono mutate le condizioni economiche e sociali. Oppure ci si sente• rac-
contare tutto l'incredibile pasticcio del Fronte, costituito di partiti le cui propor-
zioni nelle liste, uniche, e negli incarichi sono già definite prima delle elezioni e di
cui alcuni (come il partito contadino) sono dichiaratamente sigle di mascheratura,
tanto che i suoi dirigenti sono nominati dalla SED, senza un tentativo di spiega-
.
26—
















