
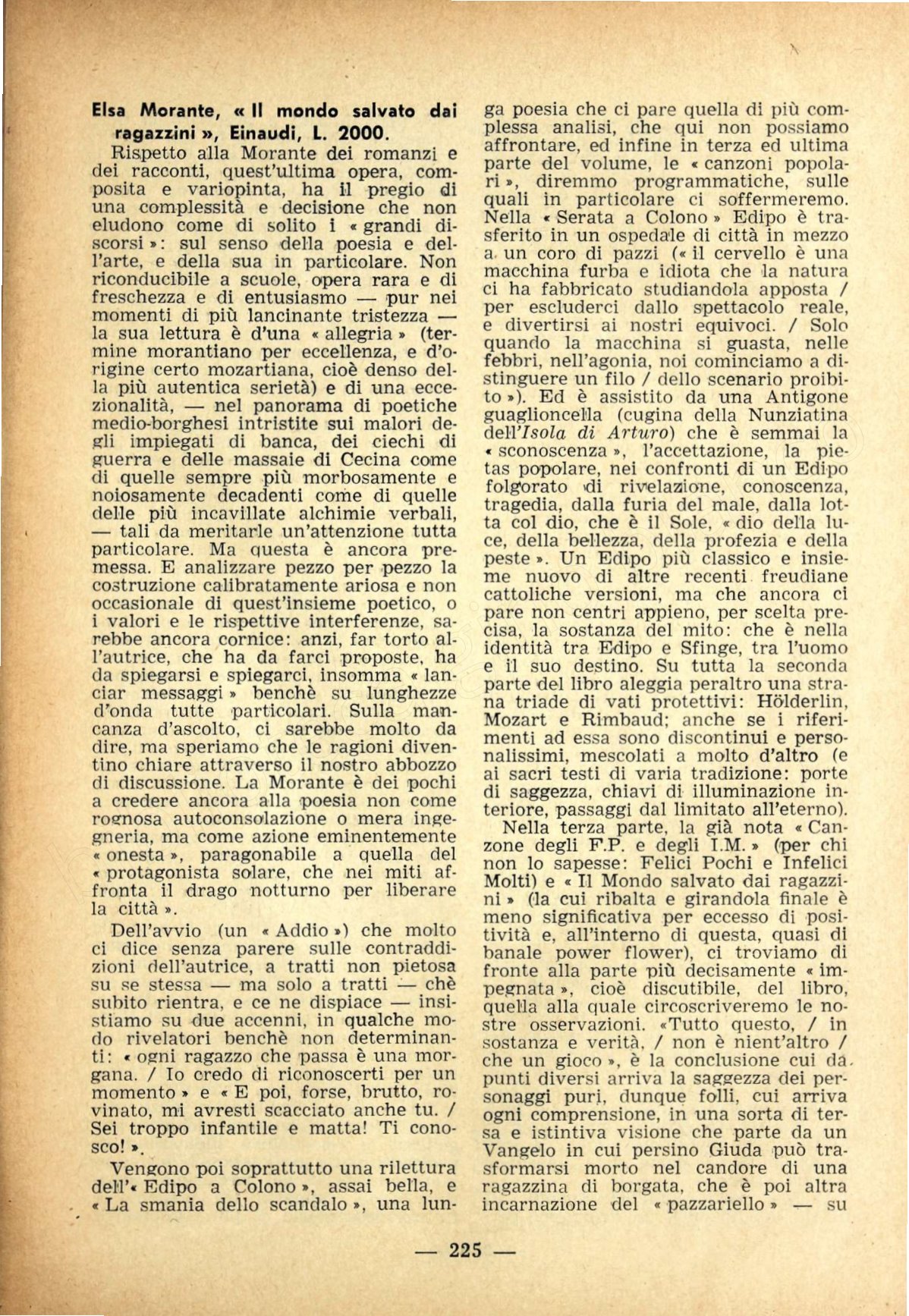
e
Elsa Morante, cc Il mondo salvato da i
ragazzini », Einaudi, L. 2000.
Rispetto al la Morante dei romanzi e
dei racconti, quest'ultima opera, coma
posita e variopinta, h a 11 pregio d i
una complessità e decisione che non
eludono come d i solito i e grandi di -
scorsi »: su l senso della poesia e del-
l'arte, e della sua i n particolare. Non
riconducibile a scuole, opera rara e di
freschezza e di entusiasmo — pur nei
momenti di più lancinante tristezza
la sua lettura è d'una « allegria » ( ter-
mine morantiano per eccellenza, e d'o-
rigine certo mozartiana, cioè denso del-
la più autentica serietà) e di una ecce-
zionalità, — nel panorama di poetiche
medio-borghesi intristite sui malori de-
gli impiegati d i banca, de i ciechi d i
guerra e delle massaie di Cecina come
di quelle sempre più morbosamente e
noiosamente decadenti come d i quelle
delle p i ù incavillate alchimie verbali,
tali da meritarle un'attenzione tutta
particolare. M a questa è ancora pre-
messa. E analizzare pezzo per pezzo la
costruzione calibratamente ariosa e non
occasionale d i quest'insieme poetico, o
i valori e le rispettive interferenze, sa-
rebbe ancora cornice: anzi, far torto al-
l'autrice, che ha da farci proposte, ha
da spiegarsi e spiegarci, insomma e lan-
ciar messaggi» benchè s u lunghezze
d'onda t u t t e particolari. Su l l a man -
canza d'ascolto, c i sarebbe mol to d a
dire, ma speriamo che le ragioni diven-
tino chiare attraverso i l nostro abbozzo
di discussione. La Morante è dei pochi
a credere ancora alla poesia non come
rognosa autoconsalazione o mera inge-
gneria, ma come azione eminentemente
«onesta », paragonabile a quel la de l
eprotagonista solare, che nei mi t i af -
fronta i l drago notturno per •liberare
la città ».
Dell'avvio ( u n « Addio' ) che molto
ci dice senza parere sul le contraddi-
zioni dell'autrice, a t rat t i non pietosa
su se stessa — ma solo a tratti - - chè
subito rientra, e ce ne dispiace — insi-
stiamo su due accenni, in qualche mo-
do rivelatori benché non determinan-
ti: e ogni ragazzo che passa è una mor-
gana. / I o credo di riconoscerti per un
momento » e « E poi, forse, brutto, ro-
vinato, mi avresti scacciato anche tu. /
Sei troppo infantile e matta! T i cono-
sco! ».
Vengono poi soprattutto una rilettura
dell'e Edipo a Colono », assai bella, e
«La smania dello scandalo », una lun-
— 225
ga poesia che ci pare quella di più com-
plessa analisi, che qu i non possiamo
affrontare, ed infine in terza ed ultima
parte del volume, l e «canzoni popola-
ri », di remmo programmatiche, su l l e
quali i n particolare c i soffermeremo.
Nella e Serata a Colono» Edipo è tra-
sferito in un ospedale di città in mezzo
a. un coro di pazzi (« il cervello è una
macchina furba e idiota che l a natura
ci ha fabbricato studiandola apposta /
per escluderci dal lo spettacolo reale,
e divertirsi a i nostri equivoci. / Solo
quando l a macchina s i guasta, nel le
febbri, nell'agonia, noi cominciamo a di-
stinguere un filo / dello scenario proibi-
to »). E d è assistito da una Antigone
guaglioncella (cugina della Nunziatina
dell'Isola
d i Arturo)
che è semmai l a
esconoscenza », l'accettazione, l a pie-
tas popolare, nei confronti di un Edipo
folgorato d i rivelazione, conoscenza,
tragedia, dalla furia del male, dalla lot-
ta col dio, che è i l Sole, « dio della lu-
ce, della bellezza, della profezia e della
peste'. Un Edipo più classico e insie-
me nuovo d i a l t re recenti freudiane
cattoliche versioni, ma che ancora c i
pare non centri appieno, per scelta pre-
cisa, l a sostanza del mito: che è nella
identità t ra Edipo e Sfinge, t ra l'uomo
e i l suo destino. Su tut ta l a seconda
parte del libro aleggia peraltro una stra-
na triade di vat i protettivi: Hblderlin,
Mozart e Rimbaud; anche se i riferi-
menti ad essa sono discontinui e perso-
nalissimi, mescolati a molto d'altro ( e
ai sacri testi di varia tradizione: porte
di saggezza, chiavi di illuminazione in-
teriore, passaggi dal limitato all'eterno).
Nella terza parte, l a già nota e Can-
zone degli F. P. e degli I .M. » ( pe r chi
non lo sapesse: Fel ici Pochi e Infelici
Molti) e e I l Mondo salvato dai ragazzi-
ni» ( l a cui ribalta e girandola finale è
meno significativa per eccesso di posi-
tività e, all'interno di questa, quasi di
banale power flower), c i troviamo d i
fronte alla parte più decisamente e im-
pegnata', cioè discutibile, de l l ibro,
quella alla quale circoscriveremo le no-
stre osservazioni. «Tut to questo, / i n
sostanza e verità, / non è nient'altro /
che un gioco », è la conclusione cui da,
punti diversi arriva la saggezza dei per-
sonaggi puri , dunque folli, cui arr iva
ogni comprensione, in una sorta di ter-
sa e istintiva visione che parte da un
Vangelo i n cui persino Giuda può tra-
sformarsi mor to ne l candore d i una
ragazzina d i borgata, che è poi al t ra
incarnazione de l e pazzariello » - - su
















