
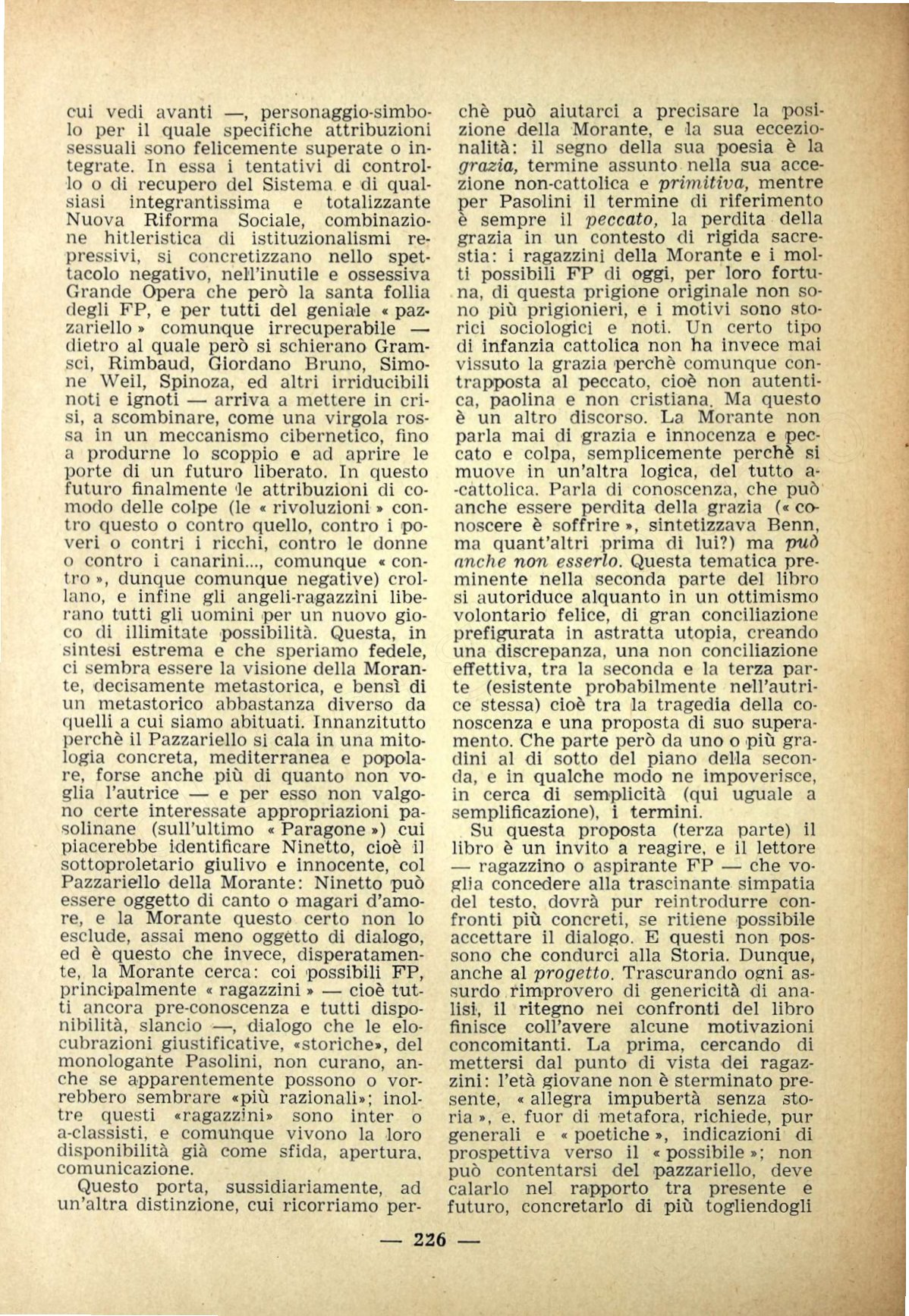
cui ved i avan t i , personaggio-simbo-
lo p e r i l quale speci f iche at t r i buz i on i
sessuali sono felicemente superate o in-
tegrate. I n essa i tentat i v i d i control -
lo o d i recupero del Sistema e d i qual-
siasi i n t eg r an t i ss ima e t o t a l i zzan t e
Nuova R i f o r ma Sociale, combinazio-
ne h i t l er i s t i ca d i i st i tuz ional i smi r e -
pressivi, s i concret izzano n e l l o spet -
tacolo negativo, nel l ' inut i le e ossessiva
Grande Opera che però l a santa fo l l i a
degli FP, e per t u t t i del geniale « paz-
zariello » comunque i rrecuperabi le —
dietro al quale però si schierano Gram-
sci, Rimbaud, Giordano Br uno , Simo-
ne We i l , Spinoza, ed a l t r i i r r i duc i b i l i
noti e ignot i — arr iva a mettere i n cr i -
si, a scombinare, come una vi rgola ros-
sa i n u n meccanismo cibernetico, f i no
a produrne l o scoppio e ad apr i re l e
porte d i u n f u t u r o l iberato. I n questo
futuro f inalmente l e at t r ibuzioni d i co-
modo delle colpe ( le « rivoluzioni » con-
tro questo o contro quello, contro i po-
ver i o cont r i i r icchi , cont ro l e donne
o cont ro i canarini..., comunque « con-
tro », dunque comunque negative) crol-
lano, e i n f i ne g l i angel i -ragazzini l ibe-
rano t u t t i g l i uomini per un nuovo gio-
co d i i l l imi t a t e possibi l i tà. Questa, i n
sintesi estrema e che speriamo fedele,
ci sembra essere la visione della Moran-
te, decisamente metastorica, e bensì d i
un metastorico abbastanza diverso da
quelli a cui siamo abituati. Innanzi tut to
•perchè i l Pazzariello si cala in una mito-
logia concreta, medi terranea e popola-
re, forse anche p i ù d i quanto non vo-
glia l 'aut r ice — e per esso non valgo-
no certe interessate appropr iazioni pa-
solinane (su l l ' u l t imo « Paragone ») c u i
piacerebbe ident i f icare Ninet to, cioè i l
sottoproletario giul i vo e innocente, col
Pazzariello della Morante: Ni net to può
essere oggetto di canto o magari d'amo-
re, e l a Morante questo cer to non l o
esclude, assai meno oggétto d i dialogo,
ed è questo che invece, disperatamen-
te, l a Morante cerca: co i possibi l i FP,
principalmente « ragazzini » — cioè tut-
t i ancora pre-conoscenza e t u t t i dispo-
nibi l ità, slancio —, dialogo che l e elo-
cubrazioni giustificative, «storiche», del
monologante Pasol ini , non curano, an-
che se apparentemente possono o vor -
rebbero sembrare «più razionali»; inol -
tre ques t i «ragazzini» s o n o i n t e r o
a-classisti, e comunque v i vono l a l oro
disponibilità g i à come sf ida, aper tura,
comunicazione.
Questo po r t a , sussidiariamente, a d
un'al tra distinzione, cui r icorr iamo per-
chè può a i u t ar c i a precisare l a posi -
zione del la Morante, e l a sua eccezio-
nal ità: i l segno del la sua poesia è l a
grazia,
termine assunto nel la sua acce-
zione non-cattolica e
pr imi t i va,
ment re
per Pasol ini i l termi ne d i r i fer imento
è sempre i l
peccato,
l a perd i t a de l l a
grazia i n u n contesto d i r i g i da sacre-
stia: i ragazzini del la Morante e i mol-
t i possibi l i F P d i oggi, pe r l oro for tu-
na, d i questa pr igione originale non so-
no p i ù pr igionier i , e i mo t i v i sono sto-
rici sociologici e no t i . U n ce r t o t i p o
di infanzia cattol ica non ha invece mai
vissuto la grazia perchè comunque con-
trapposta a l peccato, cioè non autent i -
ca, paol ina e non crist iana. Ma questo
è u n a l t r o discorso. L a Morante n o n
parla ma i d i grazia e innocenza e pec-
cato e colpa, sempl icemente perché s i
muove i n un ' a l t ra logica, de l t u t t o a-
-càttolica. Par la d i conoscenza, che può
anche essere perdi ta del la grazia (« co-
noscere è sof f r i re », sintetizzava Benn,
ma quant ' a l t r i p r ima d i lui?) ma
può
anche non esserlo.
Questa tematica pre-
minente nel la seconda par te de l l i b r o
si autoriduce alquanto i n un ot t imismo
volontario fel ice, d i gran conci l iazione
prefigurata i n ast rat ta utopia, creando
una discrepanza, una non conciliazione
effettiva, t r a l a seconda e l a terza par-
te (esistente probabi lmente nel l 'aut r i -
ce stessa) cioè t ra l a tragedia del la co-
noscenza e una proposta d i suo supera-
mento. Che parte però da uno o più gra-
dini a l d i sot to de l piano del la secon-
da, e i n qualche modo ne impoverisce,
in cerca d i sempl ici tà ( q u i uguale a
semplificazione), i termi n i .
Su questa proposta ( t e r za par te) i l
l ibro è un i nv i t o a reagire, e i l let tore
ragazzino o aspirante FP — che vo-
glia concedere al la trascinante simpatia
del testo, dovrà p u r reint rodur re con-
f ront i p i ù concreti, se r i t iene possibile
accettare i l dialogo. E quest i non pos-
sono che condurci al la Storia. Dunque,
anche al
progetto.
Trascurando ogni as-
surdo r improvero d i generici tà d i ana-
lisi, i l r i tegno ne i conf ront i de l l i b r o
finisce co l l ' avere a l c une mo t i vaz i on i
concomitanti. L a p r ima , cercando d i
mettersi da l pun t o d i v i s ta de i ragaz-
zini: l 'età giovane non è sterminato pre-
sente, « allegra impube r t à senza s t o -
ria », e. f uo r d i metafora, richiede, pu r
generali e « poetiche », indicazioni d i
prospettiva verso i l « possibile »; n o n
può contentarsi d e l pazzariel lo, deve
calarlo n e l r appo r t o t r a presente e
futuro, concretar lo d i p i ù togl iendogl i
• 2 2 6
















