
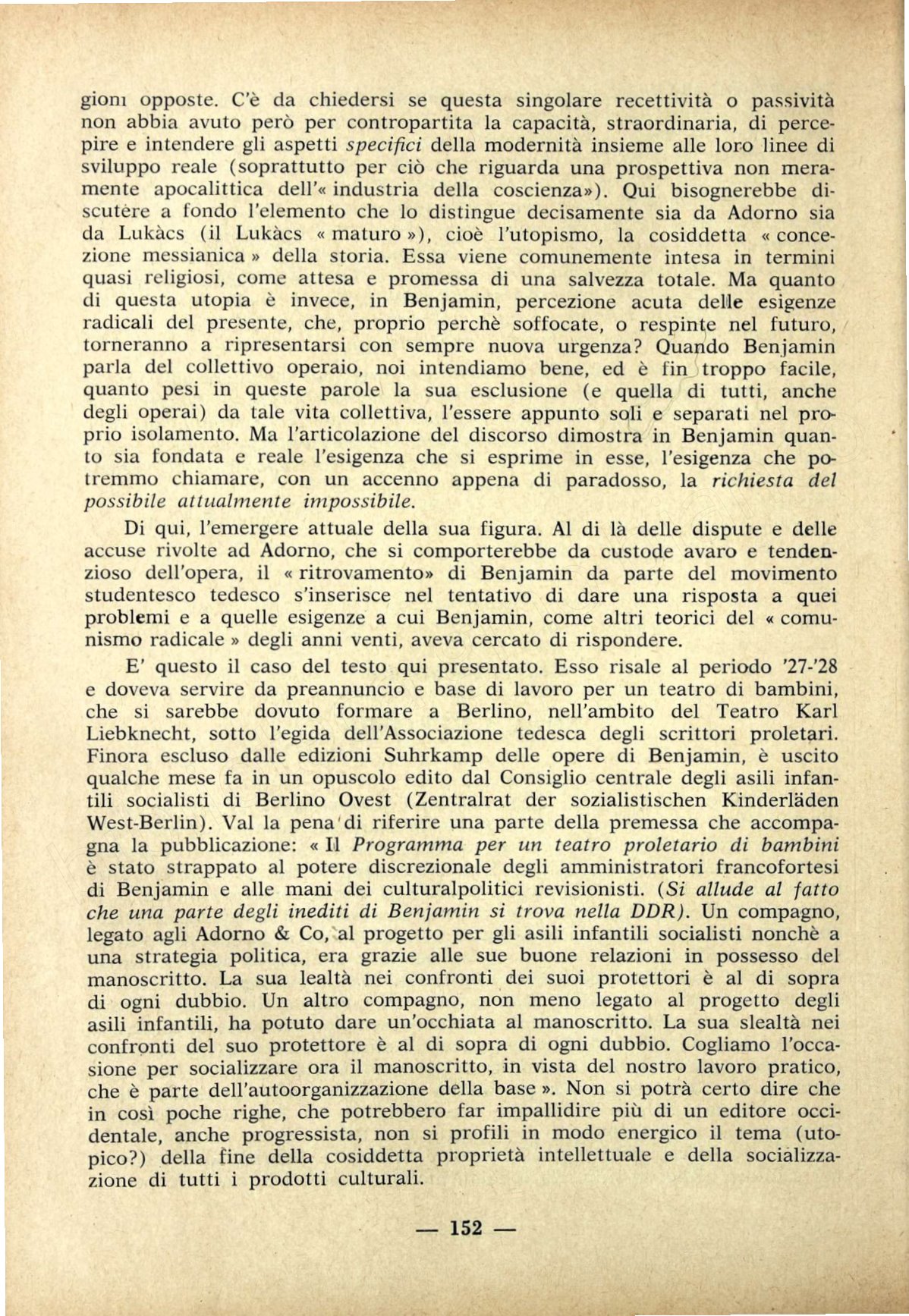
gioni opposte. C'è da chiedersi se questa singolare recet t ivi tà o passività
non abbia avuto però per contropartita l a capacità, straordinaria, d i perce-
pire e intendere gl i aspetti
specifici
della modernità insieme alle loro linee di
sviluppo reale (soprattutto per ciò che riguarda una prospettiva non mera-
mente apocal ittica del l '« industria del la coscienza»). Qu i bisognerebbe d i -
scutere a fondo l'elemento che l o distingue decisamente sia da Adorno sia
da Lukàcs ( i l Lukàcs «ma t uro »), cioè l 'utopismo, l a cosiddetta «conce-
zione messianica» del la storia. Essa viene comunemente intesa i n termini
quasi religiosi, come attesa e promessa d i una salvezza totale. Ma quanto
di questa utopia è invece, i n Benjamin, percezione acuta del le esigenze
radicali del presente, che, propr io perchè soffocate, o respinte nel futuro,
torneranno a ripresentarsi con sempre nuova urgenza? Quando Benjamin
parla de l col lett ivo operaio, no i intendiamo bene, ed è f i n t r oppo faci le,
quanto pesi i n queste parole l a sua esclusione ( e quel la d i t u t t i , anche
degli operai) da tale vi ta collettiva, l'essere appunto sol i e separati nel pro-
prio isolamento. Ma l'articolazione del discorso dimostra i n Benjamin quan-
to sia fondata e reale l'esigenza che s i esprime i n esse, l'esigenza che po-
tremmo chiamare, con u n accenno appena d i paradosso, l a
richiesta de l
possibile attualmente impossibile.
Di qui , l'emergere attuale della sua figura. A l d i là delle dispute e delle
accuse rivol te ad Adorno, che si comporterebbe da custode avaro e tenden-
zioso dell'opera, i l « ritrovamento» d i Benjamin da par te de l movimento
studentesco tedesco s'inserisce ne l tentat ivo d i dare una risposta a quei
problemi e a quelle esigenze a cui Benjamin, come al t r i teorici del « comu-
nismo radicale» degli anni venti, aveva cercato di rispondere.
E' questo i l caso del testo qui presentato. Esso risale a l periodo '27-28
e doveva servire da preannuncio e base d i lavoro per un teatro d i bambini,
che s i sarebbe dovuto formare a Ber l ino, nel l 'ambi to d e l Tea t r o K a r l
Liebknecht, sot to l 'egida dell'Associazione tedesca degl i scr i t tor i proletar i .
Finora escluso dal le edizioni Suhrkamp del le opere d i Benjamin, è usci to
qualche mese fa in un opuscolo edito dal Consiglio centrale degli asi l i infan-
t i l i social isti d i Ber l ino Ovest (Zent ral rat de r sozialistischen Kinderffiden
West-Berlin). Val la pena ' di r i fer i re una parte della premessa che accompa-
gna l a pubblicazione: « I l Programma per un teatro proletario d i bambini
è stato strappato a l potere discrezionale degl i amministratori francofortesi
di Benjamin e al le mani dei cul turalpol i t ici revisionisti.
(S i allude a l fat to
che una parte degli inedi t i d i Benjamin s i trova nella
DDR).
Un compagno,
legato agl i Adorno & Co, al progetto per gl i asili infant i l i socialisti nonchè a
una strategia pol itica, era grazie al le sue buone relazioni i n possesso del
manoscritto. La sua leal tà nei conf ront i dei suoi protet tor i è a l d i sopra
di ogn i dubbio. U n a l t r o compagno, non meno legato a l proget to degl i
asili infant i l i , ha potuto dare un'occhiata al manoscritto. La sua slealtà nei
confronti del suo protettore è a l d i sopra d i ogni dubbio. Cogliamo l'occa-
sione per socializzare ora i l manoscritto, i n vista del nostro lavoro pratico,
che è parte dell'autoorganizzazione della base ». Non si potrà certo di re che
in così poche righe, che potrebbero f a r impal l idi re p i ù d i un editore occi-
dentale, anche progressista, non s i prof i l i i n modo energico i l tema (uto-
pico?) del la f i ne del la cosiddetta propr ietà intel lettuale e del la socializza-
zione d i t u t t i i prodot t i cul tural i .
152
















