
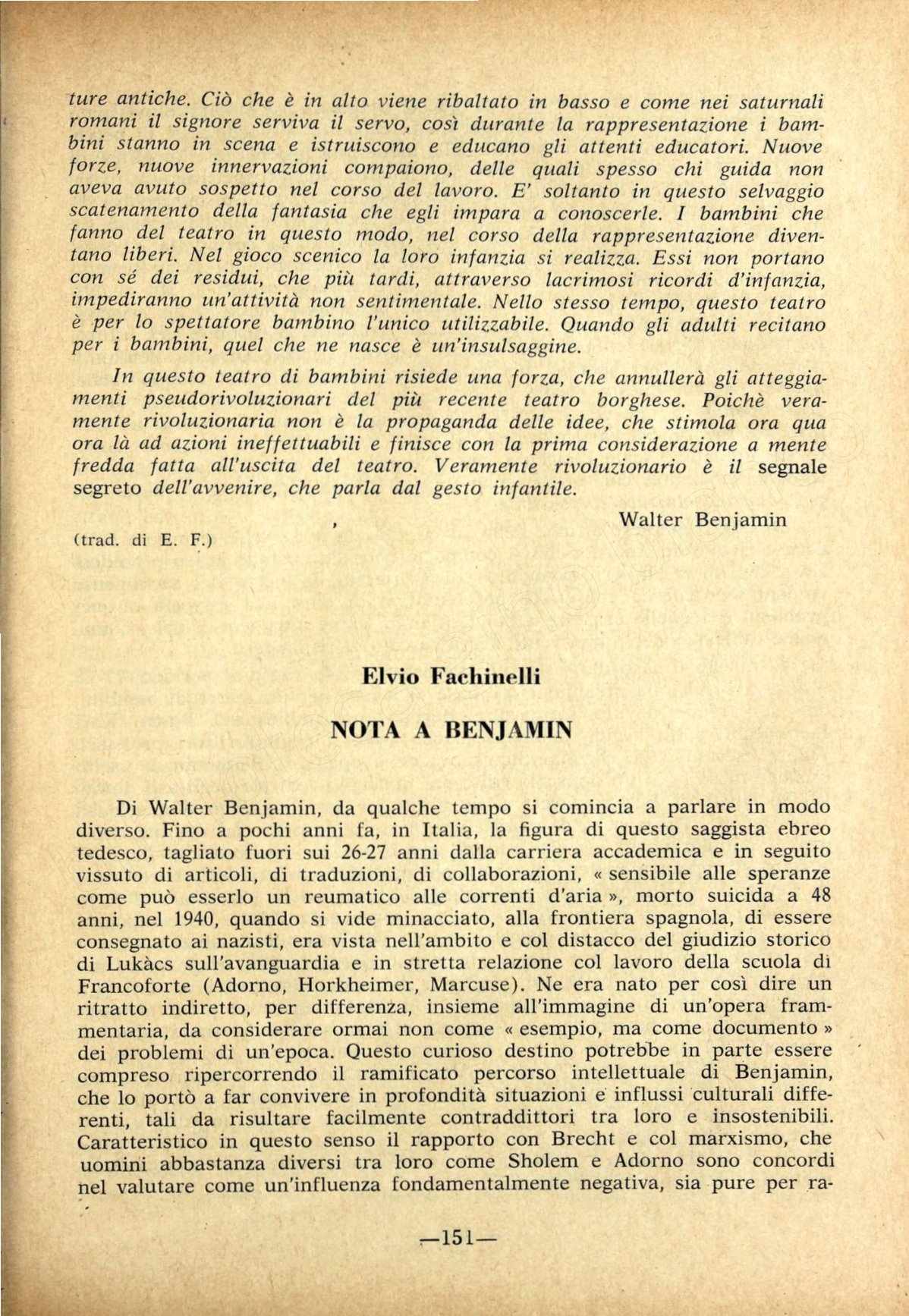
•
ture antiche. Ciò che è i n al to viene ribal tato i n basso e come nei saturnali
romani i l signore serviva i l servo, così durante l a rappresentazione i bam-
bini stanno i n scena e istruiscono e educano g l i at tent i educatori. Nuove
forze, nuove innervazioni compaiono, de l l e qua l i spesso c h i gu i da n o n
aveva avuto sospetto nel corso del lavoro. E ' soltanto i n questo selvaggio
scatenamento del la fantasia che egl i impara a conoscerle. I bambini che
fanno de l teat ro i n questo modo, ne l corso del la rappresentazione diven-
tano l iberi . Ne l gioco scenico l a loro infanzia s i realizza. Essi non portano
con sé de i residui , che p i ù tardi , attraverso lacr imosi r i cord i d' infanzia,
impediranno un'att ivi tà non sentimentale. Nel lo stesso tempo, questo teatro
è per l o spettatore bambino l 'unico utilizzabile. Quando g l i adul t i recitano
per i bambini, quel che ne nasce è un'insulsaggine.
In questo teatro d i bambini risiede una forza, che annullerà gl i atteggia-
menti pseudorivoluzionari de l p i ù recente teat ro borghese. Poichè vera-
mente rivoluzionaria non è l a propaganda del le idee, che st imola ora qua
ora là ad azioni ineffettuabi l i e finisce con la pr ima considerazione a mente
fredda f a t t a al l 'usci ta de l teat ro. Veramente r ivoluzionar io è i l
segnale
segreto
dell'avvenire, che par la dal gesto infanti le.
Walter Benjamin
(trad. d i E . F. )
Elvio Fachinelli
NOTA A BENJAMIN
Di Walter Benjamin, da qualche tempo si comincia a parlare in modo
diverso. Fino a pochi anni fa, in Italia, la figura d i questo saggista ebreo
tedesco, tagliato fuori sui 26-27 anni dalla carriera accademica e in seguito
vissuto di articoli, di traduzioni, di collaborazioni, «sensibile alle speranze
come può esserlo un reumatico alle correnti d'aria », morto suicida a 48
anni, nel 1940, quando si vide minacciato, alla frontiera spagnola, di essere
consegnato ai nazisti, era vista nell'ambito e col distacco del giudizio storico
di Lukàcs sull'avanguardia e in stretta relazione col lavoro della scuola di
Francoforte (Adorno, Horkheimer, Marcuse). Ne era nato per così dire un
ritratto indiretto, per differenza, insieme all'immagine d i un'opera fram-
mentaria, da considerare ormai non come « esempio, ma come documento »
dei problemi di un'epoca. Questo curioso destino potrebbe in parte essere
compreso ripercorrendo i l ramificato percorso intellettuale d i Benjamin,
che lo portò a far convivere in profondità situazioni è influssi 'culturali diffe-
renti, t a l i d a risultare facilmente contraddittori t r a loro e insostenibili.
Caratteristico in questo senso i l rapporto con Brecht e col marxismo, che
uomini abbastanza diversi t ra loro come Sholem e Adorno sono concordi
nel valutare come un'influenza fondamentalmente negativa, sia pure per ra-
n
151—
















