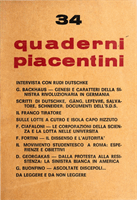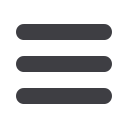
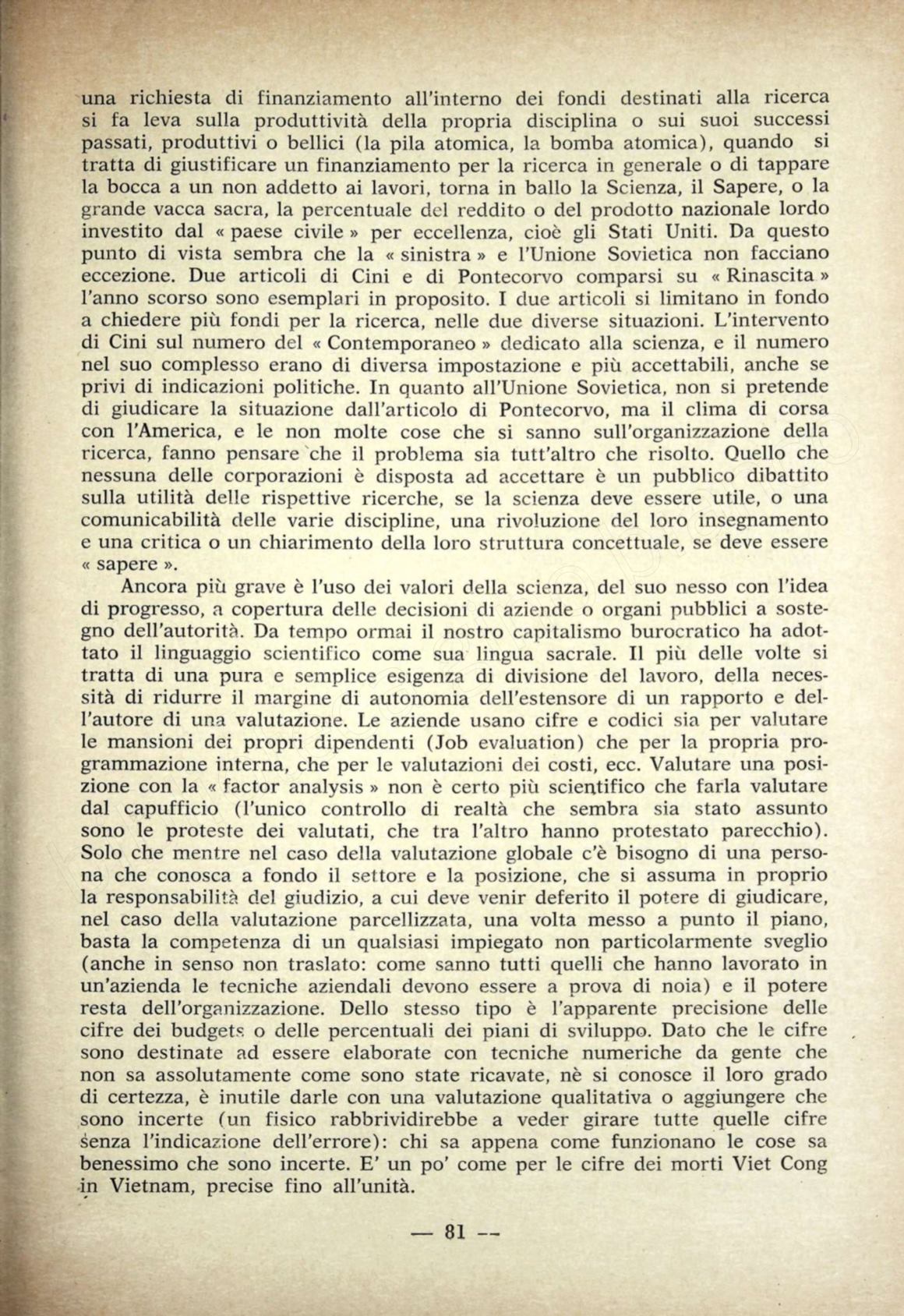
-una richiesta d i finanziamento all'interno dei fondi destinati al la ricerca
si f a leva sulla produttività della propria disciplina o sui suoi successi
passati, produttivi o bellici ( la pila atomica, la bomba atomica), quando s i
tratta di giustificare un finanziamento per la ricerca in generale o di tappare
la bocca a un non addetto ai lavori, torna in ballo la Scienza, il Sapere, o la
grande vacca sacra, la percentuale del reddito o del prodotto nazionale lordo
investito dal « paese civile » per eccellenza, cioè gli Stati Uniti. Da questo
punto di vista sembra che la « sinistra » e l'Unione Sovietica non facciano
eccezione. Due articoli d i Cini e d i Pontecorvo comparsi su « Rinascita »
l'anno scorso sono esemplari in proposito. I due articoli si limitano in fondo
a• chiedere più fondi per la ricerca, nelle due diverse situazioni. L'intervento
di. Cini sul numero del « Contemporaneo » dedicato alla scienza, e i l numero
nel suo complesso erano di diversa impostazione e più accettabili, anche se
privi di indicazioni politiche. In quanto all'Unione Sovietica, non si pretende
di giudicare la situazione dall'articolo di Pontecorvo, ma i l clima di corsa
con l'America, e le non molte cose che si sanno sull'organizzazione della
ricerca, fanno pensare 'che i l problema sia tutt'altro che risolto. Quello che
nessuna delle corporazioni è disposta ad accettare è un pubblico dibattito
sulla utilità delle rispettive ricerche, se la scienza deve essere utile, o una
comunicabilità delle varie discipline, una rivoluzione del loro insegnamento
e una critica o un chiarimento della loro struttura concettuale, se deve essere
«sapere ».
Ancora più grave è l'uso dei valori della scienza, del suo nesso con l'idea
di progresso, a copertura delle decisioni di aziende o organi pubblici a soste-
gno dell'autorità. Da tempo ormai i l nostro capitalismo burocratico ha adot-
tato i l linguaggio scientifico come sua lingua sacrale. I l più delle volte si
tratta di una pura e semplice esigenza di divisione del lavoro, della neces-
sità di ridurre i l margine di autonomia dell'estensore di un rapporto e del-
l'autore di una valutazione. Le aziende usano cifre e codici sia per valutare
le mansioni dei propri dipendenti (Job evaluation) che per la propria pro-
grammazione interna, che per le valutazioni dei costi, ecc. Valutare una posi-
zione con la « factor analysis » non è certo più scientifico che farla valutare
dal capufficio (l'unico controllo d i realtà che sembra sia stato assunto
sono le proteste dei valutati, che t ra l'altro hanno protestato parecchio).
Solo che mentre nel caso della valutazione globale c'è bisogno di una perso-
na che conosca a fondo i l settore e la posizione, che si assuma in proprio
la responsabilità del giudizio, a cui deve venir deferito il potere di giudicare,
nel caso della valutazione parcellizzata, una volta messo a punto i l piano,
basta la competenza di un qualsiasi impiegato non particolarmente sveglio
(anche in senso non traslato: come sanno tutti quelli che hanno lavorato in
un'azienda le tecniche aziendali devono essere a prova di noia) e i l potere
resta dell'organizzazione. Dello stesso t ipo è l'apparente precisione delle
cifre dei budgets o delle percentuali dei piani di sviluppo. Dato che le cifre
sono destinate ad essere elaborate con tecniche numeriche da gente che
non sa assolutamente come sono state ricavate, nè si conosce i l loro grado
di certezza, è inutile darle con una valutazione qualitativa o aggiungere che
sono incerte ( un fisico rabbrividirebbe a veder girare tutte quelle cifre
Senza l'indicazione dell'errore): chi sa appena come funzionano le cose sa
benessimo che sono incerte. E' un po' come per le cifre dei morti Viet Cong
4n Vietnam, precise fino all'unità.