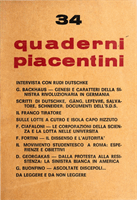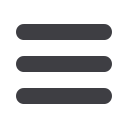
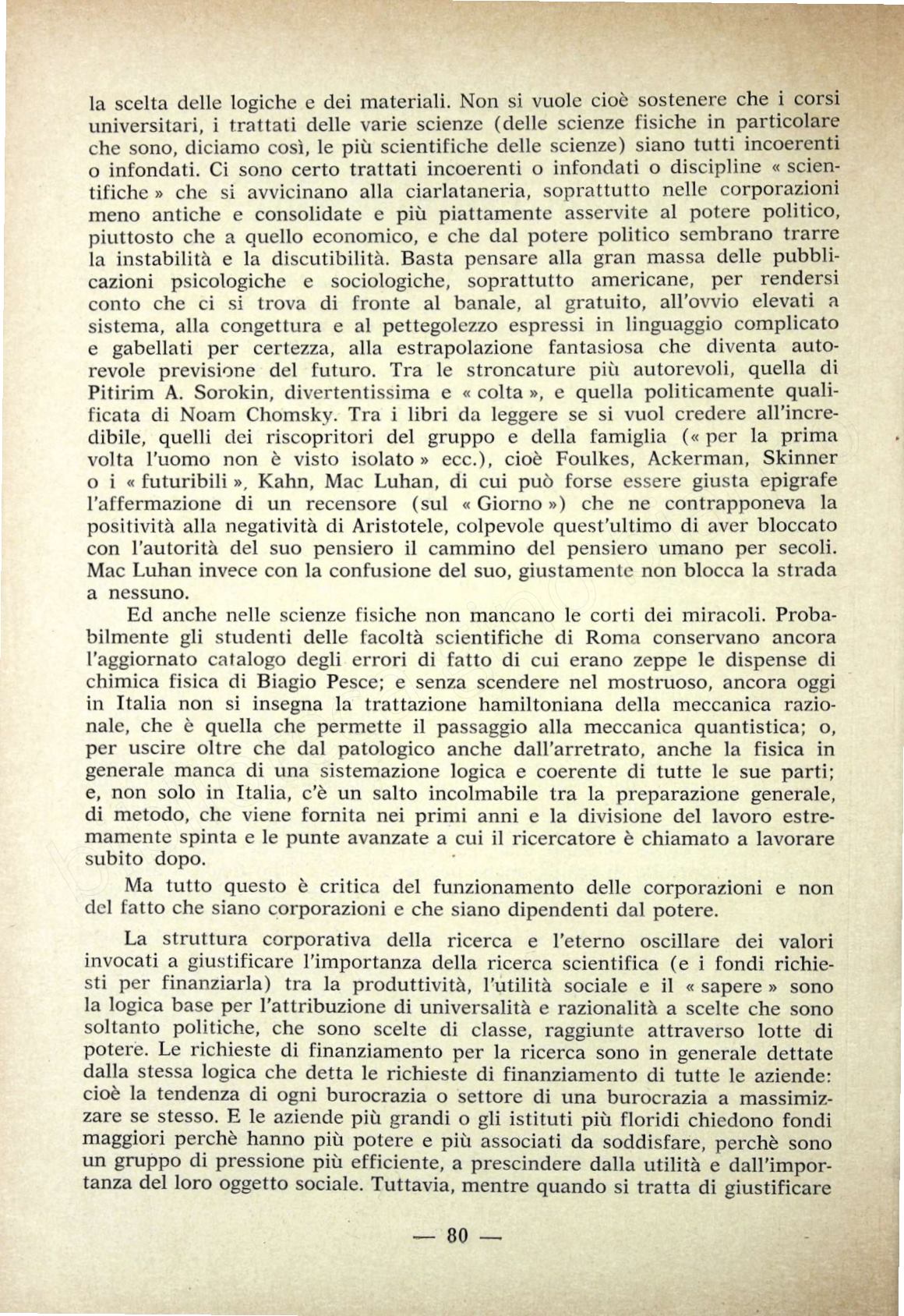
la scelta delle logiche e dei materiali. Non si vuole cioè sostenere che i corsi
universitari, i trattati delle varie scienze (delle scienze fisiche in particolare
chesono, diciamo così, le più scientifiche delle scienze) siano tutti incoerenti
o infondati. Ci sono certo trattati incoerenti o infondati o discipline «scien-
tifiche » che si avvicinano alla ciarlataneria, soprattutto nelle corporazioni
meno antiche e consolidate e più piattamente asservite al potere politico,
piuttosto che a quello economico, e che dal potere politico sembrano trarre
la instabilità e la discutibilità. Basta pensare alla gran massa delle pubbli-
cazioni psicologiche e sociologiche, soprattutto americane, per rendersi
conto che ci si trova di fronte a l banale, al gratuito, all'ovvio elevati a
sistema, alla congettura e al pettegolezzo espressi in linguaggio complicato
e gabellati per certezza, alla estrapolazione fantasiosa che diventa auto-
revole previsione del futuro. Tra le stroncature più autorevoli, quella d i
Pitirim A. Sorokin, divertentissima e « colta », e quella politicamente quali-
ficata di Noam Chomsky. Tra i libri da leggere se si vuol credere all'incre-
dibile, quelli dei riscopritori del gruppo e della famiglia ( « per la prima
volta l'uomo non è visto isolato » ecc.), cioè Foulkes, Ackerman, Skinner
o i « futuribili », Kahn, Mac Luhan, di cui può forse essere giusta epigrafe
l'affermazione d i un recensore (sul « Giorno ») che ne contrapponeva l a
positività alla negatività di Aristotele, colpevole quest'ultimo di aver bloccato
con l'autorità del suo pensiero i l cammino del pensiero umano per secoli.
Mac Luhan invece con la confusione del suo, giustamente non blocca la strada
a nessuno.
Ed anche nelle scienze fisiche non mancano le corti dei miracoli. Proba-
bilmente gli studenti delle facoltà scientifiche di Roma conservano ancora
l'aggiornato catalogo degli errori di fatto di cui erano zeppe le dispense di
chimica fisica di Biagio Pesce; e senza scendere nel mostruoso, ancora oggi
in Italia non si insegna la trattazione hamiltoniana della meccanica razio-
nale, che è quella che permette i l passaggio alla meccanica quantistica; o,
per uscire oltre che dal patologico anche dall'arretrato, anche la fisica in
generale manca di una sistemazione logica e coerente di tutte le sue parti;
e, non solo in Italia, c'è un salto incolmabile tra la preparazione generale,
di metodo, che viene fornita nei primi anni e la divisione del lavoro estre-
mamente spinta e le punte avanzate a cui il ricercatore è chiamato a lavorare
subito dopo.
Ma tutto questo è critica del funzionamento delle corporazioni e non
del fatto che siano corporazioni e che siano dipendenti dal potere.
La struttura corporativa della ricerca e l'eterno oscillare dei valori
invocati a giustificare l'importanza della ricerca scientifica (e i fondi richie-
sti per finanziarla) t ra la produttività, l'utilità sociale e i l « sapere » sono
la logica base per l'attribuzione di universalità e razionalità a scelte che sono
soltanto politiche, che sono scelte di classe, raggiunte attraverso lotte di
potere. Le richieste di finanziamento per la ricerca sono in generale dettate
dalla stessa logica che detta le richieste di finanziamento di tutte le aziende:
cioè la tendenza di ogni burocrazia o settore di una burocrazia a massimiz-
zare se stesso. E le aziende più grandi o gli istituti più floridi chiedono fondi
maggiori perchè hanno più potere e più associati da soddisfare, perchè sono
un gruppo di pressione più efficiente, a prescindere dalla utilità e dall'impor-
tanza del loro oggetto sociale. Tuttavia, mentre quando si tratta di giustificare
— 80 —