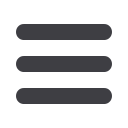
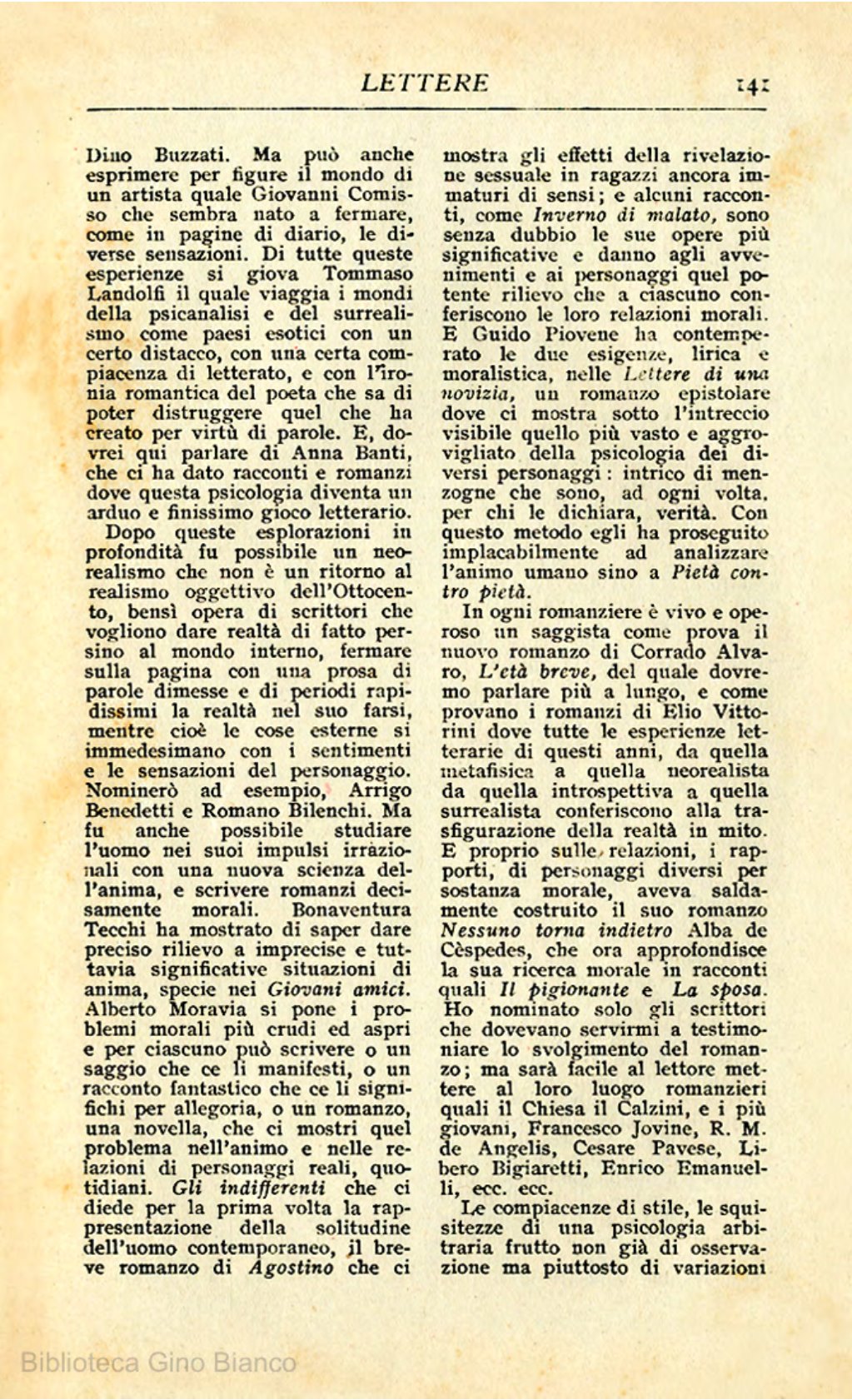
LETTERE
!;~~m!~z~~i.
tig~:e
S
1
~on~~c~1
un artista quale Giovanni Comis –
so che sembra nato a krmar<:,
come in pagine di diario, le di•
verse se11saz1oni.
Di
tutte ques te
esperienze
si giova Tommaso
Landol6 il quale ,·iaggia
i
mondi
dclb psicanalisi e del surreali –
smo come paesi esotici con un
certo distacco, con un'a certa com–
piacenza di letterato, e con l'iro–
nia romantica del poeta che sa di
poter dist ruggere quel che hn
creato per virtù
di
parole. E, do-
cll!i
c?h
1
at~~a~~~!ufi
0
:~o!:a~~l
dove questa psicologia diventa.
liii
:irduo e finissimo gioco lette rario.
Dopo queste esP.lorazioni in
profondità
fu
posstbilc un neo–
realismo che non
è
un ritorno al
realismo oggctth-o dell'O tt ocen–
to,
bensl opera di scrittori che
,-ogtiono dare realtà di fatto pc.r•
sin·o al mondo interno, fermare
sulla pagi na con una prosa di
~i~l~1idila~~tià
d:1er~i:i
;~~t
mentre cioè le
cose
esterne si
immedesima no oon i sentimenti
e le sensazioni del personaggio.
~:!k~~f
e
~omin:1b!f;neCt~f:
fu
anche
possibi le
studiare
l'uomo nei suoi impulsi irr&.Zio-
1 .-.li
con una nuova scienza del–
l'anima, e serh•ere romanz i deci–
samente
morali.
Bonaventura
Teccbi ba most .rato di saper dare
preciso rilievo a imprecise e tut–
tavia significative
situazioni di
~t=~~
s~!!vi~ isfi;',~:i iam;:;
blemi morali pià crndi
cd
aspri
!.~ioci~~u~o
lt~:~U~~i~
!
~
racronto fantaslioo che cc li signi–
fichi per allegoria, o un romanzo,
una novc1la, che ci mostri quel
fa~~:~~mcÌi
1;
1
~~~~~:i
erc:~~
1
\,~~
tidio.ni.Gli
indlfle renti
che ci
diede per la prim a volta la rap–
pr~ntazione
della solitudine
dell 'uomo contemporaneo, jl bre–
ve
romanzo
di
Agostino
che
ci
mostra gli effetti della rivdazio–
nc scssuafo in ragru-.zi ancora im–
matu ri di sensi; e alcun i raccon •
ti,
eotnc
ln-.,erno di malato,
sono
senu dubbio le sue opere
pii>.
significative
e
danno
agli avvc•
nimcnti e ai pen.ona~g i quel
po–
tente rilic,·o
eh~ a
c,ascuno
con–
feriscono le loro relazion i morali.
E
Guido Piovene
h:t
contempe•
rato
k
d11c esigc111.c,
lirica
e
morali stica, ndlc
Lettere di
iow
11ovizia,
un roma111.o epistolare
dove ci mostra sotto l'mtr«:C'.io
,·isibile quell o l)it't vasto e
a~gro–
vigliato
della
J_>Sicolog-ia
de1 di–
versi persona gg i: int rico di men•
1.ognc che sono, ad ogni volta,
pe.r
c11i
le dichfara , verità. Con
questo metodo
egli
ha proseguit o
implac.-.bilmcnte
ad analizz:ir ~
l'animo umano sino a
Pietd
con–
lro
pìl'td .
In ogni romanziere
e
vivo e ope•
~1~:,.~1
~01~agn~:tdi
c~~~aS!
0
Xiv!~
ro,
L'ctd brc-vc,
del quale dovre•
mo parlare pià a hmgo,
e
come
provano
i
romonr.i di Elio Vitto–
rini do,·e tutte le esJ_>Crien:r.e let–
terarie di questi
anni,
da quella
mdafis ic.1. a quel la noore.'llìsta
da quella introspettiva
a
quella
surrealista conferiscono alla tr a–
sfigunuione della
rc:illà in
mito.
E
proprio sulle , rcJazion i,
i
rap-
!:~~z:i
:~~{~~gg~v:!:crsial~~
mente costrui to il suo roman:r.o
Nessuno torna indietro
Alba dc
Cèspcd es, che ora apJ?rofondiStt
la
sua ricerca
morale
m racconti
quali
Il f!ìgionante e
La
s~sa .
Ho nonunato solo
gli
scnttor i
che dovevano
servirmi
a
tcstimo-
;!~r~!0
s:~
01
i~i1~
11
!f
1::lo::':i~
terc al loro luogo romanz ieri
qua li il Chiesa il Calzini, e
i
più
giovani, Francesco Jovine, R. M.
de Ani:rclis, Cesare Pavese, Li•
bcro Bìgfaretti , Enrioo Emanue l–
li,
ecc.
e«.
Le
comeiacenze
di stile, le squi–
sitezze d1 una psicologfa arbi –
tT3ria frutto non
già
di osserva–
zione ma piuttosto di varinioni
















