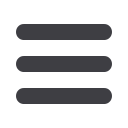
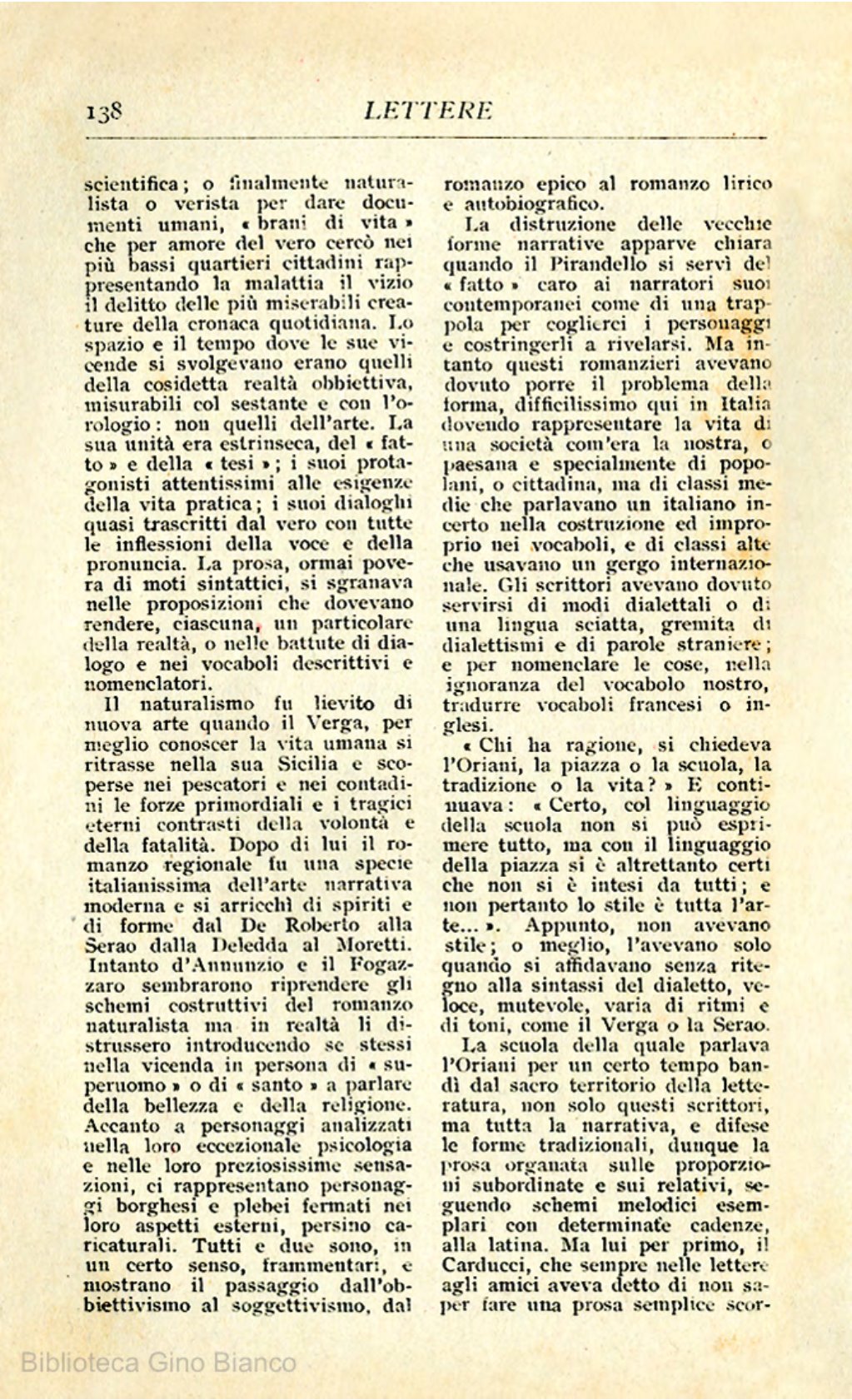
l.ETfE/U-:
sci<'ntifka; o fiu:1h11(•nt.:
natu n•
lista o vcrist:,
,~r
<
la.redocu•
menti umani, • bran i di vita •
; 11
~
ha~si":1~~ rtt:i \~ ~~a~:i~ò
/1
1
~
prC-SC)lbndo la
_1_11:1.l~ttia
!1_ ,·
i1.ioti dchtto ddlc pm m1,t(•rah1h
<'f<':'l·
ture della cronaca quotidi :rna. I.o
spai.ioe il temp o llovc k su~·
\ti•
ct'ndc si svolge,·ano erano quelli
dclltt
cosillctta rcalt/1 ohbictth·a,
111isurabili rol se!lt:mtc e ron
l'o–
rologio: non quelli dell'arte. J.a
sua unità era cstrinsl'.."C:\, lici •
fat–
to• e <lcll:t " tesi •;
i
i:noi prota–
ionist i
attentissimi
alt(' <-SiKem.~·
ddla \'ila pratica;
i
suoi dialogln
quasi tra.-;.critt i dal ,·ero ron tutk
lt: inflessioni della
\ 'OC'(:
c della
pronuucia. J.a pro,;a, ormai
J>O\'C•
ra di moti sintattici, si i-,gramwa
nelle proposi1.ioni eh,; do,·cv:1110
r,mdcre, ciascuna , un partioolar~~
tldla realt à, o nel!<'
batlute
di
dia–
logo
e nei \'oc-aboli d<o.;..crith\'i <'
nomenclatori .
li naturalismo
fu
lievito di
1110\·a arte qu ando il \"erga, per
meglio conoscer
la
\'Ìta um:ma si
ritrasse nella sua Sicilia e
SCO•
perse uei pescatori
t.·
nei conta~li•
ni le
fot1.c
prim ordiali e i lraj{ici
derui
contra l(ti della ,·olontfl e
della fatalità. Dopo di lui il ro–
manzo .regionale
fu
1111:l.
llllCC'le
itali:missi1n..'\ ddl'art<-
11:urntwa
moderna e si :1.rriC'<'hl di spiriti e
•di
forme
dal
Di:
Roherlo alla
Serao
d:llla D;,:k'(lda
al
Morett i.
Intanto d':
\111111111.ioe
il
Foga1.•
zaro sembra rono riprendl'.'re gh
schemi <'OStmtth-i del rom:mw
naturali r;ta ma in realtà li di–
stmi'ti.ero inlr odue-cndo
se slC-$:Si
11dla \'i~nda in
persona
di •
su•
pernomo • o lli • santo • a parlare
della belle1.1.a e- dcll:t r.:-llgione.
Accanto n pc~ona}!'gi nuali1.1.at1
11ella loro t.~i:iouale
psicologia
e nelk
loro
J>reziosi,isime
:-eusn–
zioni, ci rnpprc,;cntano 1x,r,io11ag–
:ti
borghes i
e plc~i fermati nei
~?:~tu~~ft
1
~u~~~c~ii :1u~>er:!~:~.
e,~;
un ttrto senso, fr:munenta r:, e
· n1ostrano il pas:-aggio dall'ob•
bi.etti\•ismo al :1>og!,!clli\',:mo. dal
rom:m:,.o cpiro al rom:uw.o liriC'l•
l'
rmtobiografie<>.
I.a
tlistrm:ione delle
\'(•C'd11c
forme narrati\'e appar\'C chiara
lJll:rndo il Pirandello si
S<'T\'Ì
dc·l
• follo •
caro
ai
nnrrat ori suo,
~xmtcmporand come di una trap•
po1:i per roJ!lk rci
i
lX'no uagg1
e eostringNh
a
rivelarsi. Ma in–
tanto questi
romanzii:r i :wcvano
do\'11lo ~rrc
il probkma
dcli:,
torma,
<hffidlissimo
<1ni
in Italia
do\'eudo rnpprcscntarc In vita di
una soci<·là com'era la
11&..tm,
o
paesana e spcdalmenk
di popo•
lani, o dttmliua,
ma
di
clns.si1m.'-
~~~il\~J~:r~~~i1.i~~1/~\iai1111?p~~
prio nei .,·ocaholi , e di classi alte–
che usa,•ano
un
gergo i11ter11a1.1~
male. Gli
scrittori aw:,·ano do,·uto
:-cn·irsi
di
modi diaktta li o
d:
nnn 11111,!'lln
i;ciatta, grem ita
1\1
dial,:ttism i
e
di parole strani<·rt";
e per nomendare k cose, 1:dla
ignoran1.a ,Id nx·abolo nostro,
tradurre
,·ocnboli
francesi
o
in•
J.!l~i.
• Chi
11a
raii011e
1
si
chiedeva
l'Oria11i, la
pia1.1.aofa
scuola, J3
tradi1.ione
o
la
,·ita ? •
E conti•
nuava:
• Certo, ool linguaggio
~!~~
t;t~ ~~am:
0
~/\1
t\~u~i;i~
della piazr.a si
è
:1ltrcttanto certi
che non si
i'.·
intesi da tutti; e
non pertanto lo
stil e
è
tutta l'ar •
te ... •· Appun to, 11011 :avc,·n.110
stil(-; o
tn\.'Klio,
1':wc,·ano solo
quanlio l'òi affid:a\·ano sc111.arik•
gno alla sintassi del dialetto, ,·e•
locc, mutev ole, varia di ritmi e
<li toni, L'Omeil Vcr~:t o l:t Scrao.
l.a scuola della qu:ilc pnrl:1\'I\
l'Oriani )X'r un certo tc-mpo ban •
dl dal sa1.·ro territ orio tldla lett e•
ratura, 11011solo qucilli scrittori,
ma tutl:I
la narra tiva,
e
dif~
le forme tradiziou :1li, dunq ue la
pro,-~, orµ:an:,ta sulle propor:uo–
ni subordinate e sui ttl:ath·i, se•
gucmlo
:-c-hemi
melodici
l~m•
pb ri
rou
<ktcnn inafo caden1.c,
alla latina. Ma lui
pcl'
\)rimo,
i!
Carducc i, che ,;cmprc nel e lett,:r .:–
agli amici a,·e, ·a lfclto di non s:i•
per fare
nna pros:a
~mp hce
.'K'Or•
















