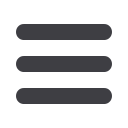
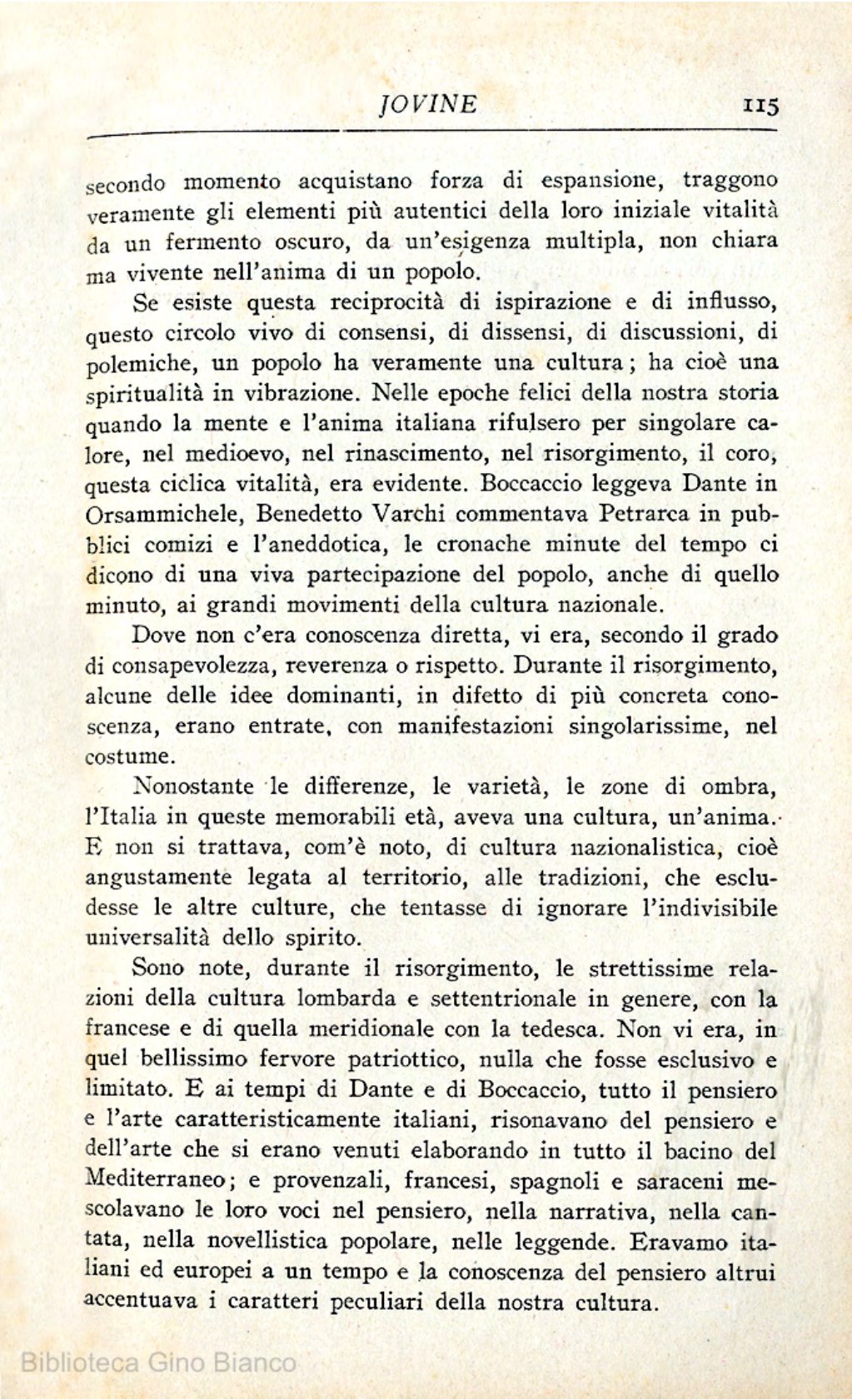
/OVINE
II5
!òecondo momento acquista no forza di espansione, traggono
veramente
gli
elementi
più
autent ici della loro iniziale vita lità
da un fermento oscuro, da un'esigenza multipla, non chiara
ma vivente nell'ani ma di un
popolo.
Se esis te questa reciprocità di ispirazione e di influsso,
questo cir<"olo vi~o di consensi, di dissensi, di discussioni, di
polemiche, un popolo ha veramente una cultura; ha
cioè
una
spiritualità in vibrazione. Nelle epoche felici della nostra storia
quan do la mente e l'anima italian a riful sero per singolare ca–
lore, nel medioevo, nel rina sciment o, nel risorgimento, il coro,
questa ciclica vitalità, era evidente. Boccaccio leggeva Dante in
Orsammichele, Benedetto Var chi commentava Petrarca in pub–
blici comizi e l'aneddo tica, Je cronache minute del tempo ci
dicono di una viva parte cipazione del popolo, anche di quello
mi11uto, ai grandi movimenti della cultura nazionale.
Dove non c'era conoscenza diretta, vi era, secondo il grado
di consapevolezza, reverenza o rispetto . Dura nte il ri sorgimento,
alcune delle idee dominant i, in difetto di più concreta cono–
scenza, erano entrate , con manif estazioni singo larissi me, nel
costume .
:-Jonostante ·le differenze, le varietà, le zone di ombra,
l'It alia in queste memorabili età, aveva una cultura, un' anima. ·
E non si tra tt ava, com'è noto, di cultura nazionalisti ca, cioè
angus tamente legata al terr itorio , alle trad izioni, che esclu–
desse le altre cultur e, che tentasse di ignorare l' indivisib ile
uuiversalità ddl o spirito .
Sono note, dura nte il risor giment o, le strett issime rela–
zioni della cultura lombarda e setten tr ionale in genere, con la
francese e di quella meridiona le con la tedesca. Non vi era, in
quel bellissimo fervore patriotti co, nulla che fosse esclusivo e
limitato. E ai tempi di Dante e di Boccaccio, tutto il pens iero
e l'arte caratterist icamente italia ni, risonava no del pensiero e
dell'arte che si erano venu ti elaborando in tutt o il bacino del
Mediterra neo; e provenzali, francesi, spagnoli e saraceni me–
scolavano le loro voci nel pensi ero. nella narr ativa, nella can–
tata, nella novellistica popolare, nelle leggende. Eravamo ita–
liani cd europei a un tempo e la coiloscenza del pens iero altrui
accentuava i cara tteri peculiari della nostra cultura .
















