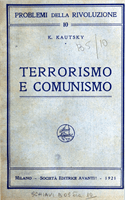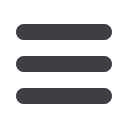
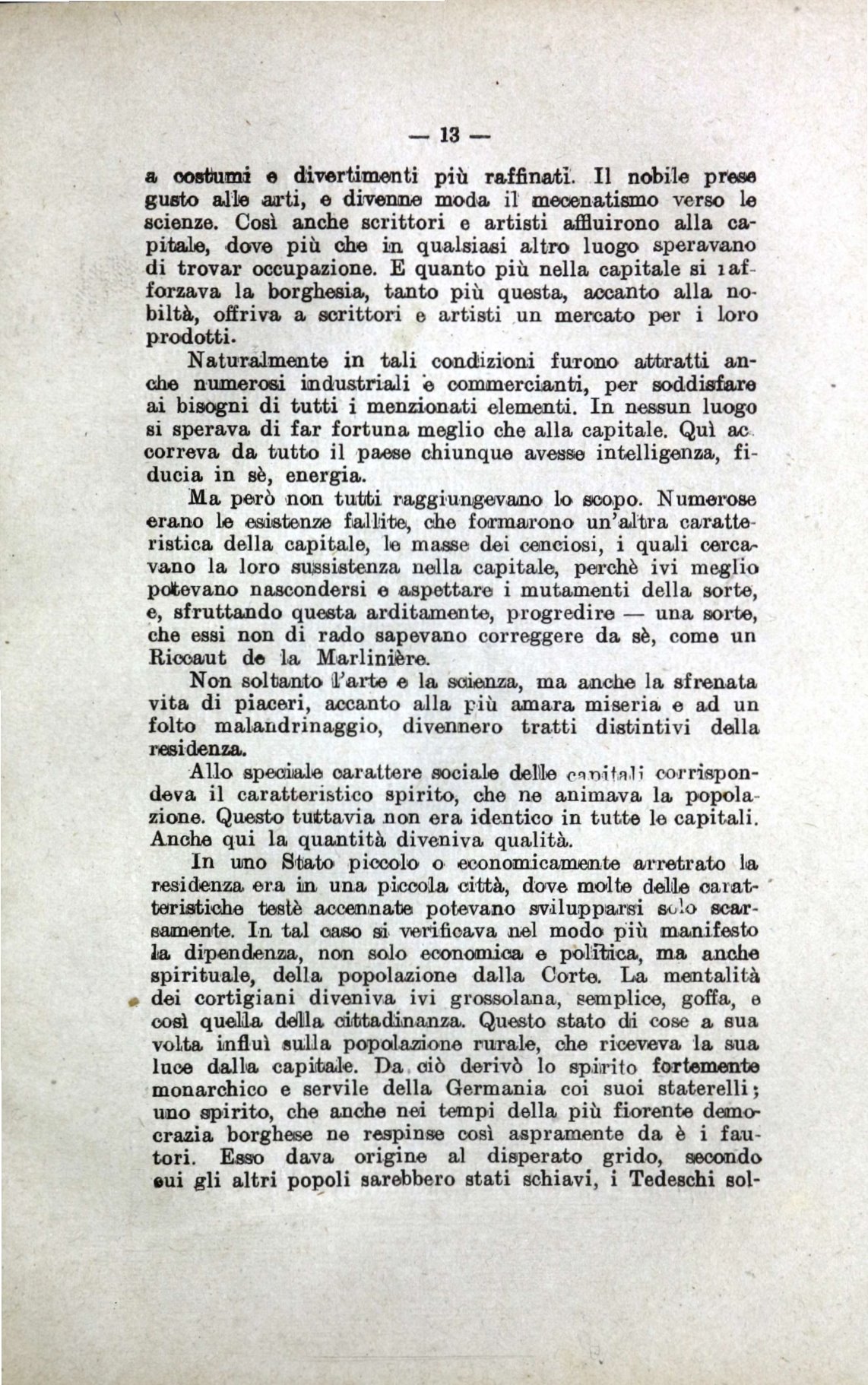
--- 13 ----
a costumi e divertimenti p i ù raffinati. I l !labile prose
gusto aile arti, e divenne moda i i mecenatismo verso le
scienze. Così anche scrittori e artisti affluirono al la ca-
pitale, idove piu che i n qualsiasi altro luogo speravano
di trovar occupazione E quanto più nella capitale si Ta t
forzava l a borghesia, tanto più questa, accanto al la no-
offriva a scrittori e artisti un mercato per i loro
prodotti.
Naturalmente i n t a l i condizioni furono attratti an-
che numerosi industriali e commercianti, per soddisfare
ai bisogni di tutti i menzionati elementi. I n nessun luogo
si sperava di far fortuna meglio che alla capitale. Qui ac
correva da tutto i l paese chiunque avesse intelligenza, f i -
ducia in sè, energia.
Ma però !non tutti raggiungevano lo scopo. Numerose
erano le esistenze faillite, ehe formarono un'altra caratte-
ristica della capitale, le masse dei cenciosi, i quali cerca-
vano la loro sussistenza nella capitale, perchè ivi meglio
potevano nascondersi e aspettare i mutamenti della sorte,
e, sfruttando questa arditamente, progredire — una sorte,
cheessi non di rado sapevano correggere da sè, come un
Riceaut de l a Marlinière.
Non soltanto l'arte e la scienza, ma anche la sfrenata
vita di piaceri, accanto alla più amara miseria e ad un
folto malandrinaggio, divennero t ra t t i distintivi del la
residenza.
Allo speciale carattere sociale delle ennritn1i corrispon-
deva i l caratteristico spirito, che ne animava la popola-
zione. Questo tuttavia non era identico in tutte le capitali.
Anche qui l a quantità diveniva qualità.
In Imo Stato piccolo o, economicamente arretrato l a
residenza era in una piccola città,, dove mane done carat-
teristiche testé accennate potevano svilupparsi sulo scar-
samente. I n tal caso si verificava nel modo più manifesto
Ladipendenza, non solo economica e politica, ma anche
spirituale, del la popolazione dal la Car ta L a mentalità
dei cortigiani diveniva ivi grossolana, semplice, goffa,
così quella deilla cittadinanza. Questo stato di cose a sua
volta influi sulla popolazione rurale, che riceveva la sua
luce dalla capitale D a ció derivò lo spirito for temente
monarchico e servile della Germania coi suoi staterelli,
uno spirito, che anche nei tempi della più fiorente demo-
crazia borghese ne respinse così aspramente da è i fau-
tori. Esso dava origine a l disperato grido, secando
eui gli altri popoli sarebbero stati schiavi, i Tedeschi sol-