
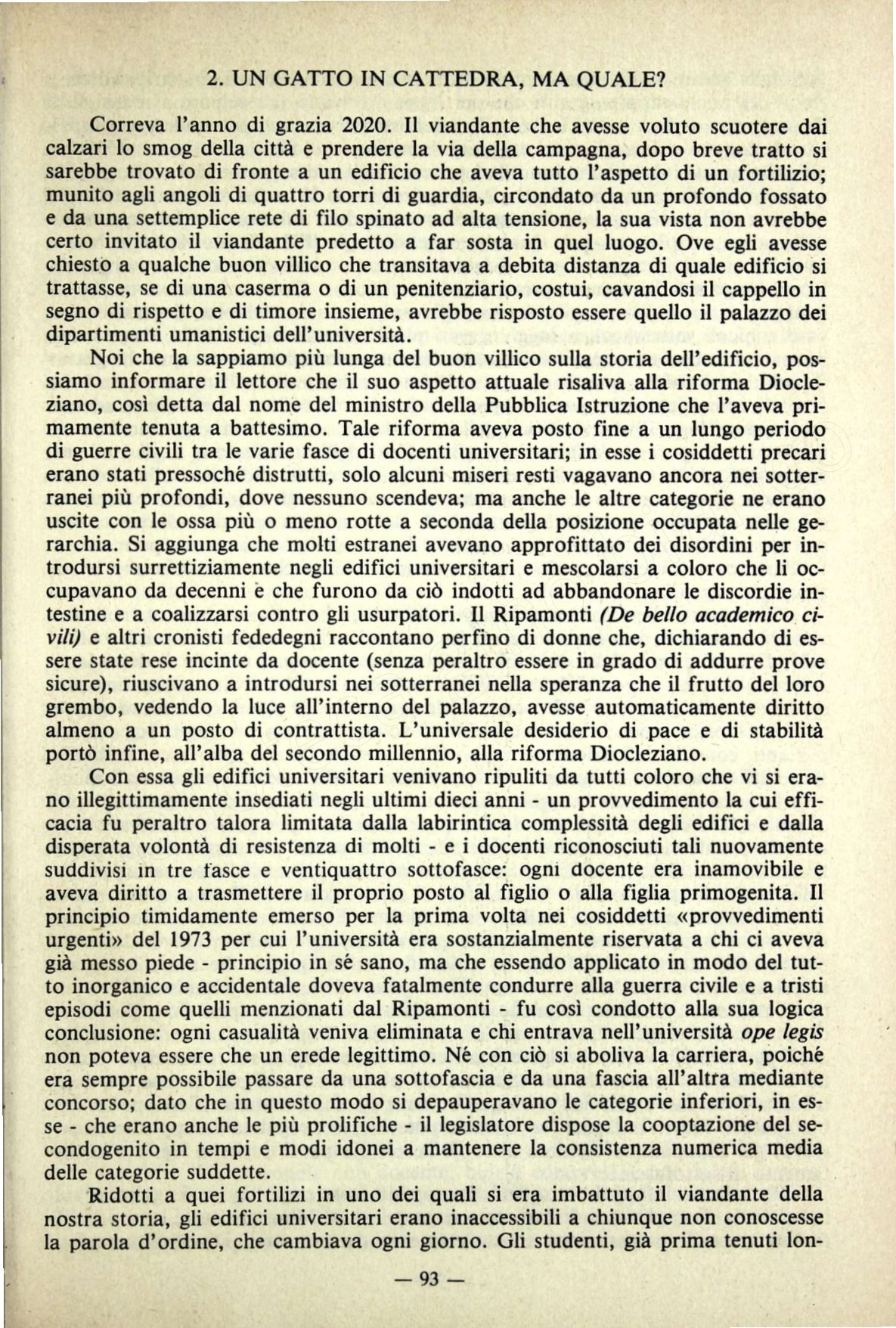
2. UN GATTO IN CATTEDRA, MA QUALE?
Correva l'anno di grazia 2020. I l viandante che avesse voluto scuotere dai
calzari lo smog della città e prendere la via della campagna, dopo breve tratto si
sarebbe trovato di fronte a un edificio che aveva tutto l'aspetto di un fortilizio;
munito agli angoli di quattro torri di guardia, circondato da un profondo fossato
eda una settemplice rete di filo spinato ad alta tensione, la sua vista non avrebbe
certo invitato il viandante predetto a far sosta in quel luogo. Ove egli avesse
chiesto a qualche buon villico che transitava a debita distanza di quale edificio si
trattasse, se di una caserma o di un penitenziario, costui, cavandosi il cappello in
segnodi rispetto e di timore insieme, avrebbe rispostoesserequello il palazzo dei
dipartimenti umanistici dell'università.
Noi che la sappiamo più lunga del buon villico sulla storia dell'edificio, pos-
siamo informare il lettore che il suo aspetto attuale risaliva alla riforma Diocle-
ziano, così detta dal nome del ministro della Pubblica Istruzione che l'aveva pri-
mamente tenuta a battesimo. Tale riforma aveva posto fine a un lungo periodo
di guerre civili tra le varie fasce di docenti universitari; in esse i cosiddetti precari
erano stati pressoché distrutti, solo alcuni miseri resti vagavano ancora nei sotter-
ranei più profondi, dove nessunoscendeva; ma anche le altre categorie ne erano
uscite con le ossa più o meno rotte a seconda della posizione occupata nelle ge-
rarchia. Si aggiunga che molti estranei avevano approfittato dei disordini per in-
trodursi surrettiziamente negli edifici universitari e mescolarsi a coloro che li oc-
cupavano da decenni e che furono da ciò indotti ad abbandonare le discordie in-
testine e a coalizzarsi contro gli usurpatori. I l Ripamonti
(De bello academico ci-
vili)
e altri cronisti fededegni raccontano perfino di donne che, dichiarando di es-
serestate rese incinte da docente (senza peraltroessere in grado di addurre prove
sicure), riuscivano a introdursi nei sotterranei nella speranza che il frutto del loro
grembo, vedendo la luce all'interno del palazzo, avesse automaticamente diritto
almeno a un posto di contrattista. L'universale desiderio di pace e di stabilità
portò infine, all'alba del secondomillennio, alla riforma Diocleziano.
Conessa gli edifici universitari venivano ripuliti da tutti coloro che vi si era-
no illegittimamente insediati negli ultimi dieci anni - un provvedimento la cui effi-
cacia fu peraltro talora limitata dalla labirintica complessità degli edifici e dalla
disperata volontà di resistenza di molti - e i docenti riconosciuti tali nuovamente
suddivisi in tre fasce e ventiquattro sottofasce: ogni docente era inamovibile e
aveva diritto a trasmettere il proprio posto al figlio o alla figlia primogenita. I l
principio timidamente emerso per la prima volta nei cosiddetti «provvedimenti
urgenti» del 1973 per cui l'università era sostanzialmente riservata a chi ci aveva
giàmessopiede - principio in sésano, ma cheessendoapplicato in modo del tut-
to inorganico e accidentale doveva fatalmente condurre alla guerra civile e a tristi
episodi come quelli menzionati dal Ripamonti - fu così condotto alla sua logica
conclusione: ogni casualità veniva eliminata e chi entrava nell'università
ope legis
nonpotevaessereche un erede legittimo. Né con ciò si aboliva la carriera, poiché
erasemprepossibilepassare da una sottofascia e da una fascia all'altra mediante
concorso; dato che in questomodo si depauperavano le categorie inferiori, in es-
se - che erano anche le più prolifiche - il legislatoredispose la cooptazione del se-
condogenito in tempi e modi idonei a mantenere la consistenza numerica media
dellecategorie suddette.
Ridotti a quei fortilizi in uno dei quali si era imbattuto il viandante della
nostra storia, gli edifici universitari erano inaccessibili a chiunque nonconoscesse
la parola d'ordine, che cambiava ogni giorno. Gli studenti, già prima tenuti lon-
93
















