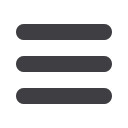
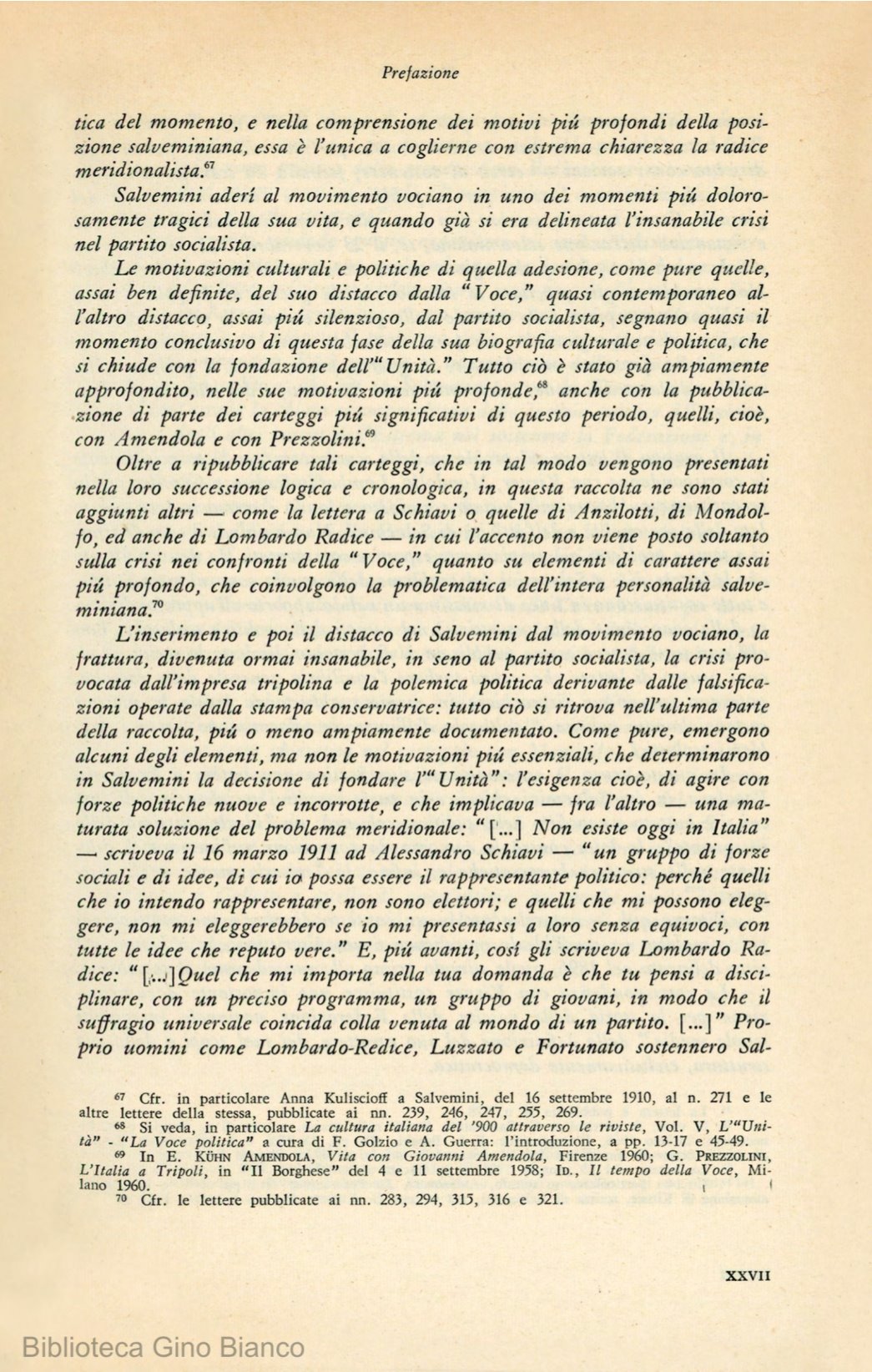
Prefazione
tica del momento, e nella comprensione dei motivi piu profondi della posi–
zione salveminiana, essa è l'unica a coglierne con estrema chiarezza la radice
meridionalista.•'
Salvemini aderf al movimento vociano in uno dei momenti piu doloro–
samente tragici della sua vita, e quando già si era delineata l'insanabile crisi
nel partito socialista.
Le motivazioni culturali e politiche di quella adesione, come pure quelle,
assai ben definite, del suo distacco dalla "Voce," quasi contemporaneo al–
l'altro distacco, assai piu silenzioso, dal partito socialista, segnano quasi il
momento conclusivo di questa fase della sua biografia culturale e politica, che
si chiude con la fondazione dell"' Unità." Tutto ciò è stato già ampiamente
approfondito, nelle sue motivazioni piu profonde,
68
anche con la pubblica–
zione di parte dei carteggi piu significativi di questo periodo, quelli, cioè,
con Amendola e con Prezzolini.
69
Oltre a ripubblicare tali carteggi, che in tal modo vengono presentati
nella loro successione logica e cronologica, in questa raccolta ne sono stati
aggiunti altri
~
come la lettera a Schiavi o, quelle di Anzilotti, di Mandol–
fo, ed anche di Lombardo Radice
-
in cui l'accento non viene posto soltanto
sulla crisi nei confronti della "Voce," quanto su elementi di carattere assai
piu profondo, che coinvolgono la problematica dell'intera personalità salve–
miniana.70
L'inserimento e poi il distacco di Salvemini dal movimento vociano, la
frattura, divenuta ormai insanabile, in seno al partito socialista, la crisi pro–
vocata dall'impresa tripolina e la polemica politica derivante dalle falsifica–
zioni opemte dalla stampa conservatrice: tutto ciò si ritrova nell'ultima parte
della raccolta, piu o meno ampiamente documentato. Come pure, emergono
alcuni degli elementi, ma non le motivazioni piu essenziali, che determinarono
in Salvemini la decisione di fandare
l"'
Unità": l'esigenza cioè, di agire con
forze politiche nuove e incorrotte, e che implicava
-
fra l'altro
-
una ma–
turata soluzione del problema meridionale:
"[' ...]
Non esiste oggi in Italia"
-
scriveva il 16 marzo 19.11ad Alessandro Schiavi
-
"un gruppo di forze
sociali e di idee, di cui io possa essere il rappresentante politico: perché quelli
che io intendo rappresentare, non sono elettori; e quelli che mi possono eleg–
gere, non mi eleggerebbero se io mi presentassi a loro senza equivoci, con
tutte le idee che reputo vere." E, piu avanti, cosf gli scriveva Lombardo Ra–
dice: "[.,.. ,]Quel che mi importa nella tua domanda è che tu pensi a disci–
plinare, con un preciso programma, un gruppo di giovani, in modo che il
suffragio universale coincida colla venuta al mondo di un partito.
[...] "
Pro–
prio uomini come Lombardo-Redice, Luzzato e Fortunato sostennero Sal-
6 7
Cfr.
in particolare Anna Kuliscioff a Salvemini, del 16 settembre 1910, al n. 271 e
le
altre
lettere della stessa, pubblicate
ai nn. 239, 246, 247, 255, 269.
68
Si veda, in particolare
La cultura italiana del '900 attraverso le riviste,
Vol. V,
L'"Uni–
tà"
•
"La Voce politica"
a cura
di F.
Golzio e A. Guerra: l'introduzione, a
pp.
13-17 e 45-49.
69
In E.
KiiHN AMENDOLA,
Vita
con Giovanni Amendola,
Firenze
1960; G.
PREZZOLTNI,
L'Italia a Tripoli,
in "Il Borghese" del 4
e
11 settembre 1958; Io.,
Il tempo della Voce,
Mi–
lano 1960.
I
7
°
Cfr.
le lettere pubblicate ai nn. 283, 294, 315, 31.6 e 321.
XXVII
BibliotecaGino Bianco
















