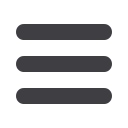

R I N A S C I T A
Cronache del mese
(Dal 10 settembre al 20 ottobre)
Situazione internazionale
1,
I T A L I A :
F i rma dell'accordo per Trieste. — 2.
EUROPA OCC I DEN –
T A L E :
Ed e n propone u n a soluzione di ricambio al la C E D -
Accordi di Londra - L'Uni one Soviet ica per l a ripresa del la
Conferenza di Ber l ino. — 3,
GERMAN I A :
Adenauer I n di ff icol tà -
El ez i on i ne l la R D T ,
—
4 . GRAN BRETAGNA:
Congressi labur i s ta e
conservatore - I portual i i n sciopero. — 5. ONU : L ' UR S S accetta
11 plano franco-br i tanni co per
11
disarmo.
—
6.
SCANDINAVIA:
E l e –
z ioni i n Svezia - Nuovo governo i n F i n l and i a - L a Dan imarca e
l a Norvegia non aderiscono al patto di Bruxel les .
—
v.
AU S TR I A :
Successo socialdemocratico nel le elezioni provincial i . — 8.
B A L –
CAN I :
Col loqui turco-germani c i a Bonn . — 9.
MEDIO O R I E N T E :
Cruent e repressioni ne l l ' I ran - Si tuazione cr i t i ca i n L i b i a -
L'Eg i t to firma l'accordo per Suez - A t t i v i t à diplomat ica del Pr e –
mi er iracheno - I par t i t i progressisti s i affermano nelle elezioni
I n S i r i a - Inc i dent i i n Gi ordan i a .
—
10.
I ND I A :
Viaggio di Nehru
I n B i rman i a , I n Indoc ina e i n C i n a - L a Fr an c i a rest i tuisce gl i
ul t imi possediment i a l l ' Indi a . — 11.
V I E T N AM :
Grave cr i s i nel
Sud - Ho Ch i Mi n ent ra i n Hanoi . — 12.
G I AP PONE :
Molotov per
un trat tato di pace nipponico - Viaggio di Yosh i da I n Europa . —
13.
C I N A :
F i rma di nuov i accordi russo-cines i - I l governo di
Pechino protesta a l l 'ONU contro gl i a t t acch i di Cl ang K a l -
scek.
—
14. AMER I CA LAT I NA :
Stato d'assedio i n Ci l e - El ez i on i
i n Bras i le, nel l 'Honduras e ne l Gua t ema l a .
i- — Dopo anni di aspre polemiche e di logorante ten–
sione, il 5 ottobre, il governo italiano e quello jugoslavo
decidevano di porre fine alla controversia per Trieste sot–
toscrivendo a Londra un cosiddetto « memorandum d'in–
tesa ». Con questo accordo veniva praticamente compiuta
la spartizione del TI /T, anche se formalmente si mante–
neva la situazione di diritto originata dal trattato di pace,
per quanto si riferisce alla sovranità dell'ONU su quel
territorio.
L'accordo, faticosamente raggiùnto, non veniva accolto
con lo stesso favore nei due paesi direttamente interessati.
Per la Jugoslavia esso costituiva, infatti, come riconosceva
il presidente Tito, il 6 ottobre, in un discorso a Serajevo,
una soluzione soddisfacente. Per l'Italia, invece, come
ebbe a dichiarare lo stesso governo, rappresentava un
doloroso sacrificio. E doloroso particolarmente risultò quel
sacrificio ai nuovi profughi che venivano ad aggiungersi
a quelli istriani e, in generale, all'opinione pubblica ita–
liana, la quale, pur riconoscendo la necessità di una solu–
zione concordata, ravvisò in quel compromesso la peg–
giore sistemazione della controversia. Pertanto al Senato
prima (8 ottobre) e alla Camera in seguito ( IQ ottobre),
il governo riusciva a fatica, ponendo la questione di fidu–
cia, a far approvare, con il più esiguo scarto di voti, quel
memorandum d'intesa che consacrava l'impopolare solu–
zione del problema triestino.
Sul piano internazionale, invece, l'accordo italo-jugoslavo,
in quanto raggiunto mediante negoziati diretti tra le due
parti interessate, veniva giudicato dall'Unione Sovietica,
il 13 ottobre, quale elemento atto a contribuire alla ridu–
zione della tensione in quel settore europeo.
2. — Primo fra tutti i governi delle potenze occìdeutali
a riaversi dal colpo causato dal crollo della CED è stato,
quello di Londra il quale, dopo aver proposto di con–
vocare nna conferenza per cercare una soluzione di ri–
cambio, si è prodigato, con il suo ministro degli Esteri,
a convincere gli altri ex firmatari del trattato bocciato
ad accettare il piano del
Foreign
Office.
Questo piano,
illustrato personalmente da Eden ai tre ministri del Be-
nelux l 'u settembre a Bruxelles, poi al cancelliere Ade–
nauer il 12 settembre a Bonn, quindi a Sceiba e a Piccioni
il 13 settembre a Roma ed infine a Mendès-France il 15 e
il 16 settembre a Parigi, consisteva, come si venne subito
a sapere, nella riesumazione del trattato di Bruxelles del
1948, opportunamente aggiornato per poter assolvere alla
funzione un tempo attribuita alla CED. In sostanza la
Gran Bretagna suggeriva l'inclusione della Repubblica
federale tedesca sia nella NATO (per sviluppare la potenza
militare iu armonia con la strategia dell'Occidente), sia,
come si è detto, nel quadro dell
1
* Unione occidentale »
di Bruxelles (per limitare e controllare lo sviluppo del
potenziale militare, in modo da non compromettere l'equi–
librio in Occidente a danno della Francia).
Accettata in linea di massima dagli ex aderenti alla CED
la proposta britannica, non restava che da convincere gli
Stati Uniti. Ma anche questo ultimo ostacolo veniva su–
perato il 18 settembre dal segretario di Stato americano
Foster Dulles che, giunto precipitosamente in Europa, si
incontrava con Adenauer a Bonn e subito dopo con Eden
e Churchill a Londra. Nel corso di questi colloqui, il rap–
presentante degli Stati Uniti doveva persuadersi che la
polìtica oltranzista aveva oramai fatto il suo tempo e che,
dopo il fallimento della CED, non si poteva più insistere
in un atteggiamento di sfida verso l'opinione pubblica
europea senza provocare una inevitabile rottura nello schie–
ramento atlantico. Perciò, con evindente amarezza, il se–
gretario di Stato americano si vedeva costretto ad acco–
darsi all'iniziativa britannica.
La Conferenza di Londra non faceva quindi che con–
sacrare in un documento finale quell'accordo di principio,
che già poteva dirsi acquisito sin da quando il piano pro–
posto da Eden era stato da tutti accettato.
Naturalmente, per sgombrare il terreno dai non pochi
intralci, il governo britannico doveva in primo luogo
tener conto di una delle obiezioni sollevate dal Parlamento
francese. Occorreva cioè assicurare alla Francia la pre–
senza e la permanenza delle quattro divisioni inglesi sul
continente europeo, allo scopo di fare da contrappeso alla
superiorità militare tedesca, nel quadro del nuovo patto
sostitutivo della CED. Ma per poter giocare questa carta
decisiva agli effetti dell'esito della Conferenza di Londra,
10 stesso Eden aveva bisogno di poter impegnare la Gran
Bretagna anche nell'eventualità di una caduta dell'attuale
governo conservatore, in seguito alle prossime elezioni.
Occorreva, perciò, ìl consenso dei laburisti. Ora, proprio
in quei giorni si riuniva a Scarborough il Congresso del
« Labour Party
che doveva pronunciarsi sul problema
del riarmo tedesco. E quel congresso, grazie all'abilità ma–
novriera del
leader
del partito, Attlee, approvava, il 28 set–
tembre, una risoluzione con la quale si accettava, sia pur
con la più esigua maggioranza (3.270.000 voti favorevoli
contro 3.022.000 contrari) e con la formulazione più vaga,
11
principio di un riarmo tedesco.
Superata questa difficoltà, il ministro Eden poteva, nel
momento più critico della conferenza apertasi a Londra
il 28 settembre, annunciare la « storica decisione » di non
ritirare le forze armate attualmente di stanza in Germa–
nia, fino al 1998 se non con il consenso della maggioranza
dei paesi aderenti al patto di Bruxelles, .esteso alla Ger–
mania e all'Italia. La Conferenza di Londra, dopo una
serie di alterne vicende e di drammatici contrasti, poteva
così concludersi ìl 3 ottobre, riaffermando, in un atto finale
in sei punti le basi del nuovo accordo raggiunto tra gli
occidentali. Tali basi sono : 1) per quanto si riferisce alla
Germania, le tre potenze occidentali decidono di porre
termine al regime di occupazione e di sopprimere l'Alta
Commissione alleata esistente nella Repubblica federale
tedesca; 2) per quanto si riferisce al patto di Bruxelles,
si decide che esso venga rafforzato ed esteso con la parte–
cipazione della Germania occidentale e dell'Italia; 3) per
quanto si riferisce alle due potenze anglo-sassoni, l'In–
ghilterra si impegna in modo molto elastico a non ritirare
le quattro divisioni di stanza in Europa, e gli Stati Uniti
a continuare i loro aiuti militari; 4) per quanto si riferisce
al patto Atlantico, si decide l'ammissione della Germania
nella NATO; 5) "per quanto si riferisce alla politica del
governo di Bonn, si accetta come garanzia sufficiente la
dichiarazione unilaterale del cancelliere Adenauer di non
ricorrere alla forza per unificare la Germania o per ret–
tificarne le frontiere; 6) infine, per quanto si riferisce alla
procedura, si stabilisce di convocare un'altra conferenza
per il
22
ottobre a Parigi, allo scopo di fissare in una serie
di protocolli, i principi dell'accordo raggiunto.
Subito dopo la Conferenza di Londra, Mendès-France
presentava all'Assemblea nazionale francese i risultati con–
seguiti, chiedendo il consenso del Parlamento a proseguire
sulla via intrapresa. Ma di fronte alla resistenza incon–
trata, il presidente del Consiglio si vedeva costretto a
porre la questione di fiducia, dando contemporaneamente
assicurazione della sua buona volontà di persistere nella
ricerca di una intesa con l'Unione Sovietica per risolvere
attraverso i negoziati, la questione
tedesca
e quella della
sicurezza europea. Con un margine inferiore al consueto,
il governo francese il 12 ottobre otteneva quella maggio-
















