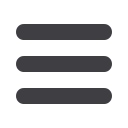

R I N A S C I T A
7
°5
foiosamente, per evitare ulteriori scandali. L'altro epi–
sodio si verificava il 30, il giorno stesso in cui la Camera
doveva votare, e consisteva nella diffusione della sensa–
zionale notizia dì un improvviso colpo di scena nelle in–
dagini sul caso Montesi per cui il vero responsabile della
morte di Wilma doveva ritenersi lo zio di questa: alla
divulgazione di tale voce, il cui effetto sui deputati della
maggioranza-è intuitivo, si prestava con eccezionale ala–
crità il solito on. Saragat.
2. — Con il mese di ottobre l'interesse dell'opinione pub–
blica veniva spostato dalla politica interna alla politica
estera. Al centro dell'attenzione generale subentrava an–
cora una volta la questione giuliana che, quasi d'improv–
viso dopo le lungaggini e i rinvìi di tutte le precedenti
promesse e trattative, veniva finalmente riprospettata in
termini conclusivi. Le prime notizie sull'ultimazione dei
negoziati fra i governi di Londra, Washington, Belgrado
e Roma si avevano il 29 settembre da fonte americana :
successivamente, il 3 ottobre, il ministro Martino reduce
dalla Conferenza dei nove informava il governo sui parti–
colari dell'accordo raggiunto e il 5 il governo autoriz–
zava il nostro ambasciatore a Londra a siglare tale ac–
cordo e ne dava ufficiale comunicazione al Senato, in aper–
tura del dibattito sugli Esteri.
Per tale accordo, al fine di evitare ogni ratifica parla–
mentare, si era scartata la forma di un regolare trattato
per ricorrere a quella, piuttosto ambigua, di un « memo–
randum d'intesa ». In base a questo documento veniva sta–
bilito che Je truppe anglo-americane di occupazione nella
Zona A sarebbero state ritirate e detta zona, salvo alcuni
ulteriori ritocchi di confine in favore della Jugoslavia,
passava sotto amministrazione italiana.
Questo compromesso — che portava in pratica alla spar–
tizione definitiva del T . L , T . e alla conseguente rinuncia
dei diritti italiani su tutta la zona B — appariva subito
come U peggiore di tutti gli accordi di cui s'era discusso
in passato e dettato esclusivamente dalla premura di
compiacere agli anglo-americani nel loro desiderio di to–
gliere dì mezzo un motivo d'attrito nell'ambito dello
schieramento occidentale.
Consapevole della propria capitolazione, il governo ten–
tava di reagire, prima di tutto, asserendo che l'accordo
non aveva carattere definitivo (il che trovava piena smen–
tita nelle dichiarazioni e nei commenti di stampa di Lon–
dra e di Washington) e, poi, mobilitando la propria mac–
china propagandistica per sfruttare al massimo l'inevita–
bile emozione che « il ritorno di Trieste all'Italia » pro–
vocava in tutti ì cittadini. Inoltre, precorrendo qualsiasi
voto del Parlamento, procedeva senz'altro agli atti ine–
renti al trapasso dei poteri (che doveva concretarsi il
25 ottobre) e impegnava il prestigio del Presidente della
Repubblica presentandogli il testo dell'accordo di Londra
prima ancora di averlo sottoposto alle due Camere.
Del disagio creato da quest'ultima scorrettezza si rendeva
interprete, nel corso del dibattito al Senato svoltosi fra
il 6 e l'8, il senatore liberale Jannaccone con un severo
intervento che suscitava l'irata reazione di Sceiba e aveva
larga eco sulla stampa. La triste conclusione della que–
stione giuliana e il generale fallimento della politica estera
governativa venivano, inoltre, denunciati da numerosi
oratori dell'opposizione di destra e di sinistra, sicché al–
l'atto del voto la spartizione del T . L . T . era approvata
con soli 122 * sì * (metà del Senato) contro 8g « no »,
mentre Ì monarchici abbandonavano l'aula * per protesta »,
in pratica per favorire il governo.
Più interessante e vivace fu il dibattito che segui alla
Camera dal 12 al 20. In primo luogo esso si estese con mag–
gior respiro, oltre la questione giuliana, al desolante pa–
norama della politica estera governativa ed atlantica' alla
luce del fallimento della C.E-D. e degli altri clamorosi
avvenimenti internazionali degli ultimi mesi. In secondo
luogo fu riscontrato come il ministro Martino (che nel
dibattito senatoriale era stato sostituito da Sceiba) usasse
un linguaggio assai più cauto e, potrebbe dirsi, riservato
rispetto ai furori atlantici tradizionali dei suoi colleghi.
Infine, accanto ai molteplici interventi critici degli ora–
tori d'opposizione, si registrarono due discorsi dei de
Melloni e Folchì assai indicativi dello stato d'animo di
una parte della maggioranza, oramai sfiduciata e perplessa
verso gli schemi obbligati della politica atlantica e seria–
mente preoccupata delle prospettive di riarmo della Ger–
mania occidentale aperte dalla sua più recente evoluzione.
Ciò non pertanto il governo otteneva ancora una volta
l'assenso della sua parte (alla Camera votarono contn»
anche i monarchici), in una votazione che si venne a
svolgere in condizioni affatto particolari, come riferiamo
subito appresso.
3. — Secondo un'oramai inveterata consuetudine, la
D. C. aveva deciso infatti di rimontare l'impopolarità de–
terminata dagli ultimi avvenimenti (e in particolare dallo
scandalo connesso all'affare Montesi) per la via dell'an–
ticomunismo, visto ancora una volta soprattutto come di–
versivo attraverso il quale allarmare, eccitare e frastor–
nare l'opinione pubblica.
Il grosso dell'offensiva aveva inizio ai primi di otto–
bre con l'affissione — avvenuta sotto la protezione della
polizia — di migliaia di manifesti di volgare denigra–
zione di alcuni esponenti comunisti (accusati, fra l'altro,
di essere stati spie dell'O V.R.A.), la cui paternità era
attribuita alla fantomatica organizzazione maccartista in
Italia, * Pace e Libertà ». L'intento provocatorio dì tali
manifesti era trasparente, cosi come era intuitivo che
governo e D. C. ne fossero i veri ispiratori e in ogni
caso, i beneficiari. La preordinazione della campagna tro–
vava d'altro canto conferma nel modo sollecito con cui
le calunnie di « Pace e Libertà 0 venivano raccolte e am–
pliate da tutta la stampa governativa in base evidente–
mente ad una precisa parola d'ordine: bisogna nella quale
si distingueva particolarmente l'organo della socialdemo–
crazia.
Ma era nella seduta della Camera del 19 che la pro–
vocazione doveva assumere corpo attraverso un intervento
del democristiano di destra Togni. Questi raccogliendo le
sanguinose calunnie di « Pace e Libertà » determinava,
spalleggiato dai deputati monarchici e missini, violenti e
ripetuti tafferugli nell'aula, dove i rappresentanti social-
comunisti erano insorti, scontrandosi con gli avversari
dell'estrema destra. La tumultuosa seduta, che si pro–
traeva fino alle 3 del mattino prima che si arrivasse alla
votazione del bilancio degli Èsteri, dava naturalmente
pretesto alla stampa governativa per rinfocolare, capo–
volgendo le responsabilità, la massiccia offensiva antico–
munista in corso, imperniandola, stavolta, su una pretesa
difesa del Parlamento dalle violenze socialcomuniste.
4, — Quest'ultimo episodio, rapportato nel quadro dell'at–
tività dei partiti, assumeva, per jdtro, particolare signifi–
cato politico denunciando per la prima volta in modo
cosi aperto e, diremo, organico, la collusione fra destra
de rappresentata da Togni e ì suoi amici e la destra
monarchico-fascista. Si è osservato, infatti, in proposito
come, anche a giudicare dagli atteggiamenti della stampa
interessata, l*« operazione Togni», oltre ad inserirsi nel
quadro della campagna anticomunista ordita dalla D. C ,
veniva a trar pretesto da essa campagna per puntare sul
più ambizioso obiettivo dì un mutamento di governo o,
per lo meno di una stipulazione d'alleanza fra tutte le
forze anticomuniste, posto che la D. C. s'è mostrata fino
ad ora incapace di debellare il comunismo.
Particolarmente infelice è divenuta in questo perioda
la situazione del P.S.D.I. (e in genere dei partiti laici
minori che sono stati investiti in pieno dal discredito
della D. C. senza aver la capacità di distinguere le respon–
sabilità). Come si è accennato in precedenza, le stupefa–
centi prestazioni giornalistiche o verbali di Saragat hanno
contribuito ad aggravare lo sfacelo della socialdemocra–
zia che non ha più una politica autonoma (rispetto
n
quella de), anche se un comunicato della Direzione del
7 ottobre denunciava platonicamente la serie di mancate
realizzazioni da parte del governo, quasi che il P.S.D.I.
non ne facesse parte.
L'attività dei partiti di sinistra si è riflessa in tutta la
vita politica e parlamentare di questo periodo come per
implicito è già riferito, specie attraverso gli interventi dei
loro
leaders
e in particolare, per la posizione del P.C.I.,
t discorsi di Togliatti del 12 settembre a Ravenna e del
2g settembre alla Camera sulla politica interna, la sua
intervista
all'Unità
del 19 sulla politica estera, e i comu-
















