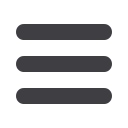

7
o
4
R I N A S C I T A
dra Huang Hsiang, dalla partenza per la Cina di un'altra
delegazione britannica (5 ottobre) e di una giapponese
composta da 25 deputati (26 settembre).
Mentre andava cosi normalizzandosi la situazione in Ci–
na, nei giorni l i , 12 e 13 settembre aerei di Ciang Kat-scek
compivano una serie di incursioni bombardando Amoy e
la costa del Fukien. Gli aerei venivano abbattuti dalla con–
traerea della Repubblica popolare. Il 10 ottobre Ciu En
Lai ricorreva all'ONU contro l'aggressione americana a
Formosa e il 15 ottobre Viscinski chiedeva al Segretario
generale "delFONU di includere all'ordine del giorno del–
l'Assemblea la questione degli attacchi del Kuomintang,
condotti con l'aiuto statunitense, contro la Cina Popolare.
14. — Una gravissima misura antidemocratica veniva
presa dal presidente della Repubblica cilena, Ibanez, con
la proclamazione, il 20 settembre, dello stato d'assedio in
tutto il paese per sei mesi, al fine di stroncare lo sciopero
degli operai delle miniere di rame, in atto dal 18 agosto
per un aumento salariale del 75 %. Dopo aver inutilmente
militarizzato le miniere, cui rispondeva uno sciopero gè-
nerale di solidarietà il 15 settembre, Ibanez attuava l'estre¬
ma misura scavalcando il parere del Senato, e dimostrando
così di voler istaurare una politica di forza, non solo per
colpire le organizzazioni dei lavoratori e dei comunisti,
fuori legge dal 1948, ma anche per assicurarsi i poteri
straordinari contro la stessa volontà del Parlamento,
.
In Brasile, dove il 20 settembre il presidente Cafè faceva
arrestare centinaia di dirigenti e militanti sindacali in
occasione dello sciopero dei trasporti a Rio de Janeiro,
il 3 ottobre avevano luogo le elezioni per il rinnovo delle
due Camere federali e delle amministrazioni regionali.
Dagli scrutini risultava una maggioranza a favore dei par–
titi governativi, ma risultava anche che il 40
%
degli
elettori si era astenuto, manifestando così la sua opposi–
zione al nuovo regime.
Il 10 ottobre si svolgevano contemporaneamente le ele–
zioni nel Guatemala e nell'Honduras per designare i mem–
bri dell'Assemblea legislativa e il presidente della Repub–
blica. Nel Guatemala stravinceva sfacciatamente Castillo
Armas in quanto, proibiti i partiti politici, le liste dei
candidati erano solo di tre raggruppamenti filo-governativi.
Nell'Honduras non poteva essere nominato il presidente
della Repubblica, perchè nessuno dei tre candidati, in
testa ai quali risultava il liberale d'opposizione Ramon
Morales, raggiungeva la maggioranza prescritta dalla Co–
stituzione. •
Po l i t i c a i t a l i ana
1. Sv i luppi dell'afTare Montesi , rimpasto mini steriale per le
dimissioni di Pi cc ioni e dibatt i to sul la pol itica Int erna alle
Camere . — 2. Spart izione del T . L . T . e dibat t i to parlamentare
di pol itica estera. — 3. Nuova offensiva ant i comuni s ta , come
diversivo al la cr i s i pol i t ica e morale del quadripart i to. — 4. Vi t a
del par t i t i : sfacelo del F . S . D . I . , t ravàg l i o d . c , col lusione fra
destra clericale e destra monarchico- fasci sta.
Nelle giornate del 16 e 17 settembre si avevano scam–
bi di vedute, in merito allo scandalo Montesi, fra i mag–
giori esponenti de e, secondo alcune voci, il segretario
della D. C. Fanfani avrebbe espressa a Sceiba l'impossibi–
lità per il partito di continuare a solidarizzare con il gover–
no nella sua difesa ad oltranza di Piccioni, stante le con–
dizioni d'animo dell'opinione pubblica; contemporanea–
mente venivano fatte circolare voci secondo cui Piccioni
avrebbe chiesto un periodo di congedo « per poter meglio
difendere il figlio ». Il 18 sera, infine, la presidenza del
Consiglio comunicava che Piccioni si era definitivamente
dimesso. Non passavano 48 ore che si apprendeva come la
Procura generale avesse riconsegnato gli atti al giudice
istruttore, sbloccando in tal modo il corso della giustizia,
e il giorno dopo, il 21, venivano emessi i mandati di cat–
tura nei confronti di Piero Piccioni e di Ugo Montagna e
il mandato di comparizione per l'ex questore di Roma
Pòlito.
Di fronte a questo precipitare degli avvenimenti, la pro–
paganda governativa era costretta ad arretrare pauro–
samente, fino a tentare di rovesciare ogni responsabilità
sull'ex ministro Piccioni, accreditando la voce che egli
aveva sorpreso la buona fede dei suoi colleghi; intanto,
sempre il 21, si riuniva il Consiglio dei ministri per esa–
minare la situazione, specie in vista dell'imminente ria–
pertura delle Camere, e Sceiba sosteneva la tesi che il
governo non avrebbe dovuto accettare un dibattito sulla
« questione morale » : senonchè — indizio del grado di
turbamento degli stessi ambienti governativi — egli ri–
maneva in minoranza in seno al Consiglio stesso, il quale
decideva cosi di affrontare la discussione politica alle
Camere.
L'occasione tecnica — per così dire — di tale discus–
sione era data dal rimpasto ministeriale che le dimissioni di
Piccioni avevano comportato : il giorno 18, infatti, dopo
48 ore di consultazioni affannose e semiclandestine, Sceiba
aveva deciso di nominare ministro degli Esteri, al posto
di Piccioni, il liberale Martino, ministro dell'Istruzione
e, in sostituzione di questi, il noto clericale Ermini.
A parte ciò, era tutta la posizione politica e, più an–
cora, morale del ministero che formava oggetto di allar–
mata attenzione — e di severo giudizio — da parte del–
l'opinione pubblica (proprio in quei giorni, il 23, si aveva
la conferma, attraverso una sentenza della magistratura
nei riguardi del capitano Perenze, che il governo aveva
asserito il falso nel riferire a suo tempo al Parlamento le
circostanze dell'uccisione del bandito Giuliano). Una vera
e propria crisi di coscienza s'era diffusa anche in seno
alla maggioranza al punto che era legittimo prevedere
che il governo non avrebbe ottenuto la fiducia negli im–
minenti dibattiti parlamentari. Voci attendibili facevano
ritenere che lo stesso Fanfani considerasse giunto il mo–
mento di far mancare l'appoggio della propria corrente
al gabinetto Sceiba, oramai tanto screditato.
Bisogna dire che lo stesso discredito cui era giunto ha
salvato, viceversa il ministero Scelba-Saragat : e ciò nel
senso che, da parte degli interessati, s'è potuta svolgere
una controffensiva psicologica tendente a dimostrare che
la caduta del governo su una questione morale avrebbe
travolto in un giudizio di riprovazione l'intiera classe diri–
gente clericale e quadripartita. Si sa in particolare che
il 22, mentre il dibattito aveva inizio al Senato, si svolgeva
un drammatico incontro fra Sceiba e Fanfani, nel corso
del quale presumibilmente il primo persuadeva il segre–
tario della D. C. a tener conto delle considerazioni di cui
sopra. A questa sorta di ricatto generale, doveva poi ag–
giungersene nei giorni successivi uno personale, di cui
si faceva voleuterosamente strumento Saragat e di cui
riferiremo appresso. Nell'insieme, si aveva la sensazione
che il facinoroso
leader
di Iniziativa democratica fosse
sottoposto a una dura e minacciosa pressione che lo co–
stringesse a un repentino mutamento di programma. Sta
di fatto che il 23 egli dava ai suoi amici il segnale della
ritirata con una dichiarazione in cui, mentre si assicurava
che « la D- C. incoraggerà ogni assennato ed obiettivo
sforzo diretto a eliminare dalla vita pubblica costumi,
usanze, facilonerie riprovevoli », d'altro canto si precisava
che « la D. C, non si presterà a giuochi di speculazione
politica, nè commetterà debolezze capaci di compromettere
la stabilità degli istituti, la collaborazione fra le forze
democratiche, la continuità d'azione del governo».
Grazie a tale forzata garanzia, il ' governo poteva af–
frontare il dibattito, il 22 al Senato e il 28 alla Camera,
con buone speranze dì riuscire, da un lato a far respin–
gere la proposta di inchiesta parlamentare su tutto l'af–
fare Montesi avanzata dai socialisti e, dall'altro, a otte–
nere la stentata fiducia dei suoi.
D'altro canto, a conferma dell'insicurezza del governo
di ottenere la fiducia dagli stessi deputati della propria
parte, sta il fatto che il dibattito della Camera si è aperto
e chiuso sótto il segno di due clamorosi episodi che hanno
avuto entrambi per protagonista Fon. Saragat. I l primo
è consistito in un articolo del
leader
socialdemocratico
sulla
Giustizia
del 28 nel quale si chiamava minacciosa–
mente in causa chi aveva per primo messo in giro il nome
di Piero Piccioni come probabile responsabile della morte
di Wilma Montesi : nel che tutti gli ambienti politici e
giornalistici ravvisavano, più che un attacco, un vero
e proprio ricatto nei confronti di Fanfani, cui generalmente
si fa risalire la paternità dì quella propalazione di voci.
E tanto ciò era vero che Fanfani, punto sul vivo, repli–
cava dando esca a una penosa polemica, chiusa poi fret-
















