
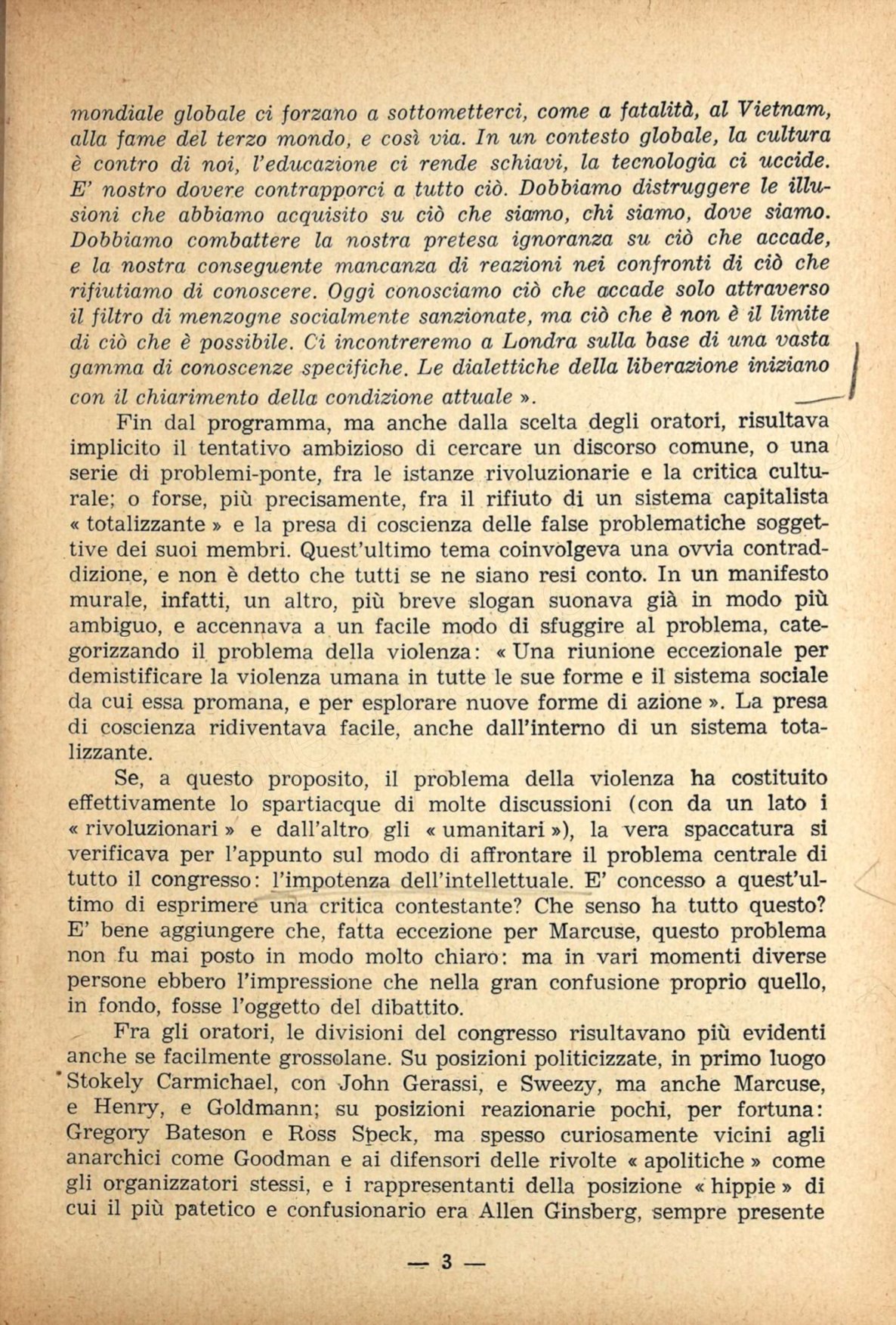
mondiale globale ci forzano a sottometterci, come a fatalità, al Vietnam,
alla fame del terzo mondo, e cosi via. I n un contesto globale, la cultura
è contro d i noi, l'educazione c i rende schiavi, l a tecnologia c i uccide.
E' nostro dovere contrapporci a tutto ciò. Dobbiamo distruggere le i l lu-
sioni che abbiamo acquisito su ciò che siamo, ch i siamo, dove siamo.
Dobbiamo combattere l a nostra pretesa ignoranza su ciò che accade,
e la nostra conseguente mancanza d i reazioni nei confronti d i cid che
rifiutiamo d i conoscere. Oggi conosciamo ciò che accade solo attraverso
i l f i l tro di menzogne socialmente sanzionate, ma cid che è non è i l limite
di ciò che è possibile. Ci incontreremo a Londra sulla base di una vasta
gamma di conoscenze specifiche. Le dialettiche della liberazione iniziano
con i l chiarimento della condizione attuale ».
Fin dal programma, ma anche dalla scelta degli oratori, risultava
implicito i l tentativo ambizioso d i cercare un discorso comune, o una
serie d i problemi-ponte, f ra le istanze rivoluzionarie e la critica cultu-
rale; o forse, p i ù precisamente, f ra i l r i f iuto d i un sistema capitalista
«totalizzante » e la presa di coscienza delle false problematiche sogget-
tive dei suoi membri. Quest'ultimo tema coinvolgeva una ovvia contrad-
dizione,• e non è detto che tut t i se ne siano resi conto. I n un manifesto
murale, infat t i , un altro, p i ù breve slogan suonava già i n modo p i ù
ambiguo, e accennava a un facile modo d i sfuggire al problema, cate-
gorizzando i l. problema della violenza: « Una riunione eccezionale per
demistificare la violenza umana in tutte le sue forme e i i sistema sociale
da cui essa promana, e per esplorare nuove forme di azione ». La presa
di coscienza ridiventava facile, anche dall ' interno d i un sistema tota-
lizzante.
Se, a questo proposito, i l problema del la violenza ha cost i tui to
effettivamente l o spartiacque d i mol te discussioni (con da u n lato
« rivoluzionari » e dal l 'al tro g l i « umanitari »), l a •vera spaccatura s i
verificava per l'appunto sul modo di affrontare i l problema centrale di
tutto i l congresso: l'impotenza dell'intellettuale. E' concesso a quest'ul-
timo d i esprimere una critica contestante? Che senso ha tut to questo?
E' bene aggiungere che, fatta eccezione per Marcuse, questo problema
non f u mai posto i n modo molto chiaro: ma i n var i momenti diverse
persone ebbero l'impressione che nella gran confusione proprio quello,
in fondo, fosse l'oggetto del dibattito.
Fra g l i oratori, le divisioni del congresso risultavano più evidenti
anche se facilmente grossolane. Su posizioni politicizzate, in primo luogo
Stokely Carmichael, con John Gerassi, e Sweezy, ma anche Marcuse,
e Henry, e Goldmann; s u posizioni reazionarie pochi, pe r for tuna:
Gregory Bateson e Ftòss Sbeck, ma spesso curiosamente v i c i n i ag l i
anarchici come Goodman e ai difensori delle rivolte « apolitiche » come
gli organizzatori stessi, e i rappresentanti della posizione « hippie » d i
cui i l più patetico e confusionario era Al len Ginsberg, sempre presente
















