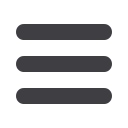

R I N A S C I T A
685
ad allora erano sembrati pentii estranei, straordinari,
provvisori di vita sarda, si allineano le forze più vive
della politica e della cultura di Sardegna: i l lutto
abbruna le bandiere di Tempio, dì Sassari, di Iglesias.
A Cagliari un grande comizio è promosso dall'Unione
dei radicali ; centinaia di telegrammi giùngono alla
Lega dei minatori di Buggerrù; all'insulto del mini–
stero degli Interni, che concede mille lire alle famiglie
dei caduti, risponde lo slancio delle sottoscrizioni pro–
mosse dal partito socialista e da quello radicale.
L'episodio intanto offre l'attesa occasione di «sco–
prire » i l saccheggio che le aziende a capitale conti–
nentale
0
straniero vanno operando indisturbate da
almeno un ventennio sulle ricchezze sarde e l'inumano
sfruttamento a cui vengono sottoposti i lavoratori sardi.
Le colonne dei giornali sardi si aprono alle prime
polemiche fra coloro che al capitale continentale vo–
gliono sia riconosciuto i l merito di aver industrializzato
risola e coloro che ritengono ciò sia avvenuto a troppo
caro prezzo e per vie non naturali, che hanno reso
inutile i l sacrificio del lavoro e dei giacimenti isolani.
La piattaforma dell'autonomia sarda non è ancora
formulata (Io sarà solo sul finire dèll 'altra guerra, verso
i l 1917), ma si sviluppa oramai vìvo i l dibattito che
tende a individuare l'esatto schieramento delle forze
sociali e politiche in Sardegna, e la più chiara con–
trapposizione degli interessi e nazionali e di classe : si
risente allora i l grido « foras is istranzos »; è un grido
intorno a cui si erano raccolti i sardi nel corso del
loro tentativo di rivoluzione democratico-borghese e
nazionale, quando i l 7 maggio del 1794 avevano accom–
pagnato alle navi nel porto di Cagliari tutti i piemon–
tesi residenti nell'Isola, compreso i l viceré dei Savoia.
La tematica si fa presente dunque, ma forse è ancora
presto perchè i sardì condividano consapevolmente i l
giudizio che un loro storico e deputato, i l Siotto-Pintor,
aveva pochi anni prima dato nella « Storia civile dei
popoli sardi», quando scriveva «er rammo tut t i», ' r i –
cordando quei novembre del 1847 in cui i sardi invia–
rono una delegazione a Torino perchè Carlo Alberto—
sbalordito e persino diffidente — accogliesse i voti dei
« nazionali » che chiedevano l'abolizione elei privilegi
e degli statuti sardi, sui quali avevano giurato quattro
monarchie per regnare in Sardegna dal 1297.
Ed è soprattutto ancora presto per la classe operaia
sarda, ancora in formazione si può dire (saranno le
lotte del 1904 e poi quelle del 1906 a darle consistenza
e quasi direi fisionomia permanente, recisa dai ri torni
alla terra e fatta collettività); e prestissimo è ancora
per i l movimento politico socialista, « sovversivo » in
Italia isolato in pochi gruppi cittadini a Cagliari, Tem–
pio, Iglesias, e alcuni altri centri minori, e che solo
nel 1S98 aveva potuto ascoltare la predicazione dì An–
drea Costa e dì Rinaldo Rigola.
In questo clima di crescente malumore e di solidarietà
dell'opinione pubblica in Sardegna, gl i operai delle
miniere sarde continuano la loro lotta: scioperi e ma–
nifestazioni compatti e quasi sempre violenti si accen–
dono un po' dovunque, anche se in forma discontinua
e nOn coordinata, nei centri estrattivi del Sulcis, da
Nebida a S. Giovanni a Ingurtosu; e così a fine anno
la neo costituita Associazione mineraria' sarda — i l
cartello di resistenza delle industrie minerarie eser–
centi in Sardegna — doveva cedere agli operai e con–
cedeva, insieme alla fornitura gratuita degli attrezzi,
all'assistenza malattìe e al nulla osta alla costituzione
di cooperativa di consumo, i l tanto atteso contratto
di lavoro.
Ma l'episodio di Buggerrù ha serie, profonde riper–
cussioni in' Italia.
I morti di Buggerrù inserirono la Sardegna violen–
temente nella vita nazionale : i l movimento di opi–
nione, che dalla solidarietà passò alla lotta aperta
contro i l governo in nome degli operai uccisi a Bug–
gerrù, fece compiere un concreto passo in avanti a
quella unificazione nazionale a cui la Sardegna era
rimasta estranea.
Sui continente infatti un'ondata di orrore solleva
l'indignazione delle masse operaie del Settentrione.
Interpellanze categoriche e vibrale sono presentate a
Giolitti dai deputati socialisti di Torino e dallo stesso
sindaco di Torino, sen. Frola: l'incandescenza della
situazione obbliga Giolitti a rispondere; e la risposta
— smentendo i più inabili e solleciti difensori d'ufficio
del governo e degli industriali — nega che sìa stato
mai dato l'ordine di far fuoco e rigetta ogni respon–
sabilità sul nervosismo dei soldati.
Al 15 settembre è convocata la direzione del Partito
socialista italiano: l'ala destra e parlamentare dei
partito socialista deve rispondere della mancata pre–
sentazione alla Camera dei deputati del progetto di
legge che vieti l'intervento della forza pubblica nei
conflitti di lavoro.
La direzione del partito socialista si sostituisce allora
alle sue rappresentanze parlamentari e indice uno
sciopero generale di protesta civile « tale da imporsi
— come scrive
VAvanti ì —
ai pubblici poteri».
Lo sciopero divampa in tutto i l territorio nazionale:
è i l primo sciopero nazionale politico, ed è una prova
di forza. Da Milano (dove viene ucciso un dimostrante
e sciolto i l comizio di protesta) a Roma, a Napoli, a
Forlì, ad Ancona e Venezia e Terni e cento altri paesi
si moltiplicano le manifestazioni: a Roma 10,000 per–
sone partecipano al comizio del Teatro Cossa; inci–
denti ripetuti e nuovi morti punteggiano la solleva–
zione del proletariato italiano; nel nome di Sardegna,
accompagnato ai sìmboli del lavoro e del socialismo,
si opera una preziosa alleanza fra i l Nord e i l Sud
della nazione.
Nei pr imi quattro giorni Io sciopero paralizza com–
pletamente l'apparato industriale italiano e ancora per
diversi giorni la ripresa del lavoro è soltanto parziale:
la situazione italiana è notevolmente esasperata.
I I giorno 16 non escono neppure i giornali: e la
stampa non può dare l'annuncio della nascita dell'ere–
de al trono, Umberto, i l re di maggio.
Si rinnovano presso i l governo gl i invi t i a riunire
i l Parlamento: Giolitti minaccia di sciogliere la Ca–
mera se non cesseranno le ripetute richieste a discu–
tere del nuovo eccidio.
E poiché la minaccia non sorte effetto, fa sciogliere
la Camera e indice nuovi comizi elettorali. I l voto
del 6 e del 13 novembre segna un nuovo passo in
avanti del partito socialista. Ma ancora una volta per
i particolari congegni elettorali, gl i aumentati suf–
fragi non impediscono che i l numero dei deputati
socialisti eletti alla Camera risulti lievemente dimi–
nuito (da 33 a 30).
Ciò è sufficiente perchè i l gruppo dei deputati rifor–
misti inìzi la polemica sulle ripercussioni che gl i scio–
peri del settembre avrebbero avuto sull'opinione pub–
blica.
Solo due anni dopo la nuova Camera aprirà i l di–
battito sui fatti di Buggerrù, e voterà con legge 19 lu–
glio 1906 la costituzione di una Commissione di In–
chiesta, Guidata dal sen. Parpaglia di Oristano, essa
verrà in Sardegna nel 1908 e presenterà le sue conclu–
sioni solo nel 1911, fra l'indifferenza generale, e senza
che alcun provvedimento ne sortisca.
ARMANDO CONGIU
















